Come i bambini prendono decisioni: psicoeconomia evolutiva e teoria dei giochi
Documento universitario sulla psicoeconomia evolutiva e la teoria dei giochi. Il Pdf esplora il processo decisionale nei bambini, analizzando modelli teorici come l'Utilità Attesa e la Teoria del Prospetto, e i fattori culturali e sociali che influenzano l'acquisizione dei concetti economici in psicologia.
See more14 Pages
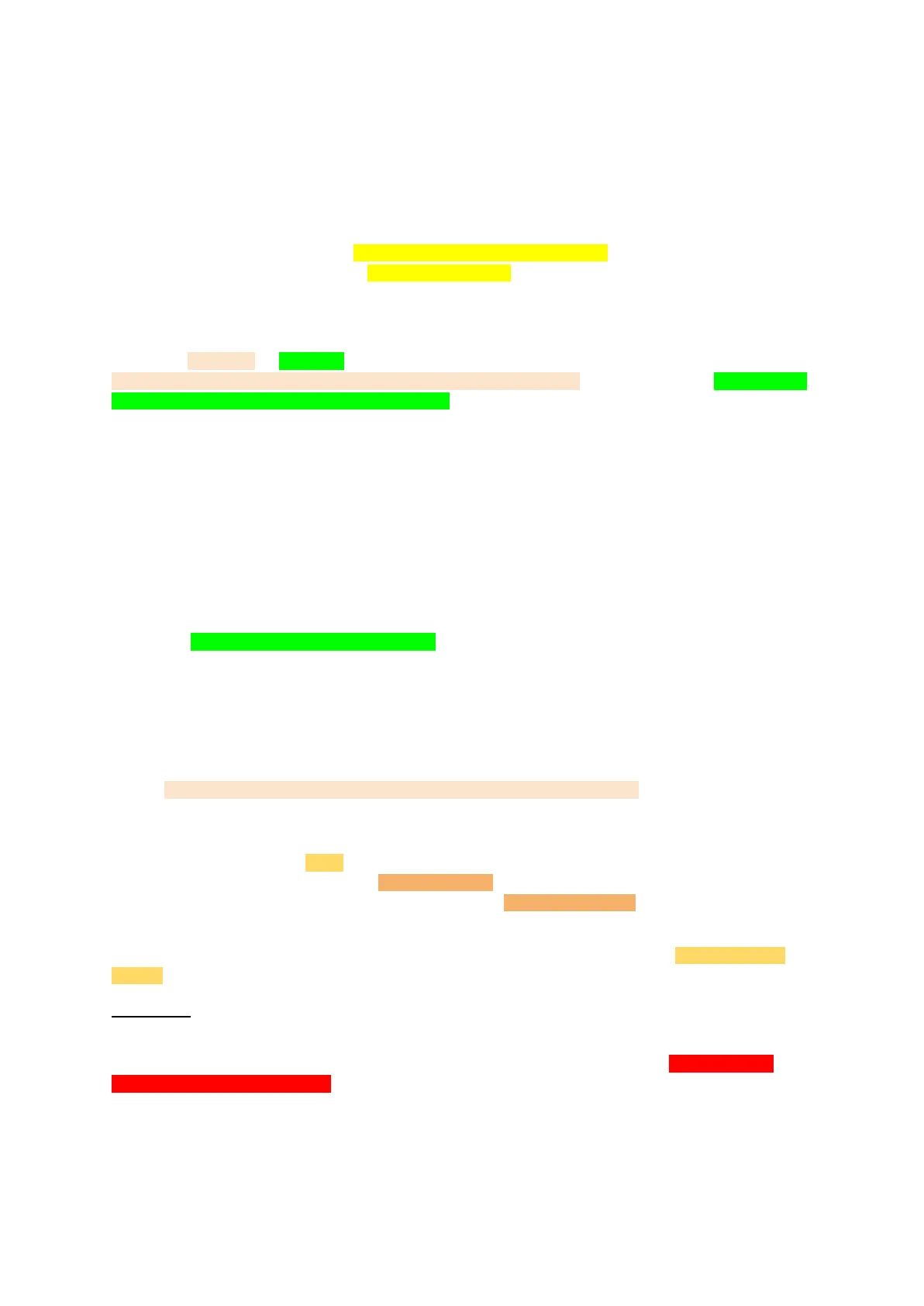
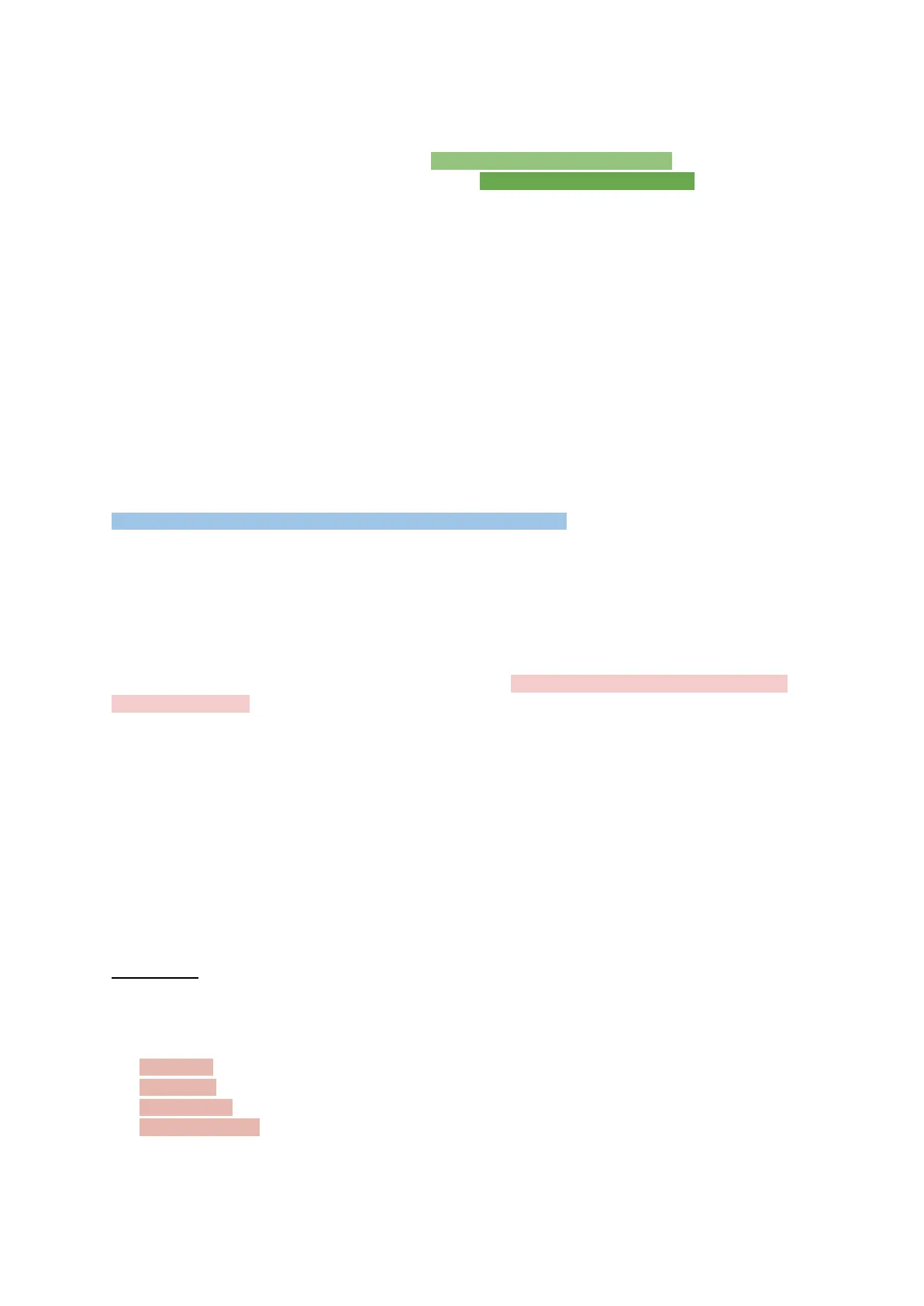
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Decision Making
Prendere decisioni significa scegliere l'opzione migliore tra quelle disponibili, spesso in condizioni di incertezza. Le decisioni possono essere semplici o complesse, a seconda della posta in gioco e della necessità di valutare vantaggi e svantaggi.
Psicologia ed economia nello studio delle decisioni
Nel tempo, psicologia ed economia hanno approcciato il tema in modo diverso: la prima attraverso la sperimentazione e lo studio dei processi mentali (approccio descrittivo), la seconda tramite modelli teorici di comportamento razionale (approccio normativo), Dalla seconda metà del Novecento, queste discipline si sono avvicinate, dando vita alla psicologia economica o economia cognitiva.
Decision-Making vs Problem-Solving
Il decision-making riguarda la scelta tra opzioni note, mentre il problem-solving implica la scoperta di nuove soluzioni. Entrambi i processi coinvolgono aspetti cognitivi e si sovrappongono nello studio del pensiero e del ragionamento.
Due modelli teorici principali
- Teoria dell'Utilità Attesa (approccio normativo)
Concepisce l'individuo come homo oeconomicus, razionale, che sceglie l'opzione con la massima utilità attesa, calcolata sulla base delle probabilità e dei possibili esiti. Postula vari assiomi (es. transitività, dominanza, invarianza) che definiscono la coerenza interna delle scelte. Tuttavia, assume condizioni ideali difficilmente riscontrabili nella realtà (es. conoscenza perfetta delle opzioni e conseguenze certe).
- Teoria del Prospetto (Kahneman e Tversky, approccio descrittivo)
Contrapposta alla precedente, descrive come gli individui prendano decisioni reali, spesso irrazionali, usando euristiche (scorciatoie mentali) per risparmiare tempo e sforzo cognitivo. Bounded - rationality. Introduce concetti come:
- Frame decisionale: il modo in cui una scelta è presentata influenza la decisione.
- Effetto certezza: si preferisce un guadagno sicuro a uno solo probabile, anche se più vantaggioso.
- Sunk cost: le decisioni presenti sono influenzate da investimenti passati.
Secondo questa teoria, l'individuo non cerca la scelta migliore in assoluto, ma quella "sufficientemente buona", in base al proprio punto di riferimento e contesto emotivo.
Conclusioni sui modelli decisionali
Le due teorie offrono modelli opposti di decisore (razionale vs razionalità limitata), ma entrambe sono fondamentali per comprendere la complessità del processo decisionale, che richiede l'integrazione di aspetti cognitivi, emotivi e sociali
Teoria dei Giochi e Decisione nell'Interazione
La Teoria dei Giochi studia matematicamente le situazioni di conflitto e cooperazione, analizzando come le decisioni di un individuo influenzano quelle degli altri. L'obiettivo è trovare un equilibrio (es. Nash) in cui nessuno ha vantaggio a cambiare strategia. È una teoria centrale per comprendere il comportamento razionale nelle interazioni sociali.
Classificazioni principali dei giochi
- Cooperativi vs non-cooperativi (con o senza accordi tra giocatori)
- Simmetrici vs asimmetrici (strategie dipendono o meno dai ruoli)
- A somma zero vs non a somma zero (guadagni e perdite bilanciate o meno)
- Simultanei vs sequenziali (azioni fatte insieme o una dopo l'altra)
- Informazione perfetta vs imperfetta (conoscenza completa o parziale delle mosse)
- Discreti vs continui, infinitamente lunghi, con uno o più giocatori
Giochi usati nello studio del decision-making (anche in età evolutiva)
- Ultimatum Game
Due giocatori: uno divide una somma, l'altro può accettare o rifiutare. Contrariamente alla Teoria dell'Utilità Attesa, le offerte spesso non sono minime e i riceventi rifiutano proposte "unfair". Ciò rivela l'importanza di emozioni, fairness, teoria della mente e contesto sociale/culturale. Il conflitto tra ragione (accettare per guadagnare) ed emozione (punire l'ingiustizia) attiva aree cerebrali diverse.
- Dictator Game
Simile all'Ultimatum Game, ma il ricevente non può rifiutare. Mostra quanto le scelte siano motivate da altruismo o egoismo, indipendentemente da conseguenze dirette.
- Trust Game
Il trustor investe denaro nel trustee, che può restituire o meno. Dimostra la propensione alla fiducia e reciprocità anche senza garanzie, influenzata da fattori psicologici, ormonali e semantici (es. chiamare l'altro "partner" o "avversario").
- Prisoner's Dilemma
Due giocatori decidono se cooperare o tradire senza conoscere la decisione dell'altro. Mostra come le scelte cooperative siano influenzate da fiducia, anche quando il tradimento offre un guadagno individuale maggiore.
Conclusioni sulla Teoria dei Giochi
La Teoria dei Giochi è un valido strumento per studiare la decisione sociale, grazie alla sua struttura semplice, applicabile anche ai bambini, e alla capacità di analizzare aspetti come:
- equità,
- fiducia,
- altruismo,
- cooperazione.
L'integrazione tra psicologia ed economia è fondamentale per comprendere a fondo i meccanismi decisionali in tutte le età.
Concetto di economia nell'infanzia - Il bambino e l'economia
- L'economia riguarda la gestione, acquisizione e distribuzione di beni e servizi, ma non implica sempre l'uso del denaro (es. baratto, scambi).
- I bambini fin da piccoli vivono situazioni economiche quotidiane (es. scambi tra pari, contrattazioni), imparando a comportarsi da agenti economici.
Acquisiscono conoscenze economiche attraverso
- Esperienza diretta;
- Osservazione e ascolto degli adulti;
- Sviluppo cognitivo naturale e curiosità verso il mondo.
Tre filoni di studio sull'acquisizione dei concetti economici
- Descrittivo: esplora la presenza di idee spontanee nei bambini sul mondo economico.
- Cognitivo-evolutivo: di ispirazione piagetiana, studia lo sviluppo a stadi delle concezioni economiche, considerate conoscenze dominio-specifiche.
- Socio-evolutivo: attribuisce un ruolo centrale alla socializzazione e ai contesti sociali nell'apprendimento economico del bambino.
Approccio cognitivo-evolutivo
- Si concentra sul "quando" emergono le concezioni economiche (più che sul come).
- Ha una visione adulto-centrica e individualista (bambino come costruttore solitario di conoscenza).
- Utilizza come metodo il colloquio clinico piagetiano.
Sviluppo della comprensione del denaro
- 5 anni: il denaro è visto come mezzo per ottenere oggetti, ma manca la comprensione del valore.
- 7-8 anni: iniziano a riconoscere differenze tra i valori delle monete e tra beni.
- 10-11 anni: acquisiscono una comprensione articolata di compravendita e attori coinvolti.
Modello di Danziger - sviluppo della comprensione economica
- 5/6 anni: eventi economici spiegati come volontà personale.
- 7/8 anni: spiegazioni fantasiose (es. re o governo che distribuiscono denaro).
- 9/10 anni: riconoscimento delle funzioni e obblighi degli attori economici.
- 11 anni: comprensione più completa del sistema economico, inclusa la nozione di profitto.
Il contributo di Jahoda
Secondo Jahoda, la conoscenza del mondo fisico e di quello sociale si sviluppa parallelamente, poiché entrambi sono sistemi complessi. Analizza due sistemi economici fondamentali:
- Sistema del profitto (relazione negoziante-cliente)
- Sistema del lavoro (relazione datore di lavoro-dipendente)
Tre livelli evolutivi
- 6-8 anni: il bambino ignora questi sistemi;
- 8-10 anni: ne riconosce l'esistenza ma non le connessioni;
- 11 anni: comprende e generalizza la nozione di profitto.
Approccio socio-evolutivo
- Critica l'approccio cognitivo-evolutivo per la sua visione adulto-centrica e individualistica.
- Considera il bambino un agente economico autonomo, attivo nel proprio mondo economico.
- Analizza la pratica della paghetta:
- In Italia non è molto diffusa ne consolidata.
- Due modalità:
- Paghetta guadagnata: data in cambio di compiti o lavoretti;
- Paghetta di diritto: data regolarmente, senza condizioni.
- Effetti:
I bambini che la ricevono tendono a essere più parsimoniosi.
- Le differenze socio-culturali (età, genere, classe sociale) influenzano modalità, frequenza e finalità educative.
Risparmio intenzionale: 3 condizioni
Per definire un comportamento come atto intenzionale di risparmio, devono esserci:
- Consapevolezza temporale: sapere che spendere ora esclude la possibilità di spendere dopo;
- Controllo dell'impulso: capacità di posticipare la gratificazione;
- Strategia pianificata: risparmiare con un piano realistico, non casuale.
Play Economy
- Simulazioni in ambienti ludici (es. banca, negozio, casa) per osservare i comportamenti economici.
- A 6 anni: i bambini sanno che risparmiare è giusto, ma non lo fanno strategicamente; spesso spendono o perdono il denaro.
- A 9-12 anni: usano la banca in modo strategico per:
- Proteggere il denaro;
- Accumulare risparmi per spese future o imprevisti.
Fattori che influenzano l'acquisizione dei concetti economici
Variabili culturali e sociali
- Tre filoni di ricerca:
- Studi transculturali: confronto tra paesi occidentali e non.
- Studi sul reddito familiare: influsso del livello economico.
- Spazio di vita: considerazione di variabili come la scuola frequentata o la professione dei genitori.
La cultura e la struttura sociale influenzano concetti come compravendita, profitto e uso del denaro. Già in età prescolare i bambini sviluppano idee di ricchezza e povertà, che si raffinano con l'età e si intrecciano con riflessioni etiche in adolescenza. Le differenze tra paesi (anche europei) riflettono storia, società, valori e non solo cultura in senso stretto.
Classe sociale e spazio di vita
- La scuola frequentata (pubblica o privata) e la possibilità di lavorare durante gli studi influenzano le concezioni economiche.
- A parità di reddito e professione genitoriale, lo spazio sociale frequentato può generare significative differenze.
Agenzie di socializzazione economica
- Famiglia:
- Influenza l'educazione al consumo e al denaro.
- Differenze nei modelli educativi e nel controllo dei media.
- Gruppo dei pari:
- Svolge un ruolo fondamentale nelle esperienze di scambio ludico.
- Rappresenta un ambiente autonomo per le prime esperienze economiche (es. baratti).
- Scuola:
- Dovrebbe avere un ruolo centrale nell'educazione economica.
- All'estero è più sviluppata, mentre in Italia è ancora trascurata.
Conclusione
I principali agenti della socializzazione economica sono:
- Famiglia: gestione del denaro e risparmio.
- Scuola: alfabetizzazione economica.