Oltre la Logica Formale: Pragmatica, Nuova Retorica, Nuova Dialettica
Documento di C. Meini su Oltre la Logica Formale: Pragmatica, Nuova Retorica, Nuova Dialettica. Il Pdf esplora l'evoluzione della teoria dell'argomentazione, dal modello del codice al ruolo del contesto, con il principio di cooperazione di Grice, per Filosofia a livello universitario.
See more22 Pages

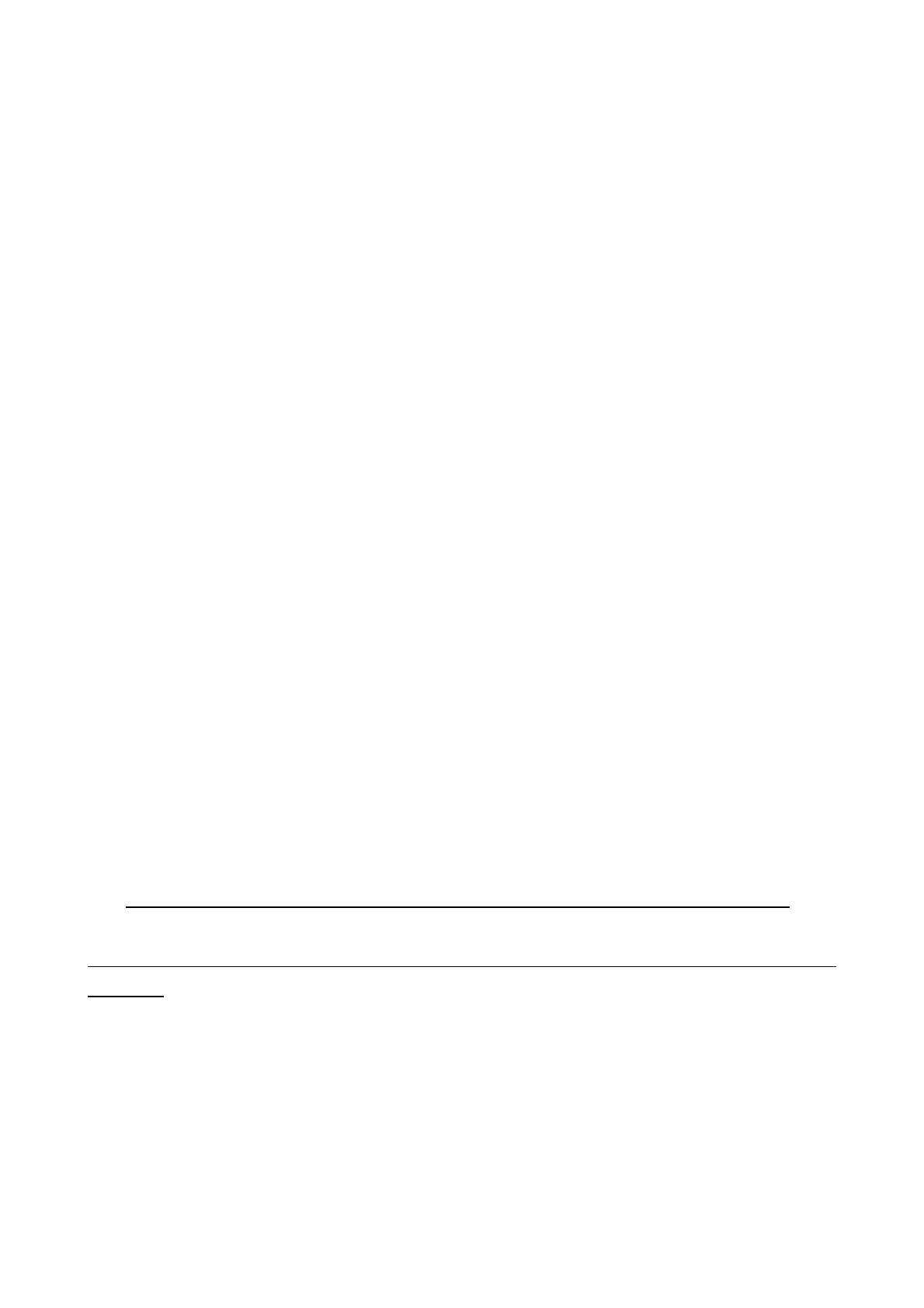
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Introduzione alla Teoria dell'Argomentazione
C. Meini CORSO DI FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE OLTRE LA LOGICA FORMALE: PRAGMATICA, NUOVA RETORICA, NUOVA DIALETTICA
Nella prima parte del corso, attraverso il testo di Varzi et al. abbiamo visto come la teoria dell'argomentazione sia stata intesa e "praticata" attraverso le strutture e i metodi della logica formale. Questo approccio, nato con Frege alla fine dell"800 e consolidato con la svolta positivistica della filosofia nella prima metà del '900, nell'ambito della filosofia analitica è stato assolutamente egemone fino agli anni '50 e ancora oggi è ampiamente studiato (come testimonia il testo di Varzi et al., che non è un testo di storia della logica ma un manuale di saperi e pratiche tuttora valide all'interno di quel paradigma).
A partire dagli anni '50, tuttavia, accade qualcosa di importante che, se inizialmente si pone in totale opposizione al paradigma precedente, trova generalmente oggi una soluzione nell'idea di "suddivisione del lavoro", ovvero nella consapevolezza che
- l'approccio logistico non è il solo approccio legittimo alla teoria dell'argomentazione e
- vi sono campi in cui è più utile/lecito/necessario servirsi di un paradigma piuttosto che dell'altro. Ma, inizialmente, il dibattito non è stato sempre così sereno.
Negli anni '50 del Novecento, infatti, nasce e si rafforza un movimento di forte opposizione all'egemonia della logica simbolica, giudicata inadeguata per valutare gli argomenti che si presentano nella vita quotidiana. In questa nuova prospettiva, che vedremo in dettaglio più avanti, prevale l'interesse per lo studio e la descrizione delle pratiche argomentative quotidiane, basate sull'incerto e su particolari contenuti, piuttosto che per forme (o schemi) di ragionamento astratte e valide a priori, indipendentemente dai contenuti che veicolano. L'argomentazione deve invece essere studiata - si sostiene - tenendo conto del contesto in cui ci si muove, in primo luogo dell'uditorio, e va analizzata con strumenti che si servono essenzialmente del linguaggio naturale. In altri termini, un argomento viene inteso come un evento storico espresso nel linguaggio naturale, avente natura dialogica e dialettica e sviluppato sempre all'interno di un contesto che ne influenza il significato. Si tratta inoltre, perlopiù, di un contesto "quotidiano", segnato dalla ragionevolezza (o, meglio, dalla ricerca di ragionevolezza) più che dalla ragione assoluta, "logica". Piuttosto che imporre sempre e comunque le regole logico-formali, si 1 di 18vogliono trovare le regole del dialogo ragionevole - non da ultimo, con l'obiettivo di intervenire con efficacia nel dibattito etico-giuridico-politico, difficilmente regimentabile attraverso regole formali. Si noti l'importanza filosofica della posta in gioco: anche i logici sono consapevoli che, per esempio, un argomento di bioetica sfugga a una riduzione completa a un formalismo logico; ritiene tuttavia che tale riduzione vada comunque, anche in questo caso, mantenuta come ideale da seguire quanto più precisamente possibile.
In questo nuovo contesto non sorprende che la svolta più o meno fortemente antilogicistica nella teoria dell'argomentazione faccia un significativo riferimento a una tradizione della filosofia del linguaggio di qualche anno precedente, che si era a suo tempo posta in contrapposizione con l'idea che il linguaggio potesse essere ricondotto a una forma logica perfetta e, come tale, potesse essere studiato senza considerare il ruolo del contesto: la teoria degli atti linguistici e la pragmatica che da essa deriva. La teoria degli atti linguistici, ispirata dalla riflessione del "secondo Wittgenstein" (ovvero, il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche), aveva evidenziato come il linguaggio (e, possiamo dire noi, la comunicazione più in generale) non serva solo per descrivere il mondo (come la logica ambisce a fare) ma sia esso stessa un agire: il linguaggio è l'uso, afferma Wittgenstein, mentre Austin pubblica un libro dal titolo significativo: Come fare cose con le parole. Con le parole, vi sostiene, non solo si descrive, ma si agisce, come quando proferisco enunciati performativi: "Vi dichiaro marito e moglie", "Ti prometto ecc.". La logica quindi, strumento per eccellenza per descrivere il modo (e non invece per dare ordini, porre domande, o agire), non basta.
Dalla teoria degli atti linguistici gemma la pragmatica, dalla quale partiremo per affrontare poi, più compiutamente, la "Nuova retorica".
Dal Modello del Codice al Ruolo del Contesto
La Pragmatica e il Modello del Codice
1. Dal modello del codice al riconoscimento del ruolo del contesto: la pragmatica [per la parte su Grice si veda anche l'articolo "Logica e conversazione" fornito dalla docente].
La teoria dell'argomentazione basata sulla logica formale assume, come sappiamo, che una buona argomentazione sia indipendente dal contesto di proferimento. Ciò che il parlante intende comunicare arriva, salvo problemi fisici di trasmissione (rumore di fondo eccessivo, oppure, per esempio, uno telefono rotto), al destinatario, attraverso un doppio processo di codifica e decodifica. Sperber e Wilson, due autori fondamentali della pragmatica recente, parlano di modello del codice, che secondo loro avrebbe dominato la teoria della comunicazione da Aristotele in poi. In realtà il modo più chiaro di capire il 2 di 18modello del codice è quello di fare riferimento alla teoria matematica dell'informazione di Shannon e Weaver (1949) e al diagramma da loro proposto per spiegare come un messaggio possa essere comunicato, ovvero possa essere trasmesso dall'emittente al ricevente:
Sorgente Codificatore Canale Decodificatore Destinazione Messaggio Segnale Segnale ricevuto Messaggio ricevuto
Questo modello spiega la comunicazione in astratto, e vale (solo per fare qualche esempio) tanto per la trasmissione di informazioni tra un termostato e la caldaia cui è collegato, quanto per la comunicazione tra due modem, o ancora per la comunicazione umana.
Il messaggio proveniente dalla sorgente viene codificato e trasformato in un segnale appartenente, appunto, a un determinato codice (p. es., il codice Morse, o il codice binario utilizzato in informatica per far comunicare tanto persone tra loro quanto termostati e caldaie). Tale segnale viene trasmesso attraverso un canale - aria, cavo elettrico, telefonico, o altro mezzo - fino a giungere a un decodificatore. Per passare indenne attraverso il canale il segnale deve superare il rumore di fondo del canale stesso. A tale scopo sarà utile introdurre una certa quota di ridondanza, come ben sanno gli ingegneri elettronici che si occupano di trasmissione dati - o i militari, che rispondendo "Signorsì" o "Signornò" (invece di "Si" e "No") tentano di superare il rumore di fondo creando una situazione di maggior chiarezza sonora. Il processo di decodifica permette infine al messaggio di giungere a destinazione, ritrasformando il codice di trasmissione in un codice comprensibile (p.es., il codice Morse in parole italiane). Oppure consideriamo il collegamento tra un termostato e una caldaia programmata per accendersi sotto i 20°. Il termostato rileva una temperatura di 19.5°. L'informazione viene codificata nel codice adeguato alla trasmissione e inviato alla caldaia, che decodifica il messaggio e, avendogli dato il significato che noi possiamo tradurre con "accenditi", provvederà alla reazione (accensione) fino a quando dal termostato non arriverà un nuovo segnale di spegnimento. Lo schema seguente illustra invece specificamente il funzionamento del modello del codice nel caso umano:
3 di 18Segnale acustico Segnale acustico ricevuto Pensiero Forma logica Processi cognitivi centrali Codificatore linguistico Aria Decodificatore linguistico Processi cognitivi centrali LOCUTORE Rumore ASCOLTATORE
Il parlante codifica il suo pensiero trasformandolo in parole, trasmette il segnale vocale attraverso l'aria (o la linea telefonica, o altro), fino a che, giunto a destinazione, tale segnale viene decodificato e trasformato in un pensiero della mente dell'ascoltatore. Il messaggio viene dunque replicato passando da una mente all'altra.
Il Contributo di Paul Grice alla Pragmatica
Paul Grice, il "padre" della pragmatica, pur non facendo esplicito riferimento al modello del codice si rende conto che le cose, per la comunicazione umana, non funzionano così. O, almeno, il modello del codice non basta. Nella comunicazione umana è fondamentale la distinzione tra significato dell'enunciato e significato del parlante1, così come il ruolo del contesto. In breve, un modello lineare come quello del codice non rende conto dell'importanza dei processi inferenziali nella determinazione del significato.
Consideriamo un elementare scambio comunicativo. Alla domanda di Francesco 'Sai se Elena è tornata?', Mario risponde: (1) Ieri sera Paolo non è venuto al cinema con noi.
(1) ha un significato letterale, ma assai più di esso sembra contare il significato del parlante, vale a dire ciò che il parlante intende dire: Elena probabilmente è tornata. Come fa Francesco a comprendere quello che Mario gli intende dire, a cogliere la sua intenzione comunicativa? Innanzitutto Francesco ricostruisce il significato della frase; e per far questo, secondo Grice, la semplice traduzione presupposta dal modello del codice basta. Ciò, tuttavia, non basta per recuperare il significato del parlante, ovvero ciò che secondo Grice conta davvero nella comunicazione: il significato di (1) non è sufficiente per ricostruire il messaggio che Mario vuole comunicare a Francesco, non gli consente di di capire il senso vero della risposta. Ci vuole un passo ulteriore: è necessario l'intervento di 1 In riferimento a un'altra nota distinzione di Grice, possiamo dire che entrambi i significati - dell'enunciato e del parlante - sono significati naturali, cioè simbolici, che esistono solo in presenza di umani dotati di intenzioni. Viceversa, i significati naturali esistono indipendentemente da chiunque sappia parlare: i cerchi dell'albero significano-n l'età dell'albero, le macchie rosse sul viso del bambino significano-n (indipendentemente dal fatto che lui sappia comunicare o meno) rosolia, ecc.
4 di 18