Strategie, tecniche e strumenti didattici per costruire competenze
Pdf sulle strategie, tecniche e strumenti didattici per costruire competenze. Il Materiale, pensato per l'università, esplora la didattica metacognitiva e la flessibilità delle tecniche per valorizzare le differenze individuali, delineando un'unità di apprendimento con obiettivi e abilità specifiche.
Ver más28 páginas
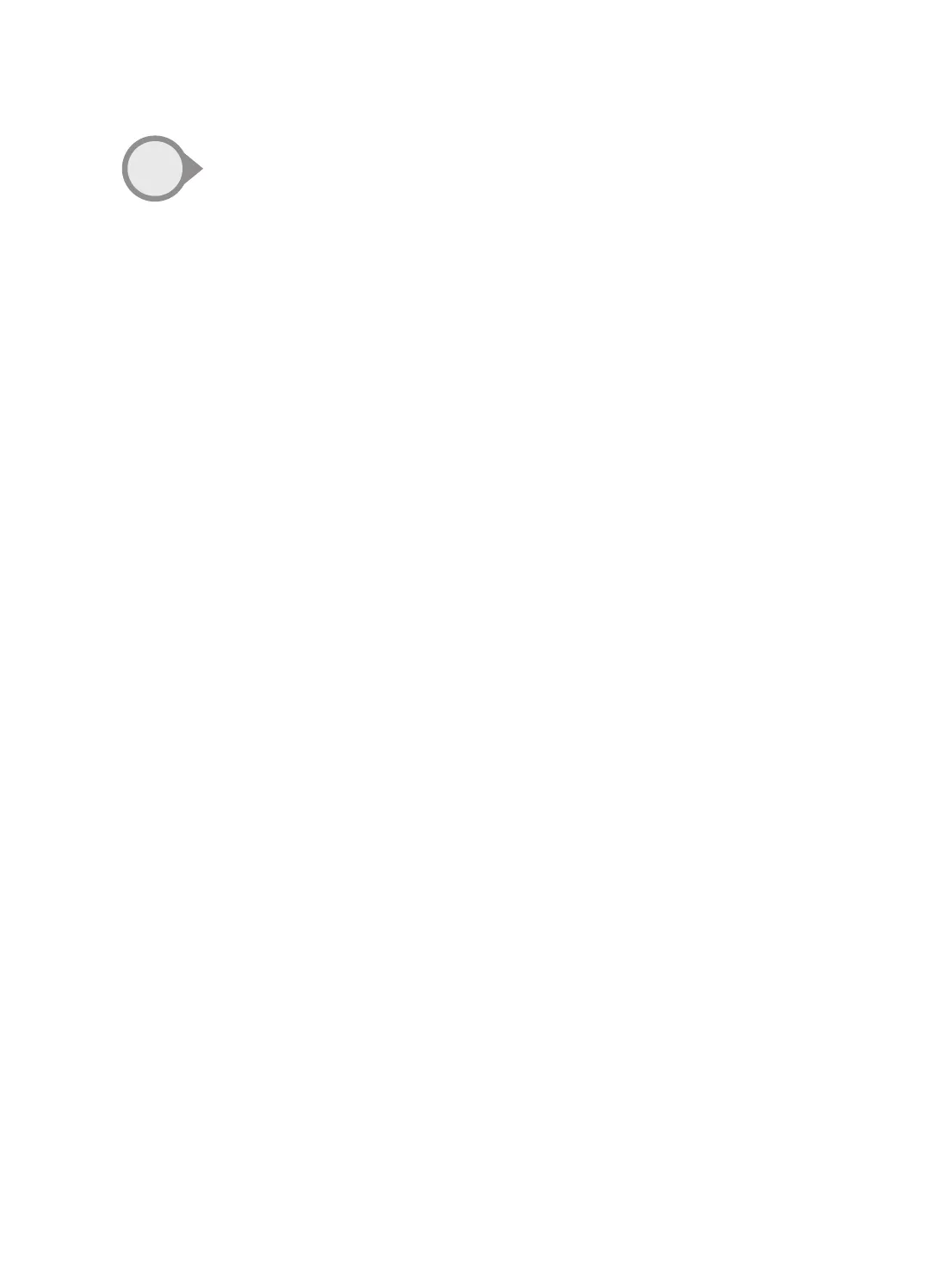
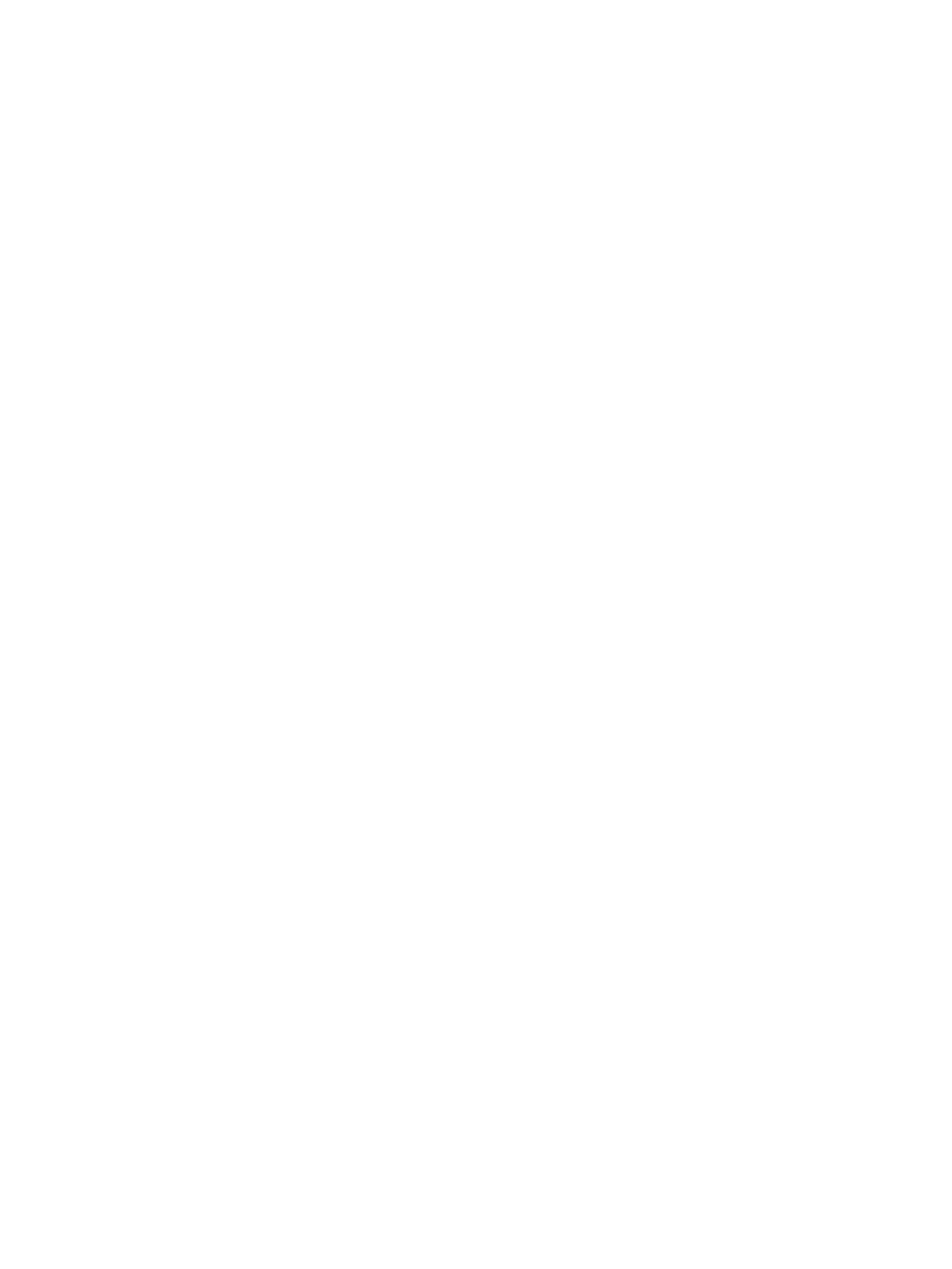
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Strategie, tecniche, strumenti didattici per costruire competenze
Una prospettiva per creare sapere
Per poter effettivamente offrire agli studenti occasioni utili a costruire la propria competenza, oltre alla creazione di un curricolo organico e sistematico è necessario predisporre strumenti, tecniche e strategie centrati sulla competenza. Abbiamo già argomentato come la didattica tradizionale, basata prevalentemen- te sull'azione del docente, sulla trasmissione di conoscenze e sull'esercizio di proce- dure, permetta di conseguire al massimo delle buone abilità. La competenza, invece, si vede e si apprezza in situazione, come "sapere agito", capacità di reagire alle sollecitazioni offerte dall'esperienza, mobilitando tutte le proprie risorse cognitive, pratiche, sociali, metodologiche, personali. Accanto alle lezioni, alle esercitazioni, al consolidamento di procedure, che pure non vanno certo eliminati, è necessario prevedere discussioni, lavori in gruppo, studio di casi, soluzioni di problemi di esperienza, presa di decisioni, realizzazione di compiti significativi. La competenza è costituita da conoscenze e abilità, quindi esse vanno assoluta- mente mantenute e fornite ai livelli più alti. Ciò che si differenzia è la prospettiva con cui esse vengono offerte agli alunni, attraverso approcci induttivi, improntati alla problematizzazione, alla costruzione sociale della conoscenza, alla contestua- lizzazione del sapere nell'esperienza, all'attribuzione di senso e significato ai con- tenuti e alle conoscenze. Ai docenti non si chiede di insegnare cose diverse, ma di scegliere con accuratez- za i contenuti che vogliamo diventino conoscenze e abilità; di dare alle conoscenze una prospettiva diversa, collegata al significato etico della competenza per la for- mazione della persona e del cittadino.
La riflessione-ricostruzione come modalità metacognitiva
Una delle dimensioni fondamentali della competenza è la metacognizione, cioè la consapevolezza di un individuo del significato, della funzione, delle modalità e 75delle potenzialità del proprio sapere. La metacognizione si costruisce per larga parte attraverso la riflessione-ricostruzione dei processi con cui apprendiamo. In questa prospettiva è quindi estremamente importante che all'alunno, posto di fronte a un compito, si chieda sempre come intenderà procedere, come sta pro- cedendo, come ha proceduto. Le domande: «Come intendi fare per ...? », «Che cosa stai facendo?», «Come hai fatto per ...? » vanno costantemente poste, meglio ancora coinvolgendo nella riflessione il gruppo classe. È opportuno, inoltre, chiedere all'alunno l'esplicitazione scritta del procedimento che intende seguire e una relazione scritta e orale quando conduce esperimenti e pro- cedure, o realizza compiti di una certa complessità. Il nostro compito, infatti, è quello di partire dall'esperienza e di portarla a rappresentazione, concetto, idea, attraverso la parola. Nominare l'esperienza e riflettere su di essa favorisce la sua rappresenta- zione teorica e il processo di astrazione. Così come non possiamo insegnare sempli- cemente in modo astratto, formale e teorico senza contestualizzare, non possiamo nemmeno lasciare gli alunni fermi alla fase dell'esperienza e del "fare". Soltanto attribuire la parola all'esperienza, attraverso la verbalizzazione orale e scritta, porta alla sua rappresentazione e quindi alla costruzione del sapere astratto e formale. La conquista del pensiero formale è ovviamente fondamentale: esso connota il pensiero adulto maturo e permette di non dover essere costantemente ancorati all'esperienza "qui e ora", che viene invece rappresentata nella mente attraverso le parole e le idee. Soltanto il processo di riflessione, inoltre, potenzia la capacità di generalizzare e applicare le soluzioni d'esperienza a contesti simili e differenti. Il fatto di condurre le riflessioni e le analisi in gruppo, infine, permette di dif- fondere e generalizzare le capacità metacognitive, che risulteranno anche arricchite dal contributo comune.
La flessibilità delle tecniche didattiche per valorizzare le differenze individuali
L'utilizzo flessibile e versatile delle tecniche didattiche è indispensabile per la- sciare spazio alle differenti modalità di apprendimento che presenta la classe e per consolidare ciò che è stato imparato da ciascuno. Sappiamo che gli alunni sono diversi per stili cognitivi, per modalità di approccio al compito, per capacità di astrazione, per stili di attribuzione, per tipologie di pensiero e di intelligenza. Non sarebbe, però, possibile mettere in pratica strategie strettamente individualizzate; invece, variando le tecniche didattiche, si può andare incontro alle differenze in- dividuali, che, come vedremo, in gran parte sono raggruppabili in macrocategorie.
Gli stili cognitivi
Secondo alcune ricerche psico-pedagogiche, le persone si caratterizzano in base agli stili cognitivi che utilizzano, ovvero alle modalità di costruzione del pensiero, 76di ricordo e recupero dell'informazione, di assunzione decisionale e di approccio al compito. Gli stili, come vedremo di seguito, si connotano per polarità opposte (ana- litico/globale, verbale/ visuale ecc.), dove i due poli non sono necessariamente l'uno migliore o peggiore dell'altro, ma sono semplicemente diversi. In pratica, le polarità rappresentano soltanto delle strategie operative differenti, che possono essere più o meno efficaci a seconda della natura del compito e della situazione da affrontare. Per questo si raccomanda che la scuola si adoperi per fornire agli alunni strumenti e occasioni affinché essi imparino a sviluppare modalità flessibili e "miste" riguardo agli stili di apprendimento. Vediamo gli stili nel dettaglio:
- stile sistematico-intuitivo: è uno stile di pensiero orientato alla costruzione di ipo- tesi. Le persone sistematiche tendono a privilegiare modalità graduali di pensiero, che si sviluppano passo per passo, mettendo in fila le informazioni e utilizzandole per costruire l'ipotesi; le persone intuitive, al contrario, utilizzano soltanto alcune delle informazioni per costruire un'ipotesi e, proseguendo nell'indagine, si servono delle ulteriori informazioni per confermare o meno l'ipotesi iniziale;
- stile analitico-globale: è uno stile di percezione legato alle modalità di accesso all'informazione. Le persone analitiche tendono a vedere nella realtà i partico- lari; le persone globali, al contrario, tendono a vedere la realtà in modo olistico, prestando minor attenzione ai dettagli. Con una battuta, potremmo dire che i globali tendono a vedere la foresta, gli analitici gli alberi;
- stile verbale-visuale: è una modalità di accesso, organizzazione e recupero dell'informazione. Le persone di tipo verbale tendono a ricordare meglio il mate- riale che si presenta loro sotto forma di parola, parlata o scritta; le persone visua- li, al contrario, tendono a ricordare meglio il materiale corredato di stimoli visivi (accentuazioni grafiche, come il grassetto, il colore; organizzazione particolare del testo, in tabelle, paragrafi, didascalie ecc .; ausili visivi, come foto e disegni);
- stile impulsivo-riflessivo: è una modalità di azione e assunzione di decisione. È l'unico caso tra gli stili in cui la polarità impulsiva va corretta, perché danneggia l'accuratezza delle decisioni e, se portata all'estremo, si connota come patologica. La persona impulsiva tende ad affrontare il compito e ad assumere decisioni senza analizzare accuratamente i dati a disposizione, ma passando direttamente "all'at- to", incorrendo facilmente in errori e decisioni non efficaci. D'altra parte, anche una persona eccessivamente riflessiva va aiutata a velocizzare i propri processi decisionali, poiché modalità troppo lente possono rivelarsi poco efficaci in condi- zioni di crisi oppure nei casi in cui sia necessario decidere e agire in tempi rapidi;
- stile convergente-divergente: è uno stile di pensiero tale per cui le persone con- vergenti tendono a privilegiare modalità di pensiero e di azione improntate a procedure precise, meglio ancora se collaudate; al contrario, le persone divergenti tendono a percorrere modalità inusuali, nuove, innovative. È chiaro che, anche 77in questo caso, a seconda del compito, può essere più efficace una modalità con- vergente o una divergente. Ad esempio, un'azienda che abbia bisogno di mettere a punto un prodotto nuovo, si avvarrà più proficuamente di persone divergenti, ma nel momento in cui il prodotto deve essere realizzato su larga scala sarà ne- cessario che il processo produttivo segua procedure codificate e standardizzate, e quindi, in questo caso, le modalità convergenti si riveleranno più efficaci.
Dopo avere esaminato gli stili e le loro polarità, appare chiaro come sia prefe- ribile l'uso di modalità miste e flessibili, potendo così avere a disposizione una più vasta gamma di strategie solutive per problemi diversi. Una didattica versatile, che affidi compiti concreti, connotati dalla varietà dell'esperienza, e utilizzi stimoli di- versificati riesce più facilmente a raggiungere questo obiettivo.
I diversi tipi di intelligenza
Dalle ricerche in campo psicologico, sappiamo che le persone possono differen- ziarsi anche rispetto ai tipi di intelligenza. Secondo la teoria delle intelligenze mul- tiple dello psicologo Howard Gardner (nato nel 1943), ad esempio, ogni individuo possiede una "forma mentis" prevalente, che convive insieme ad altre con le quali si "miscela" in misura variabile. Si tratterebbe di doti genetiche, che si sviluppano in interazione con il contesto sociale. Le dimensioni dell'intelligenza individuate da Gardner sono:
- linguistica;
- musicale;
- logico-matematica;
- spaziale e visiva;
- corporeo-cinestetica;
- sociale o interpersonale;
- introspettiva o intrapersonale;
- naturalistica.
Secondo un altro psicologo, Robert Sternberg (nato nel 1949), invece, il pensiero umano si compone di tre dimensioni fondamentali che si fondono in combinazioni personali e irripetibile di intelligenze diverse, in interazione con gli stili cognitivi:
- pensiero analitico (capacità di giudicare, valutare, scomporre, fare confronti, rilevare contrasti, esaminare dettagli);
- pensiero creativo (scoprire, produrre novità, immaginare, intuire);
- pensiero pratico (si realizza nell'organizzazione, nell'abilità di usare strumenti, attuare concretamente progetti e piani mirati a obiettivi concreti).
L'aspetto interessante è che Sternberg sostiene che la didattica tradizionale tende a favorire gli alunni con pensiero analitico, penalizzando invece quelli con pensiero creativo e ancor più quelli con pensiero pratico-organizzativo. Lo studioso afferma 78