Diritto Penale e Legge Penale: Caratteristiche e Funzioni
Documento di Università sul Diritto Penale e Legge Penale. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, esplora le funzioni di tutela del diritto penale, la protezione dei beni giuridici e la responsabilità degli enti collettivi.
Ver más35 páginas
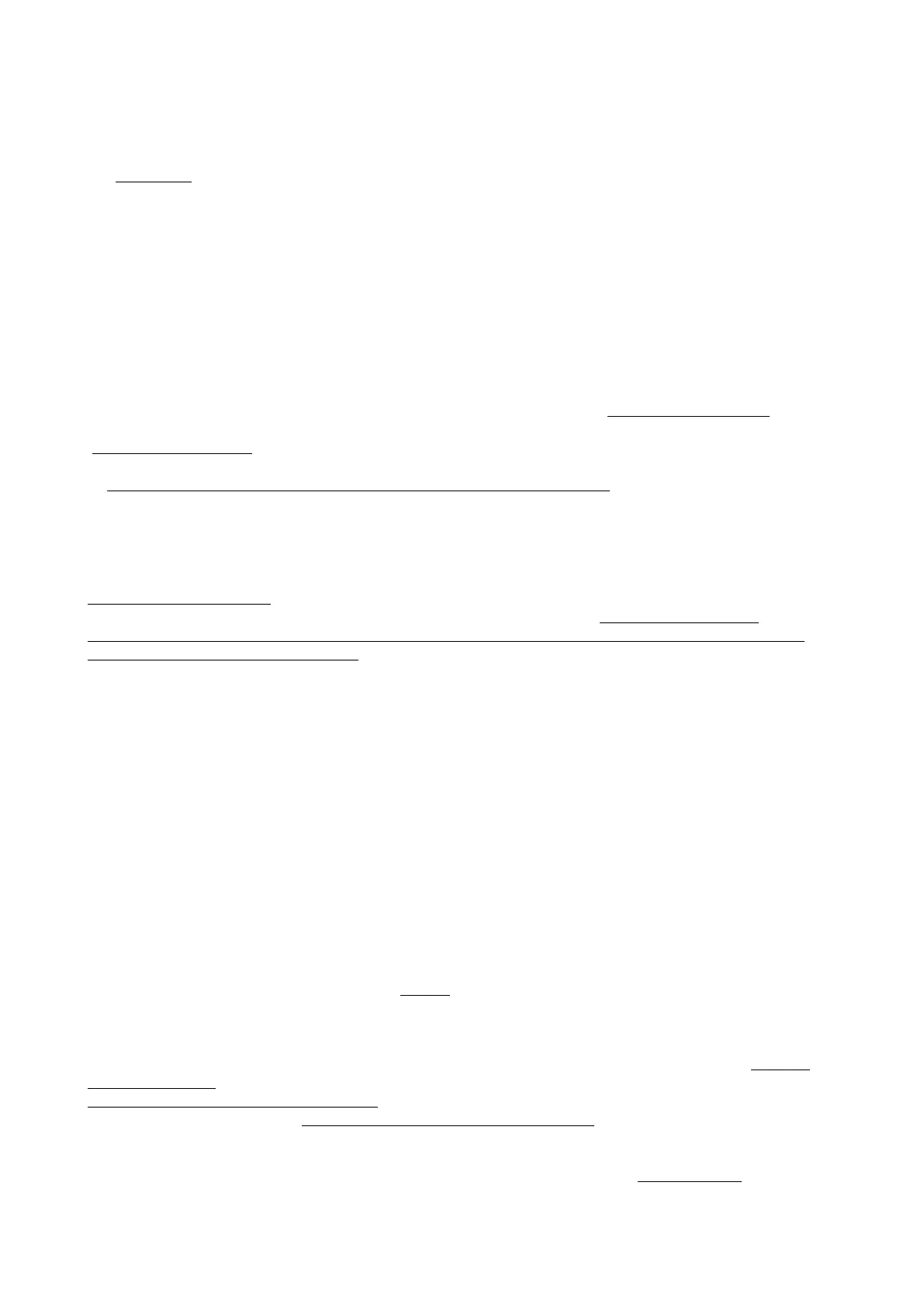
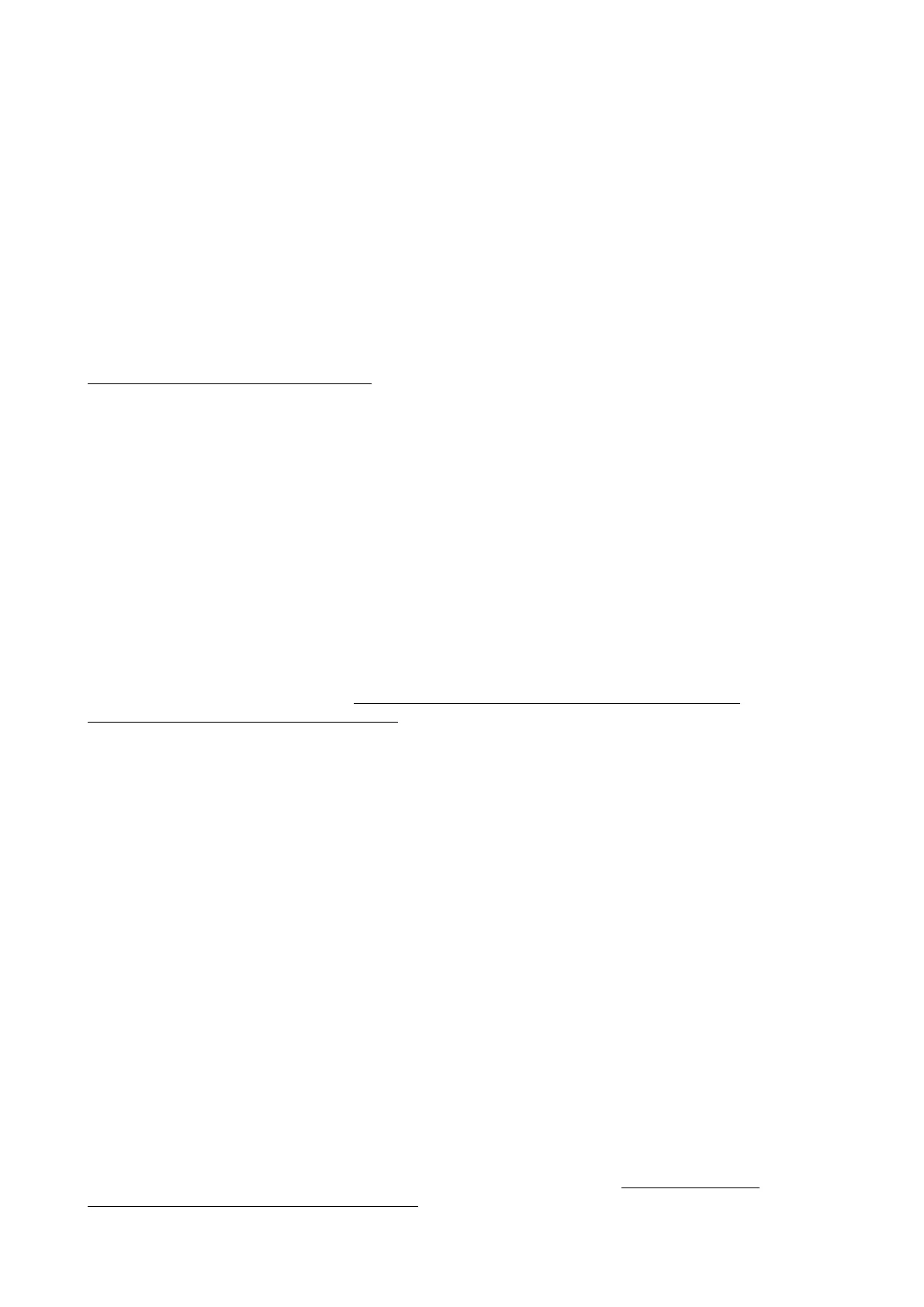
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Premessa sul diritto penale
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Si definisce reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Queste possono essere la pena o la misura di sicurezza, che hanno lo scopo di difendere la società e risocializzare il reo. Sono definibili, poi, leggi penali quelle che riconnettono sanzioni penali alla commissione di determinati fatti. Il concetto di reato ruota intorno a 3 principi: 1) principio di materialità, e cioè non vi è reato se non vi è un comportamento esterno, 2) principio di necessaria lesività o offensività, e cioè non vi è reato se non vi è la lesione di beni giuridici, 3) principio di colpevolezza, e cioè non vi è reato se quel determinato comportamento non è "rimproverabile". La necessità di ricorrere al diritto penale risiede nella particolare dannosità sociale di determinati comportamenti; il diritto penale ha, inoltre, una forte forza preventiva, che si esplica in due modi: attraverso la minaccia di infliggere una pena (prevenzione generale), e attraverso la concreta inflizione della pena che non permette al reo di essere dannoso (prevenzione speciale).
Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei beni giuridici
Il bene giuridico è quel bene socialmente rilevante meritevole di tutela penale. Tale definizione, molto generica, è stata oggetto di aggiunte e modifiche aventi l'intento di riempirne il significato. Tuttavia, è difficile trovare una definizione che riesca nettamente a separare ciò che è meritevole di tutela da ciò che non lo è. La recente elaborazione teorica ha presentato un'idea di bene giuridico dinamico, e cioè di un bene giuridico che è tutelabile in quanto è funzionale alla vita sociale, e non in quanto bene giuridico in sé. Sotto tale profilo, è bene giuridico solo quell'interesse, o quell'insieme di interessi, idonei a realizzare un determinato scopo utile per il sistema sociale o per una sua parte. Ovviamente, tale definizione, come tutte d'altronde, soffre di non poche eccezioni e forzature. La prospettiva della protezione di determinati beni giuridici, beni essenziali, ha matrice illuminista, nelle opere di Beccaria e Feuerbach, in cui viene sottolineato che il diritto penale debba intervenire solo nei limiti della stretta necessità. Tuttavia, il concetto di un diritto penale che tutela solo alcuni beni essenziali è un'idea lontana dal nostro ordinamento che, in verità, punisce comportamenti che neppure raggiungono la soglia di percepibile aggressione all'interesse protetto. Da questo punto di vista, si assiste ad una divaricazione tra la concezione teoria di diritto penale e la realtà dell'ordinamento. L'idea di bene giuridico, che, come facilmente si può notare, ha la funzione di limitare la potestà punitiva dello Stato, essendo molto generica e ampia rischia di divenire un contenitore che si presta a ricomprendere contenuti vari in dipendenza della società e del tempo. Storicamente, è stato Birnbaum il padre del "bene giuridico": egli, criticando la concezione illuministica di bene giuridico = diritto soggettivo, sottolineava come questo dovesse essere di un particolare rango, superiore a quello del diritto soggettivo. Tutto intento alla creazione di un concetto di bene giuridico che limitasse la sovranità statale, poi, Franz v. Liszt propose un concetto materiale di bene giuridico basato su interessi preesistenti alla valutazione del legislatore: "il contenuto antisociale dell'illecito è indipendente dal suo giusto apprezzamento da parte del legislatore; la norma giuridica lo trova, non lo crea. Di inclinazione diversa appare, invece, la concezione di Arturo Rocco, nell'opera "L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale". Secondo Rocco, propugnatore dell'indirizzo tecnico - giuridico, la determinazione del concetto di bene giuridico non può prescindere da valutazioni normative già compiute dal legislatore, per cui il concetto di bene finisce col coincidere con l'oggetto di tutela di una norma penale già emanata; proprio per questo era avverso a qualsiasi tentativo sociologico per configurare una nozione di bene giuridico. Risale a Rocco, inoltre, la distinzione tra oggetto giuridico formale (= diritto dello Stato all'obbedienza alle proprie norme da parte dei cittadini), oggetto giuridico sostanziale generico (= interesse dello Stato alla sicurezza della propria esistenza e conservazione), oggetto giuridico sostanziale specifico (= bene o interesse di pertinenza del soggetto passivo del reato). Tale impostazione è sintomatica di quel processo di << formalizzazione>> tipica delle correnti positiviste e tecnico - giuridiche. Altra concezione del bene giuridico, che ha portato ad ancora maggiore formalismo, è quella metodologica, elaborata dalla dottrina tedesca negli anni '30. Secondo i metodologi, il concetto di bene giuridico si riduce 1ad una mera formula abbreviatrice del più ampio concetto di scopo della norma penale, che è possibile individuare solo attraverso un'attenta attività interpretativa; quindi, il bene giuridico non sarebbe una realtà preesistente alla norma, ma esso si ridurrebbe al risultato di una interpretazione c.d. di scopo. Tale concezione, tuttavia, finisce con l'identificare il bene giuridico con la ratio legis. Secondo la concezione nazionalsocialista, poi, al centro del reato non si troverebbe più il bene giuridico oggetto di tutela, bensì la violazione del dovere di fedeltà nei confronti dello Stato etico, impersonato dal Führer. L'idea della protezione dei beni giuridici come scopo del diritto penale ritorna sulla scena del dibattito penalistico a partire dai primi anni '60 in Germania e '70 in Italia. E questo anche in seguito al riassetto politico dello Stato: la progressiva conquista di spazi di libertà e democrazia ha, infatti, imposto, sul terreno penalistico, un ripensamento critico dei criteri di legittimazione dell'intervento punitivo nell'ambito di un moderno Stato di diritto. Si ritorna ad una concezione liberale, vicina a quella di v. Liszt, secondo cui il concetto di bene giuridico preesiste al dato positivo - normativo, e tale concezione muove dall'obiettivo di liberare il diritto morale dall'attaccamento alla morale corrente (vedi il problema della laicità del diritto penale). Secondo tale concezione può assurgere a bene giuridico solo entità materiali concretamente ledibili; tenuto conto della genericità della nozione, è facile intuire come il problema di tale norma sia l'incapacità di individuare una concezione univoca di bene giuridico. Proprio per evitare l'arbitrio del legislatore, la dottrina ha elaborato una concezione di bene giuridico costituzionalmente orientata, dove la Costituzione viene presa come riferimento per ciò che può realmente costituire reato. Inoltre, la costituzionalizzazione del bene giuridico ha portato il ricorso allo strumento penale solo nei casi di << stretta necessità>>. Si possono al riguardo richiamare: 1) l'art. 25, comma II Cost., che, affidando interamente al Parlamento o al Governo il potere di legiferare in materia penale, non può non muovere dall'esigenza di una riduzione del campo dell'illiceità penale; b) l'art. 27, comma I Cost., il quale sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale; c) l'art. 27, comma III Cost., che attribuisce alla pena una funzione rieducativa. Infine, vi sarebbe da aggiungere l'art. 13 Cost. il quale sancisce l'inviolabilità della libertà personale.
Inoltre, la pena sacrifica altri valori costituzionali come la dignità sociale e frusta una piena estrinsecazione della personalità umana: se così è, la pena incide anche sui valori protetti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Quindi, il ricorso alla pena trova giustificazione solo se diretto a tutare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale. L'assunto della necessaria rilevanza costituzionale dei beni oggetto di tutela penale non deve, però, essere inteso in senso eccessivamente letterale, dovendosi includere anche i beni che trovano nella Costituzione un riconoscimento implicito: 1) beni non previsti costituzionalmente ma funzionali alla tutela di altri beni giuridici costituzionalmente garantiti, 2) altri beni che rientrano nel sistema sociale dei valori (come la pietà per i defunti). Il fatto che vi siano altri valori rilevanti per il diritto penale è un qualcosa di naturale, essendo la tutela penale differente da quella costituzionale. Dopo tali precisazioni, è più agevole rispondere alla critiche secondo cui la concezione costituzionalmente orientata del bene giuridico non sarebbe idonea a soddisfare le nuove esigenze di tutela scaturenti dal continuo evolversi della realtà sociale. Proprio l'estensione della tutela ai beni di rilevanza costituzionale anche implicita, fa ritenere ammissibile l'eventuale tutela di beni non ancora emersi nel periodo in cui la Costituzione ha visto la luce. È poi da rilevare che, di fronte all'apparente affiorare alla ribalta di un nuovo bene meritevole di protezione, non di rado non si tratta di altro che dell'esigenza di proteggere un bene già esistente da una nuova forma di aggressione. Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è ben lungi dal soddisfare le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici fin qui esposta. Invero, i motivi di frizione tra detta teoria e l'ordinamento positivo non sono pochi e si possono analizzare sotto due angolazioni: a) da un lato, verificando se si tratti di fattispecie poste a tutela di un bene sufficientemente definito e, per di più, in armonia con il sistema dei valori costituzionali, b) dall'altro, controllando la conformità ai principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal legislatore per garantire la salvaguardia del bene stesso. Riguardo il primo punto, abbiamo i c.d. reati senza bene giuridico, ed in particolare, si fa riferimento a quei tipi di reati che impongono di tenere una determinata morale (ad es. la pornografia), e reati che riguardano fattispecie tutelate per proteggere interessi quali l'economia, l'ambiente, il territorio, gli interessi diffusi. In quest'ultimo caso si tratterebbe di tutelare funzioni amministrative o la disciplina di determinate attività. In ogni caso, non bisogna ridurre la consistenza del bene protetto alla semplice materialità del suo substrato fisico: non pochi beni superindividuali, come l'ambiente, hanno acquisito un rango crescente nella stessa coscienza sociale. Sicché la prospettiva del discorso finisce col mutare: il problema si sposta su un terreno diverso, che è quello della corretta tecnica di strutturazione delle fattispecie incriminatrici. Problematici, sotto il profilo dell'enucleazione di uno 2