Apprendimento, Memoria e Oblio: modelli e teorie in Psicologia
Documento di Università su Apprendimento, Memoria e Oblio. Il Pdf esplora i concetti di apprendimento, memoria e oblio, analizzando i modelli di memoria multi-magazzino e a magazzino singolo, le diverse tipologie di memoria e la distinzione tra memoria episodica e semantica, utile per lo studio della Psicologia.
Ver más46 páginas
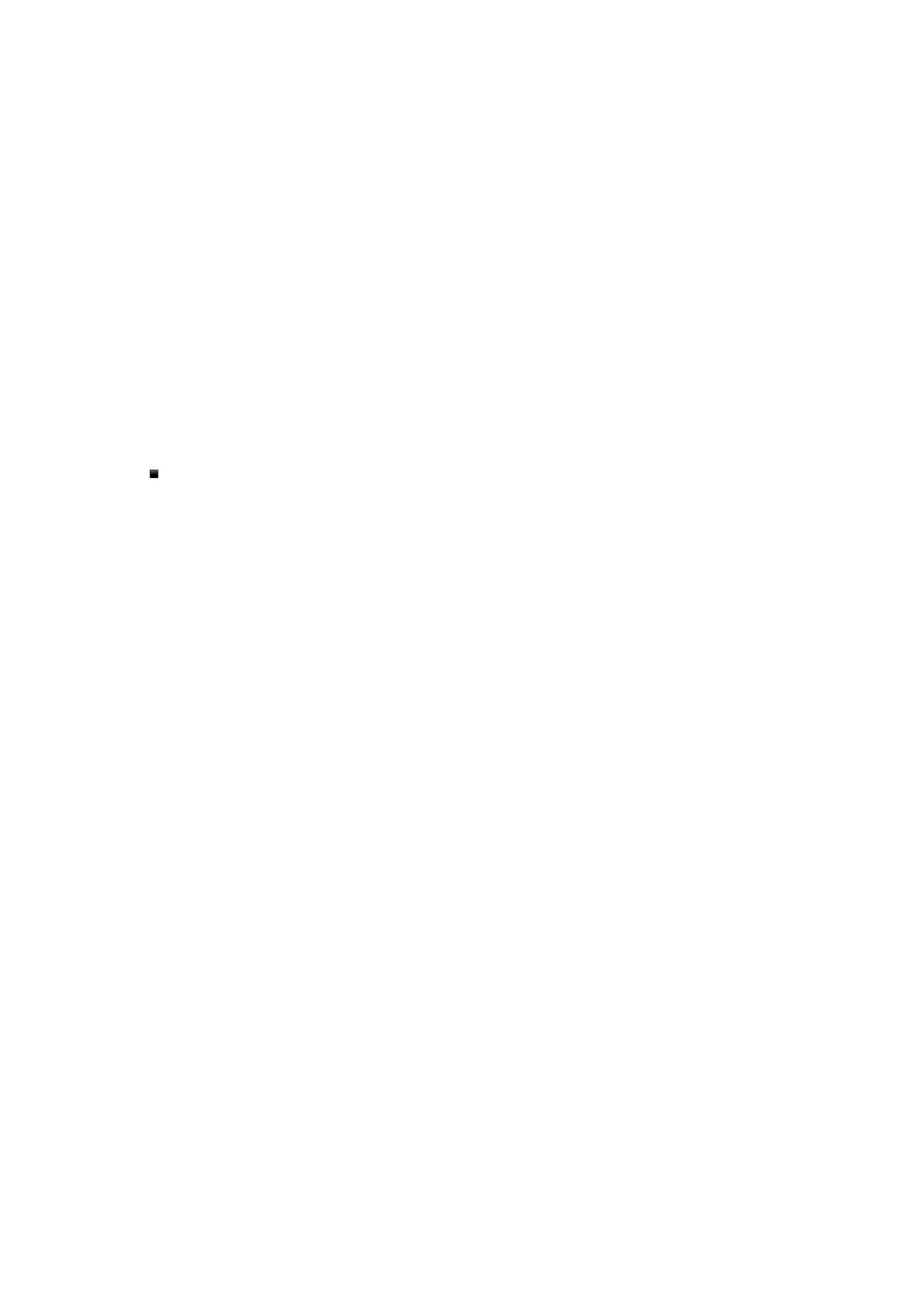

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
STRUTTURA DELLA MEMORIA
Modello multi-magazzino (Atkinson e Shiffrin, 1968)
Descrive l'architettura fondamentale del sistema della memoria in termini di numero di magazzini, proponendone tre tipi distinti:
- a) magazzini sensoriali, che sono specifici per ciascuna modalità sensoriale e conservano le informazioni per un tempo molto breve;
- b) magazzino di memoria a breve termine, di capacità piuttosto limitata;
- c) magazzino di memoria a lungo termine, di capacità praticamente illimitata che può conservare le informazioni per periodi di tempo estremamente lunghi.
2. Essi differiscono tra di loro per: durata temporale; capacità di immagazzinamento; meccanismi dell'oblio; effetti delle lesioni cerebrali.
Magazzini sensoriali
- magazzino iconico, cioè il magazzino visivo, utile;
- magazzino ecoico, cioè il magazzino uditivo temporaneo.
Elaborano l'info in parallelo e poi la mandano al magazzino a breve termine.
Magazzino a breve termine
la sua capacità è molto limitata (4 chunk); un effetto che riguarda la memoria a breve termine è l'effetto recency, che capita quando, in un compito di rievocazione libera, si ricordano meglio gli ultimi elementi di una lista rispetto a quelli intermedi. Inoltre:
- - le informazioni non reiterate vengono annullate con rapidità nella memoria a breve termine attraverso il decadimento;
- - i meccanismi di oblio sono diversi rispetto a quelli della memoria a lungo termine.
Mantiene l'info in modo accessibile temporaneamente e poi la trasferisce al magazzino a lungo termine.
Magazzino a lungo termine
è stata dimostrata la sua distinzione dalla memoria a breve termine tramite studi sulle doppie dissociazioni:
- - i pazienti affetti da amnesia presentano in genere una scarsa memoria a lungo termine ma una memoria a breve termine normale;
- - alcuni pazienti cerebrolesi presentano una memoria a breve termine ridotta ma una memoria a lungo termine intatta.
Limiti della teoria multi-magazzino
- - è troppo semplicistica quando afferma che il magazzino a breve termine e quello a lungo termine operano in modo singolo e uniforme (che sono cioè unitari), dato che lo studio di pazienti amnesici ha dimostrato che esistono più sistemi separati di memoria a lungo termine;
- - l'ipotesi secondo cui il magazzino a breve termine operi come una via di passaggio tra i magazzini sensoriali e la memoria a lungo termine non è corretta (le informazione elaborate nel magazzino a breve termine sono già entrate in contatto con le informazioni immagazzinate nella memoria a lungo termine);
- - ipotizza che le informazioni nella memoria a breve termine rappresentino il "contenuto della consapevolezza" e che quindi solo le informazioni elaborate in modo consapevole possono essere immagazzinate nella memoria a lungo termine, ma sembra esistere apprendimento senza consapevolezza di ciò che è stato appreso (apprendimento implicito);
- - l'ipotesi principale afferma che il magazzino a lungo termine conserva un'informazione se è reiterata o ripetuta nel magazzino a breve termine, ma il ruolo della reiterazione nella vita quotidiana è decisamente meno importante di quanto postulato dalla teoria;
- - si concentra in modo eccessivo sugli aspetti strutturali della memoria piuttosto che sui processi della memoria stessa.
Modello a magazzino singolo (Jonides, 2008)
Ipotizza che la memoria a breve termine sia costituita da attivazioni temporanee di rappresentazioni della memoria a lungo termine o da rappresentazioni di elementi percepiti di recente; tali attivazioni spesso si verificano quando l'attenzione è concentrata su determinate rappresentazioni. Evidenze sperimentali mostrano come sia corretto ritenere che l'attivazione della memoria a lungo termine svolga un ruolo importante nella memoria a breve termine; inoltre si è dimostrato come i pazienti amnesici possano mostrare un deficit nella memoria a breve termine in determina circostante (ad es. quando è richiesta memoria relazionale, cioè quando è richiesto di formulare nuove relazioni).
Limiti della teoria a magazzino singolo
- - è eccessivamente semplicistico sostenere che la memoria a breve termina sia attivata solo dalla memoria a lungo termine (esistono casi in cui ciò non accade);
- - non vi sono evidenze convincenti a convalida dell'ipotesi che i pazienti amnesici mostrino deficit di prestazione nei compiti di memoria relazione che dipendono principalmente dalla memoria a breve termine (sembra che essi abbiano una prestazione ridotta solo nei compiti di "memoria a breve termine" che dipendono in gran parte dalla memoria a lungo termine, e che i processi di memoria a breve termine siano intatti);
- - non vi sono altre evidenze che sostengano in modo decisivo l'approccio a magazzino singolo.
MEMORIA DI LAVORO (WORKING MEMORY)
Baddeley e Hitch (1974) hanno sostituito il concetto di magazzino a breve termine con quello di memoria di lavoro (working memory); essa è costituta da 4 parti:
- Esecutivo centrale, simile all'attenzione;
- Circuito fonologico, che conserva le informazioni in forma fonologica;
- Taccuino visuo-spaziale, specializzato nella codifica spaziale e/o visiva;
- Buffer episodico, un sistema di immagazzinamento temporaneo che può conservare ed integrare le informazioni del circuito fonologico, del taccuino visuo-spaziale e dalla memoria a lungo termine.
ESECUTIVO CENTRALE
La componente più importante è l'esecutivo centrale, il quale ha capacità limitata, è simile all'attenzione e gestisce i compiti più impegnativi dal punto di vista cognitivo; ciascuna componente del sistema della memoria di lavoro ha capacità limitata ed è relativamente indipendente dalle altre e ne conseguono 2 ipotesi:
a) se due compiti utilizzano la stessa componente, non possono essere eseguiti contemporaneamente in modo soddisfacente; b) se due compiti utilizzano componenti diverse, dovrebbe essere possibile eseguirli altrettanto bene sia insieme che separatamente.
Simile ad un sistema attenzionale, organizza e coordina il funzionamento del sistema cognitivo; sembra sia localizzato nella corteccia prefrontale dorsolaterale, ma non è del tutto vero (i pazienti con sindrome disesecutiva, per cui hanno difficoltà nella pianificazione, nell'organizzazione e nel monitoraggio del comportamento, non presentano sempre lesioni a carico dei lobi frontali). Miyake (2000) ha identificato 3 processi esecutivi o funzioni:
- funzione di (1) inibizione, che si riferisce alla capacità di inibire deliberatamente risposte dominanti, automatiche quando necessario;
- funzione di (2) trasferimento, che si riferisce allo spostarsi tra vari compiti, operazioni, o set mentali (viene usata quando si trasferisce l'attenzione da un compito ad un altro);
- funzione di (3) aggiornamento, che si riferisce all'aggiornamento ed al monitoraggio delle rappresentazioni della memoria di lavoro (viene usata quando si aggiornano le informazioni che è necessario ricordare).
Evidenze sperimentali dimostrano l'esistenza di queste funzioni (ogni processo è infatti associato all'attivazione di una regione diversa della corteccia prefrontale); è comunque probabile che esista anche una quarta funzione dedicata specificatamente alla coordinazione e all'elaborazione dei (4) doppi compiti. Stuss e Alexander (2007) hanno messo in dubbio il concetto di sindrome disesecutiva perché implica la che la lesione cerebrale ai lobi frontali danneggia in genere tutte le funzioni dell'esecutivo centrale; questi pazienti presentano una sindrome disesecutiva globale, ma vi sono 3 processi esecutivi che implicano parti diverse dei lobi frontali:
- definizione del compito, la capacità di stabilire una relazione stimolo-risposta (implica la pianificazione); - monitoraggio, il processo di controllo del compito nel tempo per un controllo di qualità;
- energizzazione, il processo di inizio e di conservazione delle risposte (implica concentrazione prolungata).
Questi processi sono molto generali in quanto vengono usati in un'enorme varietà di compiti; inoltre non sono veramente indipendenti perché possono essere usati simultaneamente quando si affronta un compito complesso. Evidenze sperimentali hanno dimostrato (studiando pazienti cerebrolesi) che a ciascun processo sono associate diverse regioni della corteccia frontale. La differenza rispetto ai processi individuati da Miyake consiste nel fatto che nei soggetti sani i processi di Stuss e Alexander non emergono chiaramente come processi distinti (ma diventano più chiare quando si considerano pazienti con lesioni frontali molto specifiche).
Principali caratteristiche dell'esecutivo centrale
- Funzione di inibizione (effetto Stroop)
- Funzione di trasferimento (sessione somma, moltiplicazione, divisione di numeri ... Spostarsi nei compiti)
- Funzione di aggiornamento e attivazione temporanea della memoria di lavoro (Esempio gruppi di categorie differenti, ricordare le ultime per ciascuna categoria)
CIRCUITO FONOLOGICO
in base ad alcune evidenze sperimentali sembra che il circuito fonologico sia costituto da:
- un magazzino fonologico passivo, direttamene coinvolto nella percezione del linguaggio;
- un processo articolatorio connesso alla produzione del linguaggio che dà accesso al magazzino fonologico.
Le parole presentate uditivamente vengono quindi elaborate in modo differente rispetto a quelle presentate visivamente (la presentazione uditiva produce un accesso diretto al magazzino fonologico, mentre la presentazione visiva permette solo un accesso indiretto al magazzino fonologico attraverso l'articolazione subvocale). La funzione del circuito fonologico non è quella di ricordare parole familiari, ma di apprenderne di nuove; tuttavia è anche possibile che disporre di un lessico ricco aumenti la capacità effettiva del circuito fonologico.
Principali caratteristiche del circuito fonologico
- Basato su reiterazione verbale
- Effetto somiglianza fonologica (due parole fonologicamente simile non sono ricordate bene)
- Effetto lunghezza delle parole (vi è uno span di circa due secondi per le parole lette di seguito) Baddley dimostra che se dei soggetti dovevano ripetere ad alta voce cifre diminuiva la capacità visiva della lunghezza di parole) Non in maniera uditiva
- A) Magazzino fonologico passivo collegato alla percezione del linguaggio
- B) Processo articolatorio La percezione uditiva produce un accesso diretto al magazzino fonologico. Quella visiva indiretta attraverso la subvocalizzazione (processo articolatorio)
- - Alcuni pazienti mostrano danni per materiale verbale-uditivo, ma hanno linguaggio normale. Quindi hanno danni al circuito fonologico, ma articolazione integra (lesione corteccia parietale inferiore sx);
- - Altri hanno un magazzino fonologico intatto ma problemi articolatori (corteccia frontale inferiore sx). Limiti: valido solo su materiali nuovi e non sulla familiarità (italiane, russe)
TACCUINO VISUO-SPAZIALE
viene usato nella memorizzazione temporanea e nella gestione delle informazioni spaziali e visive; secondo Logie (1995) può essere suddiviso in due componenti:
- deposito visivo (cache), che immagazzina le informazioni relative alla forma e al colore;
- copista interno (scribe), che gestisce le informazioni spaziali e di movimento, recuperando le informazioni dal deposito visivo e trasferendole all'esecutivo centrale.
Evidenze sperimentali hanno dimostrato che il sistema visivo è distinto da quello spaziale, in quanto vengono attivate regioni cerebrali distinte (emisfero destro per i compiti spaziali, emisfero sinistro per quelli visivi); altre evidenze provengono dallo studio di pazienti cerebrolesi che presentano lesioni a carico della componente visiva ma non di quella spaziale.
Principali caratteristiche del taccuino visuo-spaziale
- Memorizzazione informazioni visuo-spaziali
- (il taccuino funziona quando sono informazioni nuove, es. nuovo videogioco interferenza compito concorrente ... No quando sono apprese)
- Compito spaziale (memoria posizione punti)
- Compito visivo (memoria ideogrammi cinesi)
- Interferenza spaziale (discriminazione movimento oggetto)
- Interferenza visiva (discriminazione colore)
- Controllo