Diffamazione e tutela dei diritti online: siti informativi, blog e social network
Documento dall'Università sulla diffamazione e tutela dei diritti online: siti informativi, blog e social network. Il Pdf esplora la giurisprudenza italiana in merito all'equiparazione tra diffamazione a mezzo stampa e online, la competenza territoriale e le responsabilità dei gestori di blog e social media, utile per lo studio del Diritto.
Ver más12 páginas
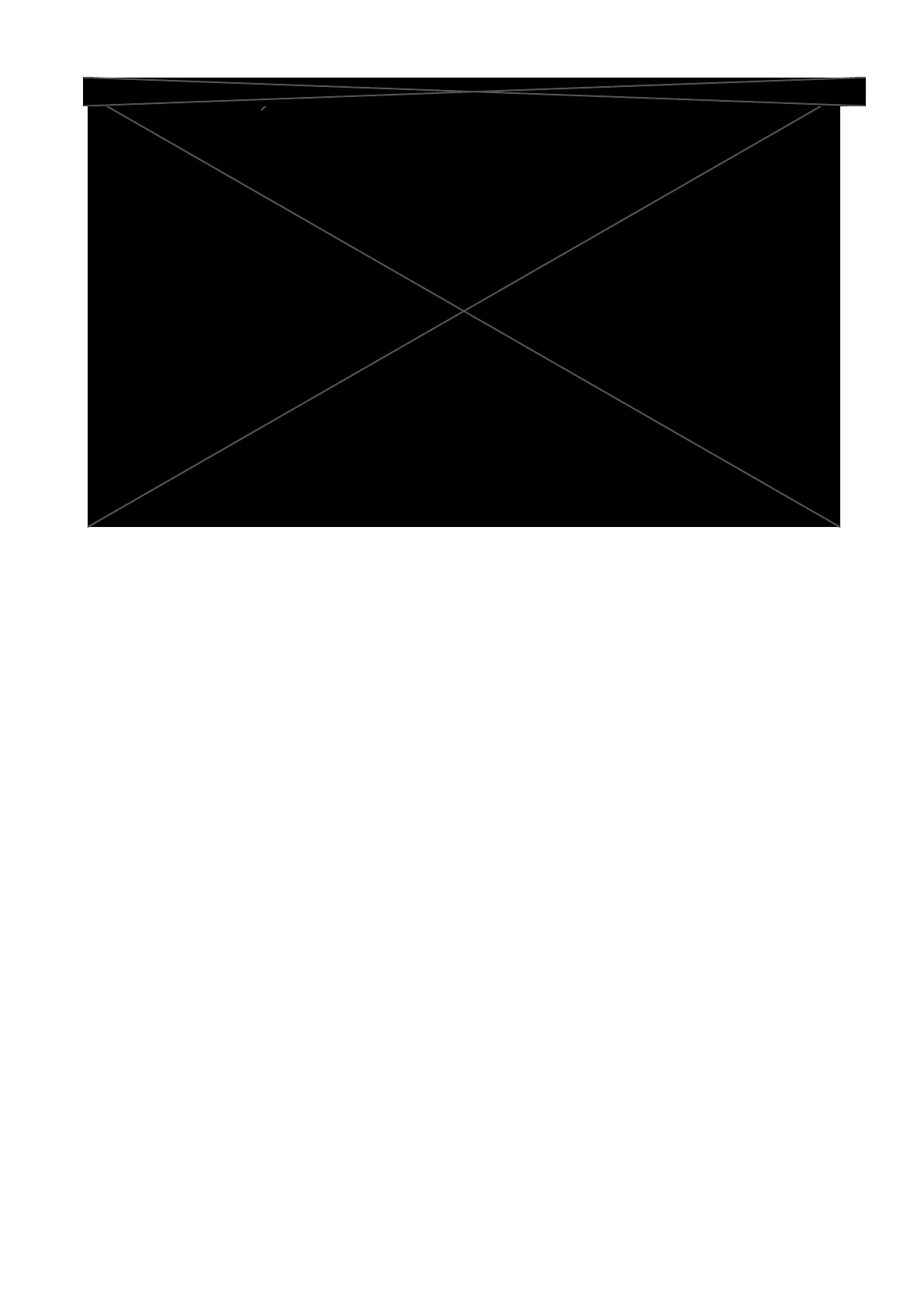
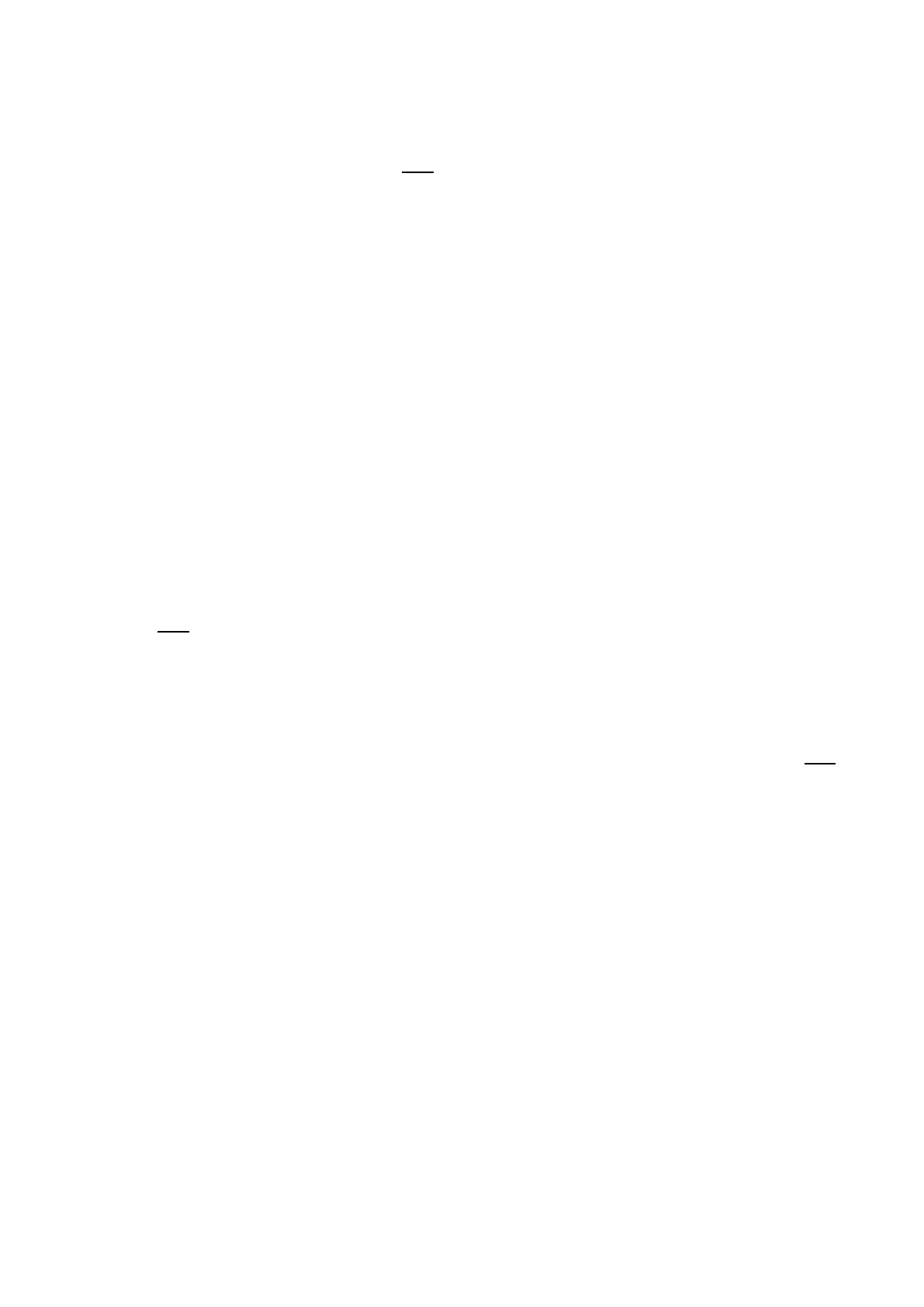
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Diffamazione e tutela dei diritti online
6.2 Diffamazione tutela dei diritti online: siti informativi, blog e social network Il dilagare dell'utilizzo di internet e il carattere ubiquo e de-territorializzato dell'ambiente virtuale pone crescenti problemi di regolamentazione giuridica: servono strumenti adeguati per governare le informazioni che si diffondono in maniera illimitata. Nell'informazione online è ancora più difficile bilanciare esercizio del diritto di cronaca e tutela dei diritti dei singoli, in quanto è complesso delimitare i confini del primo e individuare strumenti per un'efficace tutela.
Se si ipotizzasse di equiparare le regole vigenti per la stampa e le regole da applicare al giornalismo in Internet ci sarebbe la necessità di delineare criteri di individuazione molto puntuali per quanto riguarda i reati commissibili in rete, in particolare quanto riguarda la delineazione del tempus e del locus commissi delitti. Il carattere transnazionale di Internet rende, infatti, problematica la collocazione spazio-temporale del fatto penalmente illecito. Per quanto riguarda la diffamazione, per stabilire il tribunale competente occorre rifarsi a più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Per quanto riguarda l'equiparazione in se, nel '97, un'ordinanza il Tribunale di Teramo emanò un provvedimento cautelare con cui accoglieva la richiesta del Monte dei Paschi di Siena di inibire in via urgente l'ulteriore diffusione su un sito Internet di notizie lesive dell'onore del decoro e della reputazione della banca. Il tribunale rilevò che erano state diffuse notizie incomplete riguardanti l'accertamento giudiziario di una truffa contestata alla banca; la parte resistente, invece, sosteneva che quanto divulgato rientrasse nel diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero.
Il Tribunale di Teramo affermò che la verità dei fatti era stata alterata e che era stato commesso un abuso del diritto di manifestare il proprio pensiero e del diritto di cronaca, tale da compromettere gravemente la reputazione della banca ricorrente. Pertanto, ricorrevano gli estremi del delitto di diffamazione. Il Tribunale di sottolineò che l'abuso del diritto di cronaca era sanzionabile anche se commesso con Internet, dal momento che il mezzo utilizzato non modificava l'essenza dell'illecito commesso.
75Un altro caso fu quello del Tribunale di Vicenza che ha trattato un caso di diffamazione a mezzo internet come se fosse stampa.
Ma l'orientamento della magistratura non è stato sempre univoco. Ad esempio, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Oristano ha escluso l'estensibilità per via analogica a Internet delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Nelle considerazioni dei giudici sardi si sottolineano gli elementi di specificità dell'informazione online, a partire dalla definizione di stampato contenuta nella legge n.47/48, considerata del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet che avvengono attraverso la collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo della rete telefonica al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer.
Pertanto, Il tribunale di Oristano ha considerato inapplicabili al caso l'Art.13 della legge n.47/48, riguardante la diffamazione a mezzo stampa, e quello che estende la sanzione ai concessionari pubblici e privati e loro delegati. La conseguenza è stata la qualificazione del fatto in questione come diffamazione aggravata, poiché recata con un mezzo di pubblicità assimilato alla diffamazione a mezzo stampa dal III comma dell'Art.595 del Codice Penale. Inoltre, la sentenza afferma a chiare lettere che Internet rientra negli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'Art.595 del Codice Penale e che perciò tale aggravante è pienamente applicabile all'universo telematico.
Da ciò consegue che l'esclusione dello speciale regime della diffamazione a mezzo stampa non comporta automaticamente il venir meno di altre responsabilità, nel nostro caso penali, in capo all'autore di un brano diffamatorio. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è competente il giudice del luogo in cui ha il domicilio la parte che subisce i danni.
In merito all'inapplicabilità per via analogica Internet delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa, c'è chi ritiene che le forme di pubblicazione di notizie via Internet non debbano sottrarsi al regime sanzionatorio della legge n.47/48 e che la rete deve essere considerata elemento qualificante di comunicazione al pari di un giornale scritto o dei media reti televisivi.
Per quanto riguarda la competenza territoriale nelle cause per diffamazione via Internet, bisogna ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale.
Evoluzione giurisprudenziale sulla diffamazione online
Nel 2000, il Tribunale di Lecce ha stabilito che la competenza territoriale spetta al giudice civile del luogo dove si trova il server presso il quale vengono scaricate le pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni diffamanti. Questo criterio è parso ad alcuni ragionevole, tenuto conto che la notizia diviene pubblica per la prima volta nel luogo dove si trova il server.
Sempre nel 2000, la Corte di Cassazione ha allargato le possibilità di intervento su Internet del magistrato italiano anche al caso in cui l'immissione nel web di immagini o frasi lesive della dignità e dell'onore di un cittadino italiano avvenga all'estero.
Secondo i magistrati, se la diffusione dell'informazione lesiva della dignità di un soggetto era avvenuta fuori dai confini dello Stato italiano, anche la consumazione del reato doveva ritenersi avvenuta all'estero e quindi proprio in quel paese può essere avviata l'azione legale. In questo modo viene negata l'esistenza di una potestà punitiva dello Stato italiano.
76Si moltiplicano intanto le sentenze di condanna per diffamazione a partire da contenuti pubblicati su siti online.
In una sentenza del 2008, la Cassazione ha asserito che i requisiti della rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza della forma espositiva devono essere rispettati anche da chi diffonde informazioni tramite Internet. La diffamazione online è considerata un'ipotesi di diffamazione aggravata. È stato poi stabilito nel 2018 che è diffamazione anche pubblicare fotografie di persone su siti Internet visibili a tutti, per cui con diffamazione si intende l'offesa della reputazione del soggetto.
L'idea che Internet aumenti la potenzialità lesiva della diffamazione si sta diffondendo anche presso gli organi giurisdizionali europei: si pensa che l'impatto di una pubblicazione attraverso Internet e di più ampia portata rispetto alla diffusione tramite i mezzi tradizionali come la stampa, ed è quindi giustificato un intervento delle autorità nazionali più incisivo. La Corte europea ha spiegato che il web permette una maggiore accessibilità ai dati e una maggiore conservazione di fusioni di essi: basti pensare che si può inserire il nome di una persona nel motore di ricerca e arrivare ad un articolo collegato ad essa.
Identificazione del colpevole di diffamazione online
Per quanto riguarda l'identificazione del colpevole di diffamazione online, secondo la Cassazione essa può avvenire tramite l'indirizzo IP (che ha la stessa funzione delle impronte digitali) e lo stesso criterio viene impiegato nei casi di diffamazione commessa con i social network come Facebook. La Corte di Cassazione nel 2018 ha dichiarato che per la configurabilità del reato di diffamazione servono delle verifiche specifiche per accertare che l'imputato sia intestatario del profilo social incriminante.
La Corte d'appello di Lecce aveva condannato per diffamazione una donna, che all'epoca svolgeva l'attività di sindacalista, per aver diffuso attraverso Facebook un messaggio offensivo nei confronti di un sindaco del Sud Italia. Il messaggio proveniva da un profilo social con il suo nome e cognome e la discussione del forum in cui era stato postato riguardava i diritti dei lavoratori del comune. La sindacalista, però, sosteneva di non essere l'autrice del post, e che soggetti terzi avessero utilizzato il suo nickname per inviare il messaggio. Le sue argomentazioni sono state accolte, per cui la Cassazione ha annullato la sentenza.
La Cassazione penale ha anche statuito che la diffamazione via social network può configurarsi anche esclusivamente su base indiziaria a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati, quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca attuale dell'imputata con l'utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Viene anche riconosciuta rilevanza all'assenza di denuncia di furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale è avvenuta la pubblicazione del post. In questo caso, risultavano elementi convergenti quali la provenienza del post che indicava il nome dell'imputata, e il fatto che la stessa, venuta a conoscenza del post, non abbia denunciato l'uso improprio del suo nome, prendendo le distanze dalle affermazioni diffamatorie.
I giudici di legittimità hanno evidenziato un ultimo aspetto fondamentale: deve attribuirsi valenza processuale anche al contenuto stesso dei post offensivi, qualora questi richiamino fatti oggettivamente conoscibili da ben poche persone diverse dall'imputato.
Questa è un'importante innovazione perché precedentemente la Suprema Corte aveva statuito che, in tema di diffamazione, la mancata verifica dell'indirizzo IP non consente di 78Ma la Cassazione non ha condiviso questa impostazione, anzi l'ha ribaltata. Innanzitutto, ha considerato la diffamazione online un reato di evento e non di condotta. In particolare, ha sottolineato l'importanza dell'evento psicologico consistente nella percezione da parte del terzo dell'espressione offensiva e, quindi, ha individuato il momento consumativo del reato non nella diffusione del messaggio diffamatorio ma nella sua percezione da parte di terzi. Se un soggetto diverso dall'agente o dalla persona offesa clicca sul sito incriminato e visualizza il contenuto diffamatorio si realizza l'evento psicologico del reato.
Sulla base di questo assunto i magistrati della Cassazione hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'Art.6 del Codice Penale in base al quale il reato si considera commesso nel territorio italiano non solo quando si sia verificata in tutto o in parte l'azione o l'omissione, ma pure quando su di esso si realizzi l'evento che ne è conseguenza.
In un'altra sentenza la Cassazione ha dettato le regole sui danni morali e patrimoniali della diffamazione online e ha stabilito che su questi, provocati da un'offesa lanciata in rete, deve decidere il giudice del luogo in cui la vittima è domiciliata. Pertanto il locus commissi delicti va individuato nel luogo di verificazione dei danni lamentati in conseguenza all'evento diffamatorio, atteso che, essendo la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione.
Anche un'altra sentenza si afferma che il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete: quindi, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Da questa sentenza, che faceva riferimento a un caso di querela in seguito a una pubblicazione di un articolo su un sito web, emerge che l'eventuale registrazione di un sito web all'estero non basta per evitare le indagini in materia di diffamazione e di divulgazione di atti coperti da segreto.
Tutela dei soggetti danneggiati in rete
Due sentenze del 2011 della Corte di giustizia europea ampliano le tutele per i soggetti danneggiati in rete. I danni da diffamazione via web possono essere liquidati da un solo giudice, quello dello Stato dove risiede la persona danneggiata. Se una notizia pubblicata da un sito italiano e riguardante un cittadino italiano viene ripubblicata su un sito estero, la diffamazione è di competenza del giudice italiano. In questo modo chi subisce diffamazione può rivolgersi direttamente ai giudici del proprio stato di residenza o, in alternativa, può chiamare i giudici di ciascuno degli Stati dell'Unione europea nei quali sono stati diffusi i contenuti contestati, ma solo pro quota.
Anche nel 2017 la Corte di giustizia europea ha stabilito che in caso di lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione su Internet di dati inesatti, il risarcimento e la richiesta di rimozione dei commenti da un sito può essere richiesta a un giudice dello Stato membro in cui la persona giuridica ha il principale centro di interessi (considerando la collocazione spaziale delle principali attività commerciali, fatturato e numero di clienti).
Le sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito che nei reati di diffamazione commessa mezzo rete Internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il ruolo il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento deve prevalere su quest'ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile in riferimento al luogo fisico dove viene effettuato l'accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server.
77