Che cos'è l'estetica quotidiana: origini e prospettive europee e angloamericane
Documento dall'Università di Bologna su Che cos'è l'estetica quotidiana. Il Pdf esplora il concetto di estetica, analizzando le sue interpretazioni e applicazioni in vari contesti della vita quotidiana, come il corpo e il cibo, per gli studenti universitari di Filosofia.
Ver más13 páginas
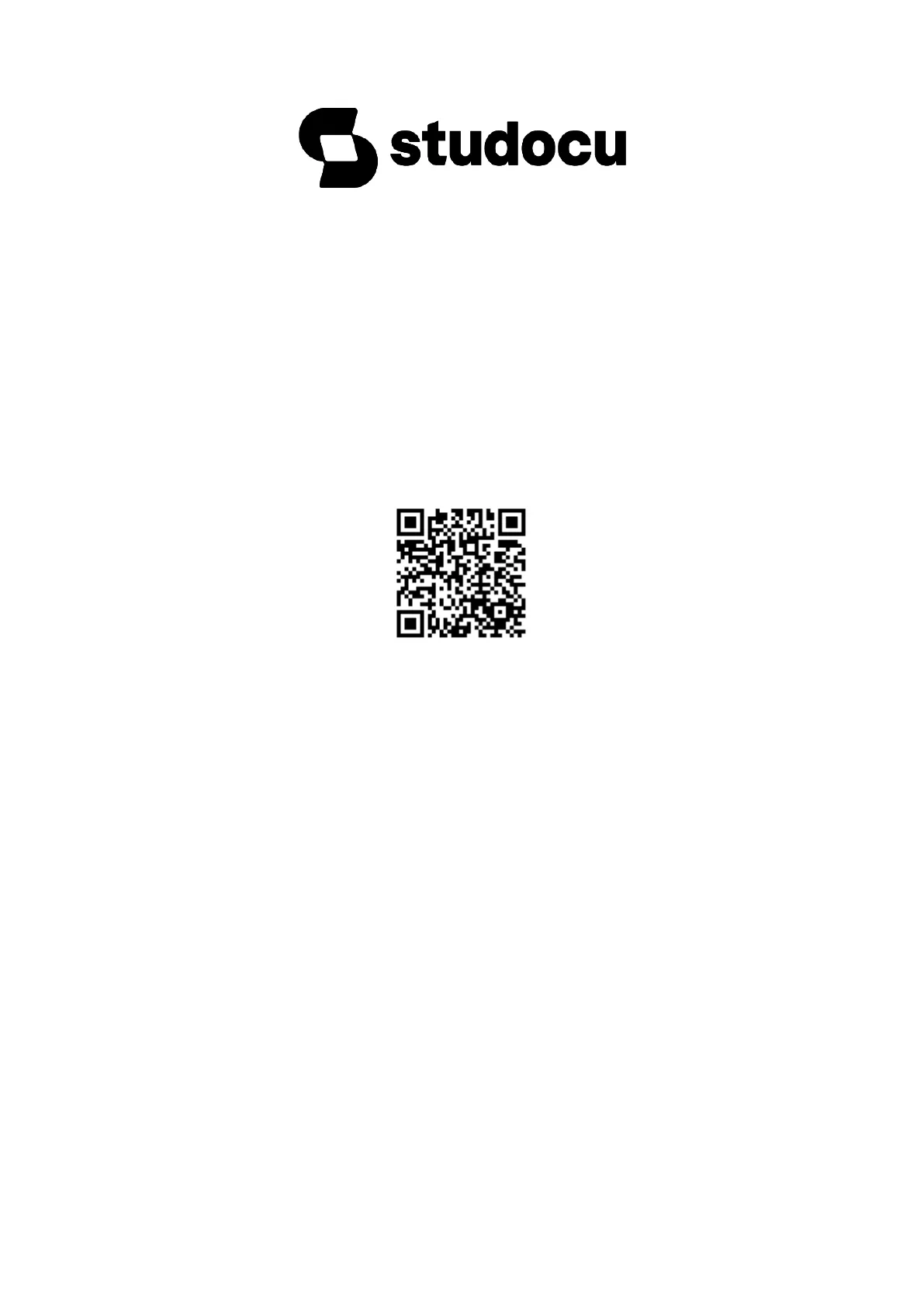

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Che cos'è l'estetica quotidiana
DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Università di Bologna) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da isabella (caffeinbiblioteca@gmail.com)Che cos'è l'estetica quotidiana, Elisabetta Di Stefano
Introduzione all'estetica della quotidianità
L'estetica come branca della filosofia riguardante l'arte e il bello ha da sempre avuto un ruolo importante in molte culture. Tuttavia, oggi l'equazione tra estetica e arte è tendenzialmente superata a favore di nuovi ambiti d'indagine e di pratiche della quotidianità. Il testo tratta infatti l'estetica della quotidianità, la quale può essere vista da punti diversi. In Europa, ad esempio, si tende a esplorare l'estetica della quotidianità nell'ambito dell'esteticità diffusa, indagando gli stili di vita, la pervasività delle immagini, il design o la cultura popolare. Nel mondo angloamericano, invece, troviamo più chiavi di lettura (spesso collegate alle ricerche europee) che tendono a ripensare il ruolo dell'arte e dell'estetica nell'educazione e nell'azione. Secondo questo approccio, se si riesce a tenere congiunta l'estetica alla morale e all'impegno, essa può avere una grande forza propulsiva nel migliorare la realtà che ci circonda, perchè sono proprio le considerazioni estetiche a spingerci a rendere il mondo più umano, la società più giusta e il futuro più sostenibile.
Un'altra estetica: definizione e sviluppo storico
Definire il termine "estetica" oggi appare particolarmente complesso poiché nel corso del tempo sono stati sviluppati diversi modi di intendere questa disciplina. Ma cos'è esattamente l'estetica? Baumgarten nel Settecento elabora una teoria che vede l'estetica come un "sapere sensibile" e che porta alla sua fondazione come disciplina accademica. Egli utilizza infatti nel 1735, in un breve saggio sul testo poetico, la parola Aesthetica per la prima volta. Questa parola deriva dal greco aisthesis ("sensazione"), e vuole indicare la scienza che si occupa delle cose sensibili, comprese quelle che sono frutto dell'immaginazione poetica. In un panorama culturale in cui le percezioni e le sensazioni erano svalutate rispetto ai processi razionali e considerate prive di dignità filosofica, Baumgarten afferma che accanto alla logica, la quale è una guida alla verità, vi deve essere, con pari dignità filosofica, una "scienza che guidi la facoltà conoscitiva inferiore ossia la scienza della conoscenza sensibile in senso lato" (impianto gnoseologico). Quest'idea di Baumgarten viene sviluppata nel corso della seconda metà del Settecento ma finisce in disuso il termine "estetica", e entrano a far parte della conversazione temi quali il gusto, l'arte e il bello. E' così che in pochi anni l'estetica si trasforma da teoria della sensibilità in filosofia dell'arte. Questa chiave ermeneutica si afferma soprattutto con l'idealismo romantico, tant'è che Schelling sancisce una nuova disciplina che si chiama proprio Filosofia dell'arte. Anche Hegel, a inizio Ottocento, definisce l'oggetto dell'estetica il bello, il cui campo è l'arte o, più propriamente, la bella arte. Hegel bandisce così dall'estetica la riflessione sulla natura e allontana la bellezza artistica da quella della vita quotidiana. Questa riduzione dell'estetico all'artistico porta all'affermazione dell'art pour l'art (arte per l'arte, arte in quanto arte), paradigma universale ed eterno. Questa teoria si consolida soprattutto nella Francia del XIX secolo, anche grazie alle riflessioni di Victor Cousin e Théophile Gautier, i quali ritenevano che l'arte dovesse essere autoreferenziale e atemporale, quindi slegata da valori morali, politici o sociali. (L'esclusione della natura e dell'arte di massa ha portato allo sviluppo di un dibattito sull'Environmental Aesthetics, sulla Popular Culture e sull'Everyday Aesthetics). La professionalizzazione dell'arte divide ancora di più artista e pubblico poiché ci si misura solo con un livello professionale di pratica artistica e, nel momento in cui le aspettative sono così alte, diventa sempre più difficile praticare arte.
Confronto tra Baumgarten e Kant sull'estetica
Fortemente in contrasto con le idee di Baumgarten è Kant, il quale vede come inammissibile la promozione dell'estetica a dignità scientifica, poiché non fornisce regole a priori per determinare il giudizio come fa la logica, ma trae le proprie regole a posteriori. Tuttavia nella Critica della ragion pura, Kant si avvicina alle idee di Baumgarten poiché intitola un capitolo "Estetica trascendentale" per indicare la "scienza dei principi a priori della sensibilità". Così, sia per Baumgarten che per Kant, l'estetica è una dottrina che si occupa degli elementi sensibili, mentre la logica si occupa di quelli razionali.
L'estetica come teoria della sensibilità: sviluppi recenti
Il termine acquista notorietà in Gran Bretagna a metà dell'Ottocento grazie all'Estetismo, un This document is available on studocu Scaricato da isabella (caffeinbiblioteca@gmail.com)movimento artistico-letterario che basa l'esperienza del bello sulla sfera dei sensi, mentre in Italia si afferma con l'Estetica (1902) di Benedetto Croce, che ripropone la distinzione tra conoscenza logica e intuizione sensibile. Negli ultimi decenni si è riaffermata l'idea dell'estetica come teoria della sensibilità sia nella filosofia europea continentale che nel pragmatismo americano. In Italia, una figura importante per questo processo è Emilio Garroni, il quale ha dichiarato che l'estetica deve essere intesa come filosofia del "senso", ovvero una conoscenza "sentita" e non appresa intellettualenente. In Germania invece, troviamo le figure di Wolfgang Welsch e Martin Seel (per Seel l'estetica riguarda la conformazione sensibile di un oggetto percettivo). Altro contributo fondamentale è stato dato da Gernot Böhme, il cui volume Aisthetik rimarca il fondamento percettivo dell'estetica, ribadito anche dal sottotitolo Estetica come teoria generale della percezione sensibile. Con quest'opera Böhme include nell'orizzonte teorico sull'estetica una dimensione pratica, già presente nel volume di Baumgarten ma prima d'allora mai sviluppata. Un altro teorico a trattare questa dimensione pratica è Richard Shusterman, il quale presenta una posizione unica nel dibattito angloamericano del Novecento. Egli propone un'analisi somaestetica, la quale vuole superare i confini della speculazione accademica per orientare l'indagine in senso pragmatico. Per questo avvia una riconsiderazione in chiave filosofica di alcune pratiche corporee (cosmetica, chirurgia estetica, ginnastica, yoga, ecc.) dove il corpo può diventare espressione di creatività e sede di fruizione estetico-sensoriale.
Estetica analitica e distinzione tra arte e non-arte
Nonostante la vasta affermazione del campo della filosofia dell'arte, si hanno anche vari sostenitori dell' "estetica analitica", ovvero quell'orientamento teorico sviluppatosi nella seconda metà del Novecento volto a distinguere ciò che è arte da ciò che non lo è. Questo approccio prende spunto dalla Pop Art e dall'arte concettuale per evidenziare l'insufficienza dell'esperienza percettiva nella distinzione dell'oggetto artistico da quello comune e ha privilegiato gli aspetti cognitivi o istituzionali, ovvero l'atteggiamento che assumiamo nei confronti di un'opera in base a ciò che sappiamo o in base alla considerazione datagli dagli organi istituzionali.
Evoluzione del concetto di bellezza e arte
La bellezza è oggi il significato più comunemente attribuito al termine "estetica", dunque è importante esaminare come si è sviluppata la nozione di bellezza e il concetto di arte (bella). La questione della bellezza è una questione ricorrente in ambito filosofico fin dalle origini. In alcuni dialoghi platonici ad esempio troviamo una concezione di bellezza non legata all'arte, così come Aristotele nella Poetica usa una sola volta il termine "bellezza, e in entrambi i casi il termine aveva un significato molto più ampio rispetto a quello attuale, infatti la bellezza era intrecciata con la metafisica (mondo delle idee, la verità, le leggi) e l'etica (le azioni, i comportamenti). La dottrina neoplatonica, poi, interpreta la bellezza come una luce che risplende con un'intensità proporzionale al grado di purezza. Mentre il concetto di bello veniva spesso declinato spiritualmente, quello di arte assumeva il significato di "tecnica". Dalla cultura classica a quella rinascimentale, con arte si intendeva un sapere sistematico fondato su regole e che quindi abbracciava una svariata gamma di discipline pratiche e teoriche (matematica, eloquenza, agricoltura). Nella tarda antichità tutte queste arti vennero divise in due branche: le artes liberales, le quali erano coltivate dagli uomini che potevano dedicarsi allo studio e comprendevano discipline matematiche e letterarie; e le artes vulgares, le quali includevano tutte le attività praticate dalla gente comune che doveva esercitare un mestiere per vivere. Questa concezione del bello è ben lontana dalla nozione moderna di belle arti. Infatti, i primi segni di una relazione tra arte e bellezza vengono manifestati a partire dal Rinascimento. Leon Battista Alberti ad esempio sottolinea per ciascun delle arti figurative il nesso con la bellezza. Nel corso della storia i concetti di arte e bellezza si sono intrecciati sempre più spesso. Questo percorso culmina nel Settecento quando Charles Batteux definisce il moderno sistema delle arti e la bellezza diventa caratteristica principale di queste pratiche, che non producono utilità ma piacere. La cultura romantica elaborerà poi l'idea che il bello trova riscontro solo in un'esperienza estetica di contemplazione disinteressata. Questa categorizzazione verrà meno solo a partire dall'Ottocento con la nascita di nuove categorie Scaricato da isabella (caffeinbiblioteca@gmail.com)estetiche come il sublime o il brutto, e soprattutto è col Novecento che viene meno il nesso arte- bellezza per via del nuovo panorama artistico. Ciononostante, la bellezza resta una chiave di lettura privilegiata per capire l'estetizzazione del reale la riflessione filosofica è ricca di incontri tra cultura alta e popolare, tra l'arte e l'esperienza quotidiana.
L'esperienza e la quotidianità nell'estetica
L'esperienza è intrinsecamente legata alla teoria della sensibilità, poiché si esperisce attraverso i sensi, tuttavia non collegata alla filosofia di Baumgarten. A questo proposito John Dewey cerca di portare le arti fuori dai canoni tradizionali per concentrarsi sul concetto di esperienza. In Arte come esperienza, Dewey estende ulteriormente l'orizzonte dell'estetica alla vita quotidiana e individua nell'arte un'occasione privilegiata ed esemplare del fare esperienza, poiché nella fruizione dell'arte le emozioni convergono in un'esperienza unitaria, compiuta e piena. Dewey però non considera l'arte come una prassi necessariamente artistica. Questa sua visione ha aperto le porte a discussioni più ampie sui campi esclusi dall'estetica tradizionale (natura, cultura di massa, quotidianità) soprattutto da parte di teorici americani che si contrappongono all'estetica intesa come filosofia dell'arte.
La quotidianità nella filosofia e nella sociologia
La quotidianità è stata relegata dalla cultura e dalla filosofia nella sfera dell'irrilevante e, quando riesce ad essere oggetto di una qualsiasi riflessione, è generalmente sublimata o trasfigurata, perdendo così la sua caratteristica principale ovvero l'essere "senza qualità". Infatti i filosofi tendono o a cercare di superare la quotidianità per innalzarsi alla vita dello spirito, oppure cercano di redimerla. Questa visione negativa del quotidiano è dovuta alla storica svalutazione del mondo terreno e delle attività produttive. Si tratta di una prospettiva che divide la vita su due livelli, uno inautentico e basso della vita terrena, e l'altro autentico e trascendente dove l'uomo ritrova la spiritualità e la verità; così si dimentica che l'uomo è al contempo materiale e spirituale e che quindi la vita è un costante mescolamento dei due livelli. In questa visione ciò che manca è, secondo il sociologo francese Henri Lefebvre, "il sentimento della quotidianità", fenomeno distintivo della modernità. Infatti sono le nuove condizioni socioeconomiche a rendere possibile una riflessione critica sulla quotidianità. La modernità, infatti, con la nascita delle metropoli e del lavoro industriale, ha dato avvio a una concezione del tempo lineare, in cui ogni giorno è uguale all'altro, contrapposto al tempo ciclico delle società rurali. Il tempo ciclico legato alle stagioni è una ripetizione connessa con la creazione, poiché nessun ciclo riproduttivo ritorna allo stesso punto esatto.
La quotidianità in Freud, Heidegger e Marx
La vita quotidiana diventa categoria del pensiero solo con Sigmund Freud (Psicopatologia della vita quotidiana), il quale coglie nell'apparente ordinarietà e inesattezza della vita, le radici del perturbante e della follia. Su questa linea si pone anche Martin Heidegger, il quale con Essere e tempo segna l'ingresso ufficiale del quotidiano nella filosofia del Novecento, infatti per lui non esisteva alcuna realtà diversa da quella di tutti i giorni (anche se poi Heidegger trascenderà il quotidiano in nome di un'esistenza sublimata). La filosofia marxista invece, relega la quotidianità nella sfera dell'inautenticità e dell'alienazione in quanto associata al denaro e alla mercificazione.
Il contributo di Lefebvre all'estetica della quotidianità
E' appunto Lefebvre a introdurre delle chiavi di lettura che segnano la svolta nel modo di considerare la quotidianità e che possono essere applicate anche all'interno dell'estetica. Egli afferma che il lavoro filosofico rientra nel quotidiano, così come anche i lavori dello scienziato e dell'artista, pur essendo professioni non comuni, comprendono esercizi e pratiche ripetitive e sono spesso legate a codici istituzionali e sociali che le ancorano alla quotidianità. (Questa visione è stata ripresa nell'Everyday Aesthetics per mettere in rilievo come alcune attività generalmente considerate eccezionali abbiano elementi di routine, dimostrando che la differenza tra attività intellettuali/straordinarie e pratiche quotidiane è solo una questione di punti di vista). Lefebvre adotta una chiave di lettura antropologica per la quale tutte le attività dell'uomo sono un tentativo di uscire dallo stato di natura. La teoria di Lefebvre ha anche conferito valore positivo alla ripetitività che è la cifra della quotidianità. Infatti il sociologo ritiene che non c'è novità se non in relazione a qualcosa che è già dato e che ritorna mutato. Così apre la strada alla possibilità di cogliere "lo straordinario nell'ordinario" che è uno dei modelli teorici dell'Everyday Aesthetics. This document is available on studocu Scaricato da isabella (caffeinbiblioteca@gmail.com)