L'autodisciplina pubblicitaria in Italia: contesto normativo e contenzioso
Documento dall'Università degli Studi Dell'insubria sull'autodisciplina pubblicitaria in Italia. Il Pdf esplora il contesto normativo europeo, la nascita del sistema italiano e il ruolo dell'IAP, analizzando il contenzioso autodisciplinare e i ricorsi relativi alle regole di comportamento e alle norme particolari del codice, utile per studenti universitari di Diritto.
Mostra di più29 pagine
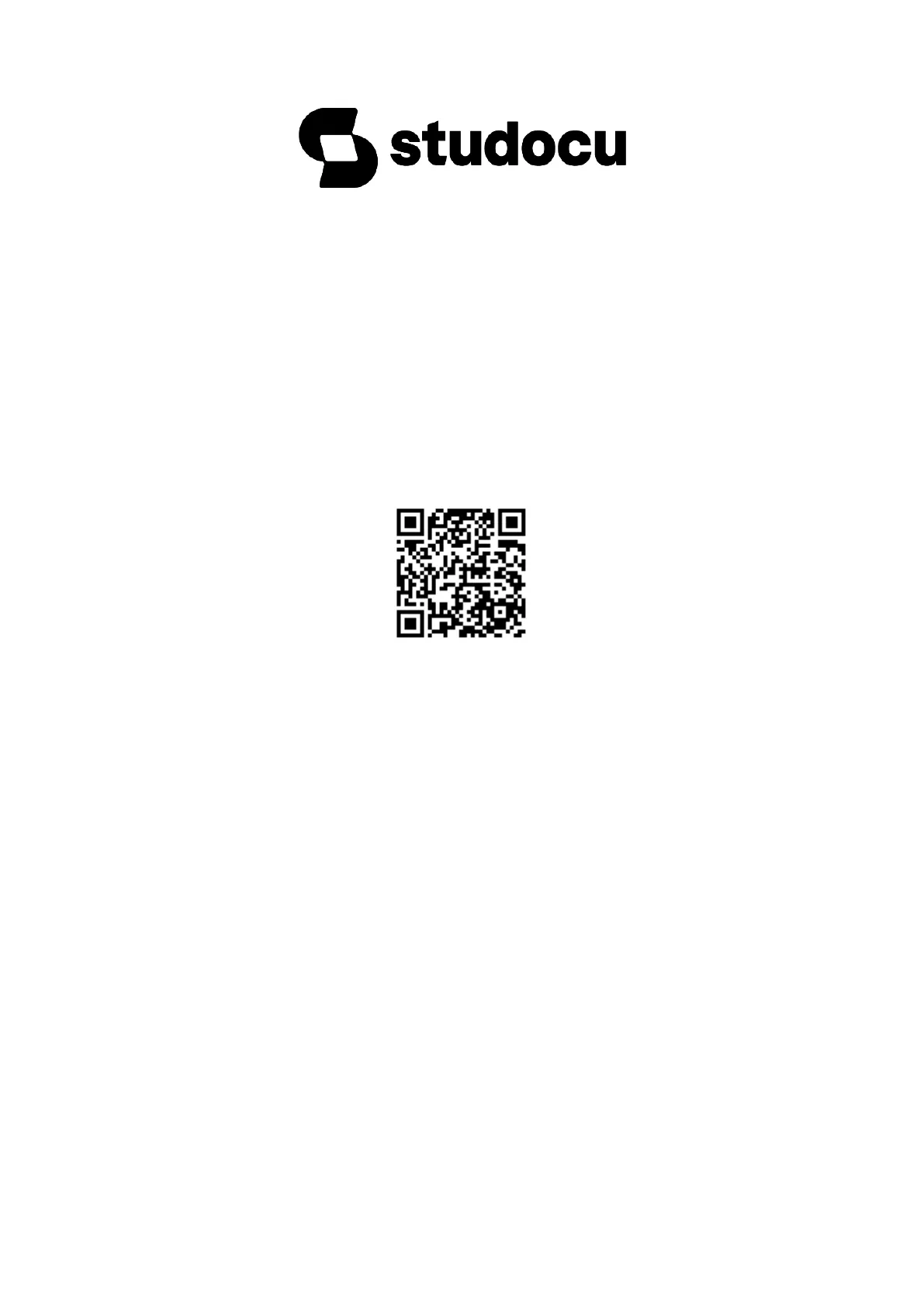

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
L'Autodisciplina Pubblicitaria in Italia
Diritto della pubblicità, della moda e degli influencer (Università degli Studi dell'Insubria) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Greta Pagani (sq6gw8c878@privaterelay.appleid.com)
L'AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA IN ITALIA
Autodisciplina pubblicitaria e pluralismo normativo
Il favor del legislatore europeo verso l'autoregolamentazione
Nel 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stipulato l'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", sottolineando l'opportunità di integrare l'attività legislativa con "meccanismi di regolamentazione alternativi". Si cercava di: › Bilanciare la necessità di linee guida uniformi › Flessibilità nell'attuazione pratica delle norme
A L'esigenza di abbandonare un approccio strettamente verticistico alle regole -> promuovendo la consultazione e il dialogo con le parti interessate. L'uso di questi strumenti alternativi non avrebbe dovuto compromettere i principi fondamentali del diritto comunitario né le prerogative dei poteri legislativi. Si dedicava particolare attenzione ai meccanismi di co-regolamentazione e autoregolamentazione. La distinzione tra autoregolamentazione e co-regolamentazione è basata sul grado di autonomia e controllo dei soggetti interessati nel definire le regole:
- Autoregolamentazione -> soggetti hanno completa autonomia nello stabilire le linee guida per le proprie azioni. L'autoregolamentazione pura sembra essere più un'alternativa, pur mantenendo coerenza con gli obiettivi generali del sistema giuridico
- Co-regolamentazione -> il legislatore fissa un quadro normativo di riferimento che specifica obiettivi, tempi, modalità di controllo ed eventuali sanzioni. Richiede un atto legislativo preliminare ed è complementare alla legislazione.
Nel 2015, il Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea criticò l'assenza di un quadro giuridico generale nell'Accordo del 2003 per l'uso di meccanismi alternativi alla legislazione. Il Comitato sottolineava che tali strumenti non dovrebbero essere considerati rigidamente come "soft law" e che la regolamentazione privata dovrebbe essere vista come uno sviluppo o un'applicazione della regolamentazione pubblica, non come alternativa. L'efficacia di questi strumenti, secondo il Comitato, dipende essenzialmente dalla collaborazione tra parti interessate, poteri pubblici e società nel complesso. In un contesto specifico, l'autoregolamentazione, che in alcuni casi si è evoluta in forme di co- regolamentazione, ha dimostrato particolare efficacia nel campo della comunicazione commerciale.
La nascita dell'autodisciplina della pubblicità in Italia. La "relazione di Ischia" del 1963
Durante il VII Congresso nazionale della pubblicità avvenuto ad Ischia fra il 3 e il 6 ottobre 1963, Roberto Cortopassi, esperto in comunicazione e allora a capo dell'associazione dei professionisti nel settore pubblicitario, presentò una relazione sulla responsabilità della pubblicità verso i consumatori. La relazione descriveva il cambiamento nel settore pubblicitario dopo la Seconda Guerra Mondiale, evidenziando la crescita economica e l'influenza delle agenzie di advertising americane e inglesi in Italia. Le aziende italiane stavano riconoscendo la pubblicità non solo come strumento informativo, ma anche come elemento di competizione. Questo periodo vide la formazione di un nuovo ambito professionale, con la creazione di associazioni e imprese specializzate come la UPA (Utenti Pubblicità Associati) e la FIP (Federazione Italiana Pubblicità). This document is available free of charge on studocu Scaricato da Greta Pagani (sq6gw8c878@privaterelay.appleid.com)
Negli anni '60, l'industria pubblicitaria italiana era considerata matura economicamente, e lo sviluppo dei media di massa, in particolare la televisione, offriva opportunità di crescita. La pubblicità inizia ad essere criticata per le tecniche di marketing, accusate di privilegiare la persuasione a discapito dell'informazione, manipolando i desideri dei consumatori. Tale manipolazione veniva vista come una minaccia alla libertà di scelta dei consumatori, rendendoli vulnerabili alle strategie dei produttori. Roberto Cortopassi riconosceva i possibili effetti distorti della pubblicità, ma criticava l'eccessiva attribuzione di responsabilità a questo strumento. Lui vedeva la pubblicità non come creatrice di bisogni, bensì come strumento per intercettare le esigenze della collettività e proporre soluzioni. Sembrava che il problema principale riguardasse l'immagine della pubblicità, sottolineando la necessità di sviluppare strumenti per proteggere sia i produttori che i consumatori da promozioni sleali. Si cercava di trovare un giusto equilibrio tra lo stimolo dei consumi sociali e quelli "irrazionali". Cortopassi riconosceva la necessità di regole di "gestione" della pubblicità che salvaguardassero il consumatore. Era però difficile come svilupparle, perché eccessivamente drastiche potevano compromettere la creatività della pubblicità, ma dall'altra parte delle raccomandazioni senza sanzioni non funzionavano. Nel panorama giuridico italiano, esistevano disposizioni per proteggere i consumatori dalla pubblicità scorretta, anche se limitato a norme riguardanti prodotti sanitari, dietetici, e prima infanzia, ma erano poco conosciute e applicate raramente. In generale, la protezione del consumatore veniva in parte garantita dall'art. 2598 del Codice civile, che identificava atti di concorrenza sleale. Mira a impedire che un'impresa ottenga vantaggi nel mercato attraverso metodi contrari ai principi dell'etica commerciale.
- 1º comma -> atti di concorrenza sleale, quali quelli idonei a creare confusione tra marchi o segni distintivi.
- 2º comma -> Denigrazione di prodotti di un concorrente o si traducono nell'indebita appropriazione dei pregi dei prodotti di un'impresa concorrente.
- 3º comma -> Copre atti non conformi ai principi della correttezza professionale che possono danneggiare altre aziende.
La necessità di regole nella pubblicità porta tra il 1951 e il 1952, sia l'UPA che la FIP a creare propri "codici morali" per la pubblicità, ma questi non erano considerati sufficientemente efficaci, essendo visti come espressione di valori corporativi. Anche i mezzi di comunicazione avevano strumenti di controllo, ma erano conosciuti principalmente dagli addetti ai lavori. Cortopassi propone quindi l'idea di sviluppare un sistema di autocontrollo elaborato dagli operatori del settore. Ciò avrebbe potuto superare le resistenze contro regole imposte dall'alto e favorire la comprensione dei principi generali da parte dei professionisti, garantendo la correttezza e la lealtà della pubblicità per proteggere efficacemente i consumatori. Suggeriva inoltre di creare "poche e chiare norme", richiamando il principio internazionale presente nel Codice delle pratiche leali in materia di pubblicità del 1937 della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
1966: il codice della lealtà pubblicitaria
La relazione di Ischia è considerata il primo passo ufficiale nel dibattito sulla regolamentazione della pubblicità, culminato nell'adozione del Codice della lealtà pubblicitaria nel maggio 1966. Questo Codice rappresenta un esempio chiaro di autoregolamentazione nel contesto legale italiano. La sua nascita è stata guidata dalla convergenza di intenti tra rappresentanti delle categorie professionali del settore e dei mezzi di comunicazione, tra cui l'UPA, la FIP, la RAI e la Federazione italiana degli editori di giornali. Il Codice ha colmato un vuoto legislativo, intervenendo in un campo di attività in crescita dove lo Stato non aveva ancora definito una disciplina efficace. Scaricato da Greta Pagani (sq6gw8c878@privaterelay.appleid.com)
Nella relazione, Cortopassi ha delineato le linee guida del Codice, che derivano dai principi della Camera di Commercio Internazionale (ICC). Questi principi includono la tutela della verità, del buon gusto e dell'onestà nei messaggi promozionali. Un elemento peculiare del Congresso di Ischia è stato la configurazione di un sistema di autoregolamentazione basato su un "controllo a più stadi" realizzato dalle stesse categorie interessate. Ognuna di esse si impegnava a rispettare le linee guida del Codice, contribuendo con la propria prospettiva nella valutazione della pubblicità, considerando il contesto, l'oggetto, la terminologia e i mezzi espressivi e di diffusione utilizzati. Cortopassi aveva auspicato "poche e chiare norme", e la prima versione del Codice della lealtà pubblicitaria risultò concisa: 19 articoli che definivano le finalità e la struttura del sistema di autodisciplina. Copriva le regole per la tutela dei consumatori e la gestione dei rapporti tra gli operatori del settore. Il termine 'messaggio' veniva ampiamente interpretato, includendo pubblicità, propaganda e persino imballaggi. Il rispetto del Codice era affidato a due organi: il Giurì e il Comitato di accertamento.
- Il Giurì -> composto da nove membri, garantiva l'imparzialità e rappresentanza equilibrata delle categorie coinvolte.
- Il Comitato di accertamento -> proposto dal Comitato interfederale della pubblicità, aveva il compito di istruire le cause, rappresentare i consumatori e formulare pareri.
I compiti del Giuri, secondo gli articoli 9 e 10, che consistono nell'esaminare comportamenti contrari al Codice e nel farli cessare. I suoi compiti includevano: A L'esame dei fatti contrari al Codice > L'invito a cessarli entro un certo termine A L'ordine di divulgare la decisione su organi di stampa o altri mezzi di informazione. Tuttavia, il Giurì non aveva il potere di irrogare multe o sanzioni pecuniarie, ma solo di inibire la prosecuzione dei comportamenti contrari al Codice. L'approccio teorico di Max Weber alla legittimità di un ordinamento normativo e sostiene che il sistema di autodisciplina pubblicitaria è emerso da una maturazione delle categorie coinvolte. Questo sistema si è basato sull'assunzione di responsabilità verso i consumatori per rafforzare l'affidabilità della pubblicità. Le forze che lo hanno creato hanno avuto un interesse esterno, consentendo al Codice di avere una dimensione legittima e vincolante, non basata su un'autorità verticale, ma su una relazione orizzontale tra categorie professionali. Questa caratteristica ha garantito l'efficacia del sistema nel tempo, anche senza sanzioni coercitive tradizionali, come evidenziato nella relazione di Cortopassi.
La pubblicità tra deontologia e diritto ufficiale
Le prime riforme dell'Autodisciplina: verso un sistema semi-autonomo
Dopo l'approvazione del Codice della Lealtà, è emersa la necessità di un impegno più forte, riconoscendo che la scarsa efficacia di altri codici etici nel settore pubblicitario derivava dalla loro unilateralità. Era essenziale che il Codice non fosse visto solo come uno strumento di tutela esclusiva. L'autodisciplina pubblicitaria, inizialmente vista come un insieme di regole etiche separate dalle leggi, ha subito cambiamenti significativi per allinearsi a una prospettiva più ampia. La sua evoluzione ha risposto all'esigenza di non essere percepita come un mezzo di tutela esclusivo per agenzie e imprese pubblicitarie, ma di manifestare esplicitamente l'intenzione di difendere anche gli interessi dei consumatori. Le prime modifiche al Codice della Lealtà hanno incluso una revisione della premessa nel 1971, evidenziando che la pubblicità aveva uno scopo di "informazione del consumatore". Questo This document is available free of charge on studocu Scaricato da Greta Pagani (sq6gw8c878@privaterelay.appleid.com)