Legislazione primaria e secondaria in tema di integrazione scolastica, Appunti
Documento dall'Università di Cassino e del Lazio Meridionale su legislazione primaria e secondaria in tema di integrazione scolastica. Il Pdf, di Diritto per l'Università, esplora la centralità della persona e il diritto all'istruzione per tutti i minori, inclusi gli stranieri, evidenziando l'integrazione come valore intrinseco.
Mostra di più35 pagine

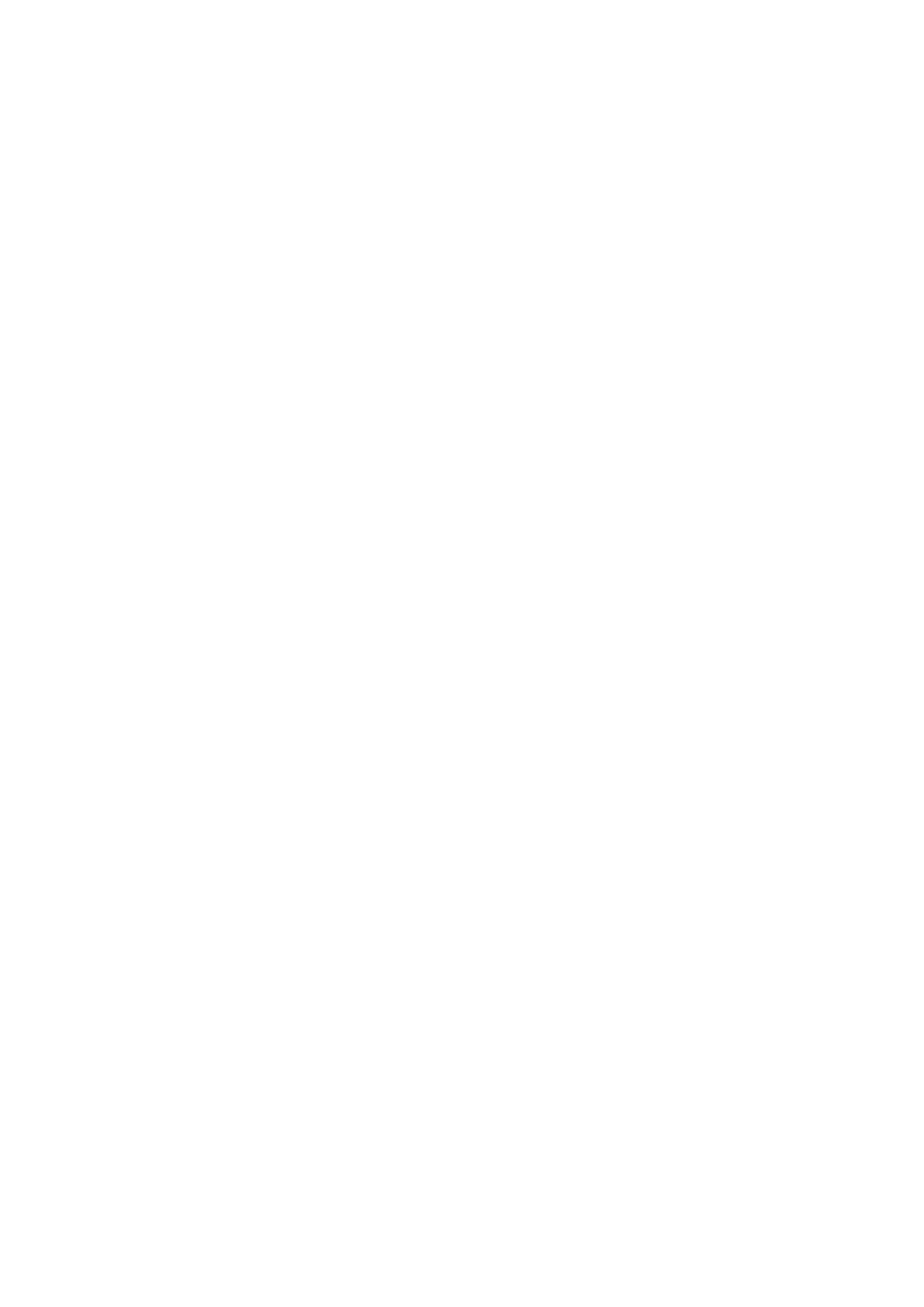
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Corso di specializzazione Sostegno Resp. Prof. G. Arduini Modulo: "Legislazione primaria e secondaria in tema di integrazione scolastica" Titolari del modulo: Prof.ri V. Baldini - M. Plutino
Prima Lezione
*I seguenti appunti hanno una funzione meramente didattica e di ausilio alle prove di valutazione dei discenti.
1La scelta fondamentale dell'Assemblea Costituente fu quella di dare centralità alla persona umana e allo sviluppo della sua personalità, in netta contrapposizione al regime fascista dove l'individuo era per lo Stato e non viceversa, secondo la concezione dello Stato etico propugnata da Gentile. Invece la nostra Costituzione pone a base del sistema repubblicano nato nel 1946 la dignità, per quanto la parola in questione sia menzionata in Costituzione solo tre volte (artt. 3, 36 e 41 Cost.). La centralità della persona umana deriva dal principio della sovranità popolare, cioè dal carattere democratico, che impone di considerare gli interessi e i bisogni dell'intero corpo sociale, a partire dall'affermazione della pari dignità sociale: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale" dice in apertura l'art. 3 Cost. volendo intendere, sinteticamente, che ogni persona ha eguale valore. Se nella logica della democrazia il possesso dei diritti politici spetta a tutti gli individui maturi ma richiede, tendenzialmente, lo status di cittadino, esistono altri diritti che dalla fondazione personalistica dell'ordinamento che essendo coessenziali alla persona umana, e non solo al cittadino, spettano a chiunque. Non anche solo allo straniero, per esempio, ma in alcuni casi anche allo straniero che è entrato o permane in modo irregolare nel territorio italiano. Un soggetto che, per certi aspetti, altri appare ancora più bisognoso di tutele, ben oltre gli aspetti correlati alla salute, all'assistenza, dunque all'urgenza della sua condizione. Premesso che non tutti i diritti spettano a tutti, ovviamente, ma che alcuni diritti spettano a tutti, altri solo ad alcune categorie di soggetti, faremo un solo esempio, relativo al campo dell'istruzione, piuttosto eloquente.
Diritti dei Minori Stranieri
I minori presenti in Italia sono soggetti all'obbligo scolastico ed anzi hanno diritto all'istruzione - un diritto-dovere - a prescindere dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Lo stabilisce l'art. 38 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 45 comma 1 del DPR 394/ 1999 (Regolamento attuativo T.U. Immigrazione), il quale all'articolo 6, co. 2 esclude esplicitamente che l'esibizione del permesso di soggiorno possa essere richiesto per ottenere le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie (sia cioè un cd. onere, un sacrificio per ottenere un vantaggio; sul punto anche la circolare n. 375 del 25 gennaio 2013). La giurisprudenza ha qualificato come discriminatoria 2rispetto ai cittadini italiani, e pertanto illegittima, la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione scolastica. Ma anche per l'iscrizione e la frequentazione della scuola dell'infanzia, che fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione della Repubblica, e concorre allo sviluppo della personalità del minore, non è necessario né può essere richiesto di esibire il permesso di soggiorno. La tutela della persona arriva al punto che ne godono di riflesso anche i genitori i quali, irregolari, se privi di titolo per restare in Italia potrebbero essere in assenza di impedimenti (es. diritto di asilo) allontanati dal territorio. Senonchè ne deriverebbe, come è evidente, un sicuro nocumento per il minore, che potrebbe essere anche grave. Alla luce di ciò, ecco che il Decreto Legislativo n. 286/1998 consente ai suddetti genitori del minore irregolare, irregolari a loro volta, di chiedere una temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia previa dimostrazione che l'allontanamento possa essere fonte per il minore di un danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave. Con recente sentenza, 12 giugno 2019, n. 15750, la Cassazione ha chiarito che tale autorizzazione non deve presuppone necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo, ma si presta a ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto1.
Valutazione del Danno per il Minore
Il danno può essere anche solo potenziale, e va valutato in relazione a diversi elementi: età del minore, grado di radicamento della famiglia nel territorio nazionale, durata del soggiorno, prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di 1 Ovviamente un minore irregolare può essere più difficilmente intercettabile dalle strutture pubbliche, ma questa è tutt'altra questione. Per quanto riguarda i genitori di minori italiani o stranieri regolarmente residenti sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, con forme di responsabilità anche penale in particolare per l'evasione dell'obbligo dalle elementari con un'ammenda fino a 10.000 €. Non sono invece previste specifiche sanzioni a carico dei genitori per l'evasione dell'obbligo in altri cicli. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i comuni di residenza e, nella quotidianità, i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritte le alunne e gli alunni. E' chiaro, in conclusione, che le norme sull'evasione scolastica e in teoria perfino sulla responsabilità genitoriali si possono applicare nella misura in cui il minore irregolare sia venuto a contatto con una struttura pubblica o assistenziale, tale che la sua posizione sia emersa. 3rimpatrio dei medesimi o di uno solo di essi, difficoltà di adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione il radicamento (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2015, n. 25419; Cassazione, sentenza del 3 agosto 2017, n. 19433).
Diritti Inviolabili e Formazioni Sociali
L'articolo 2 Cost. della Costituzione infatti parla di "diritti inviolabili" della persona, strettamente collegati ai "doveri inderogabili". Questi diritti inviolabili spettano all'individuo come anche alle formazioni sociali, ma in quanto spettano all'individuo ne è titolare anche all'interno delle formazioni sociali ed eventualmente contro di esse (si pensi alla famiglia, in cui i genitori hanno poteri e diritti, ma anche obblighi e hanno limiti nei confronti dei figli). E formazione sociale, diciamolo subito, è anche la scuola, come lo è la sua base sociale, la cosiddetta "comunità scolastica".
Stato Sociale e Soggetti Fragili
La nostra Costituzione, d'altra parte, dà forma a uno "stato sociale", quindi - come vedremo meglio in seguito - ad una organizzazione statale dove ci sono interventi promozionali intestati ai pubblici poteri, generalmente alla "Repubblica". Per tale ragione ricevono un'esplicita considerazione una serie di soggetti considerati fragili, deboli, sfavoriti, comunque bisognosi di particolare attenzione alla luce della precedente esperienza fascista, ma anche di quella liberale. Anche in tale caso si ha in genere una estensione oltre il limite della cittadinanza, ma la situazione è variegata diritto per diritto. Tra questi soggetti tutelati in modo rafforzato figurano sicuramente i minori (come si è visto) e, diremmo con terminologia moderna e sconosciuta alla Costituzione, i disabili. A proposito della terminologia, su cui torneremo in seguito, basterà qui anticipare che per esprimere un concetto riconducibile in tutto o in parte alla disabilità la Costituzione offre, accanto a disposizioni di carattere generale, alcune disposizioni espresse - a fini di apprestare tutele nel lavoro e assistenziali - che usano qualificazioni giuridiche come "invalidi", "mutilati", "malati" (o loro declinazioni) e così via.
Principio di Eguaglianza
A questo punto incontriamo fatalmente il tema dell'eguaglianza. Anzi l'abbiamo già incontrato quando in precedenza abbiamo richiamato una giurisprudenza che parlava, vietandole, di discriminazioni per il minore straniero (magari irregolare) rispetto a 4quello italiano. Successivamente alla proclamazione del carattere repubblicano, democratico, della sovranità popolare e dei diritti inviolabili e doveri inderogabili, troviamo l'articolo 3 Cost. che declina il principio di eguaglianza in due forme: formale e sostanziale.
Eguaglianza Formale
L'eguaglianza formale è la "eguaglianza dei cittadini davanti alla legge", tipicamente liberale. Ciò non vuol dire peraltro che la legge debba trattare tutti allo stesso modo. Com'è noto deve piuttosto trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso, secondo quella che è nota come la "regola di giustizia", nota allo stato liberale (dove però prevaleva la dimensione egualitaria soprattutto nell'applicazione della previsione, cioè la giusta applicazione, non la giusta differenziazione della previsione), e in realtà individuata fin dall'antichità, ad esempio nel concetto di giustizia che emerge in Aristotele. Il principio di eguaglianza funziona pertanto dosando uniformità di trattamento con differenziazioni di trattamento. Sempre nell'ambito del primo comma dell'articolo 3 Cost. si fa poi particolarmente riferimento ad alcuni elementi che in passato sono stati oggetto di discriminazioni (anche se, attenzione, nell'ordinamento in questione quelle misure magari erano assunte in modo legale e legittimo). Parliamo di alcune classificazioni giuridiche come il sesso, le opinioni politiche, le opinioni religiose, la "razza" (non perché esistano le razze, ma perché è esistito ed esiste il razzismo), la lingua minoritaria, e comunque - conclude la disposizione con clausola generale e residuale - tutte le "condizioni personali e sociali". Ebbene, anche relativamente a queste qualificazioni - quella di disabile è certamente una delle possibili "condizioni personali" rilevanti - non possono escludersi a priori, anzi sono possibili e per certi aspetti doverose delle differenze di trattamento. Qualunque condizione può rilevare a certi effetti. Queste differenze di trattamento tuttavia devono essere realizzate a fronte di una condizione oggettivamente diversa, cosa che ad esempio è acclarata, nel caso della disabilità, da una diagnosi e da certificazioni. Sono in genere anche differenze di trattamento di tipo favorevole, quindi condizioni di vantaggio, per compensare - per ragioni di giustizia sociale - appunto uno svantaggio. Ma va precisato che non è da escludere a priori che si possano ricevere anche trattamenti differenti di tipo sfavorevole, qualora siano - 5