Economia dei trasporti: analisi del trasporto terrestre e delle politiche
Documento di Università su Economia dei trasporti. Il Pdf, un testo discorsivo di Economia per l'Università, esplora il trasporto terrestre (stradale e ferroviario), le sue caratteristiche, costi e le politiche di trasporto, inclusi i fallimenti di mercato e le esternalità.
Mostra di più36 pagine
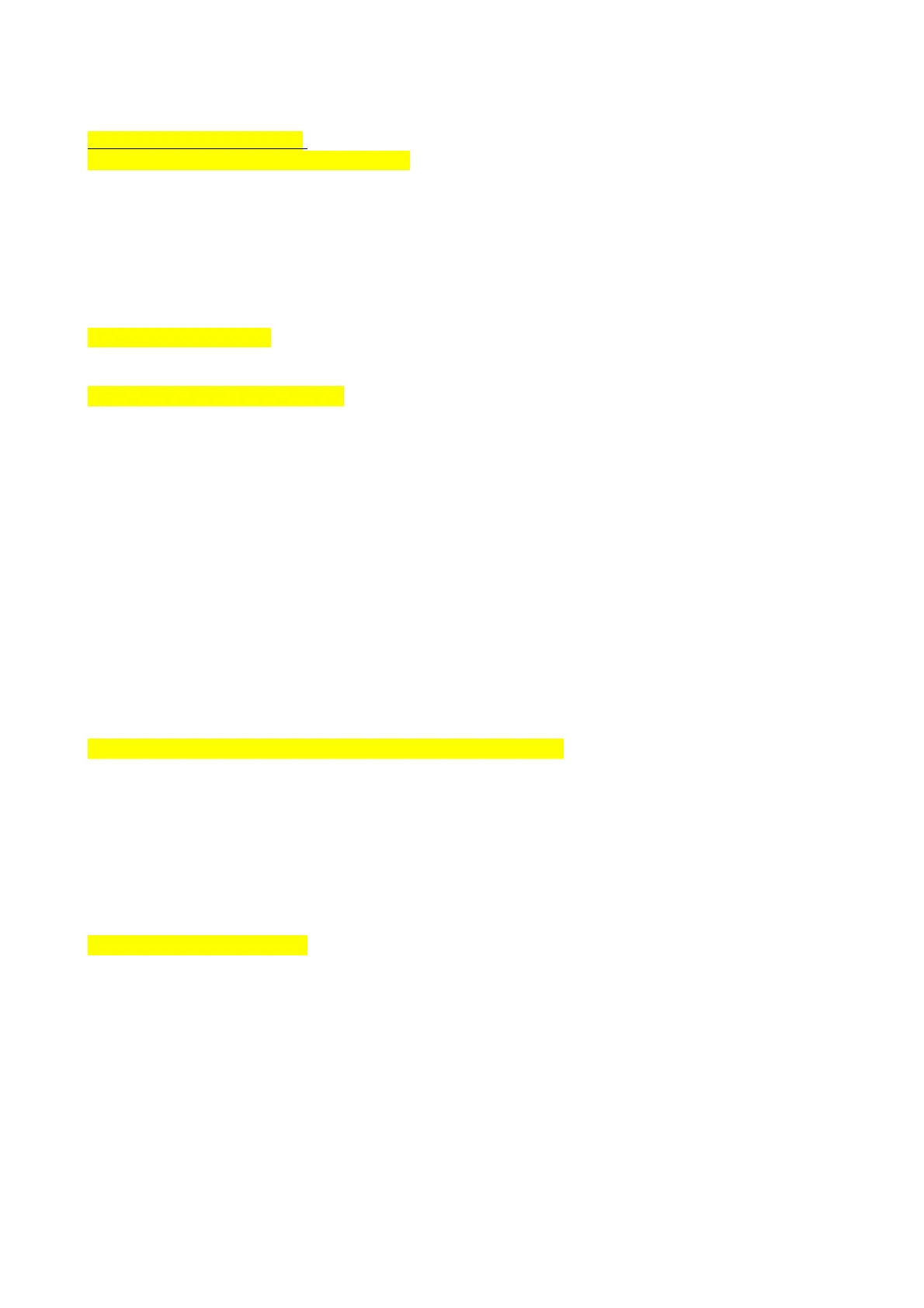
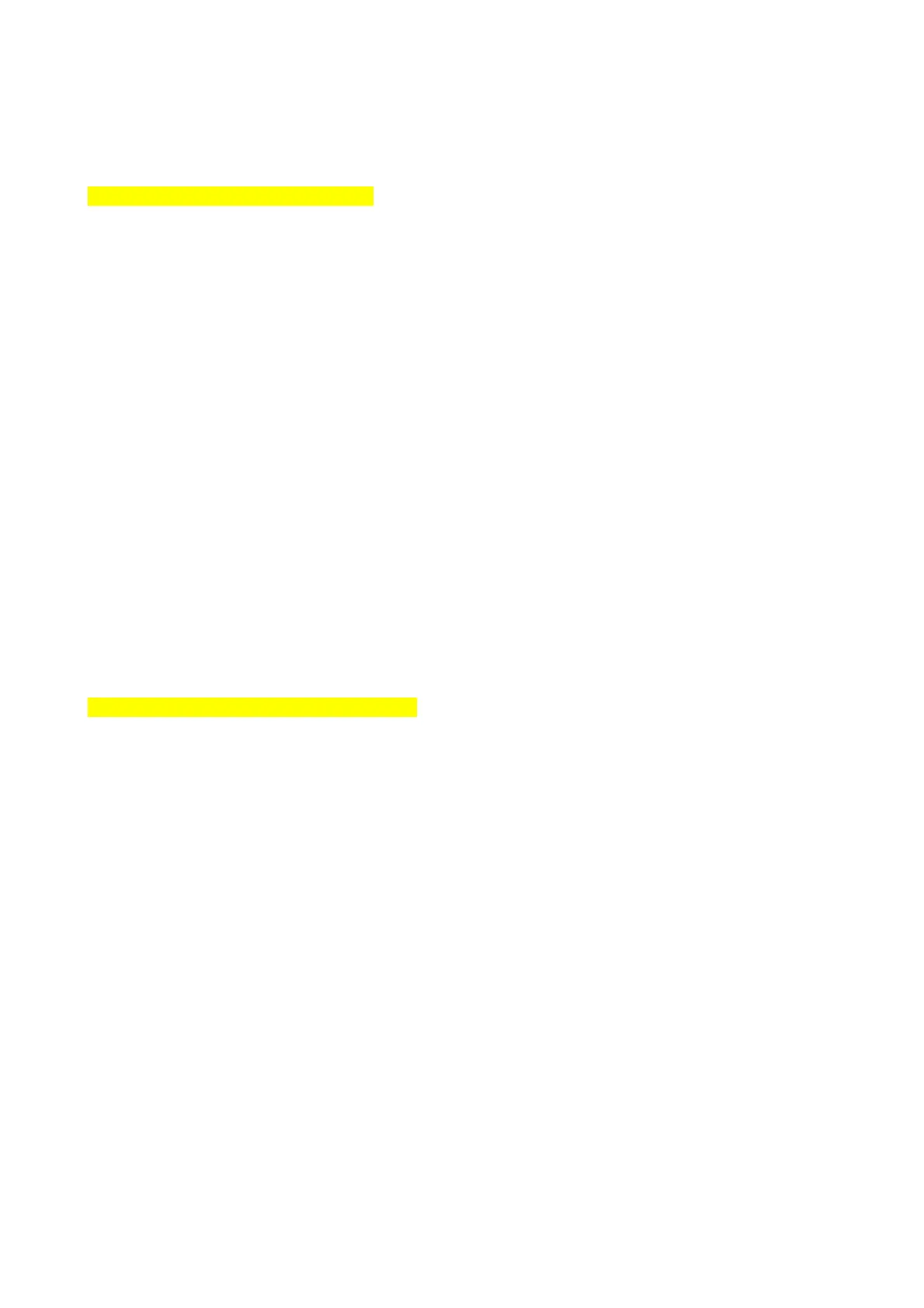
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Capitolo 9: il trasporto terrestre
La strada, il modo di trasporto più capillare
La strada si caratterizza per essere il tipo di trasporto più capillare, quello che consente di trasferire una merce o un passeggero dal luogo in cui origina il suo spostamento al luogo in cui effettivamente ha termine. Questa caratteristica lo rende quasi sempre indispensabile anche nei trasporti effettuati con altri modi, quanto meno nella parte iniziale e terminale di ciascun viaggio. Mentre d'altra parte è possibile e frequente che l'intero viaggio sia effettuato ricorrendo esclusivamente al trasporto stradale, soprattutto se il viaggio in questione è relativamente breve.
Prima e dopo il motore
Solo ultime righe da "dunque" in poi ...
Caratteristiche, produzioni e costi del trasporto stradale
Caratteristiche che lo rendono diverso da gli altri tipi:
· economie di scala relativamente modeste rispetto agli altri modi di trasporto, con scarsa possibilità fisica più che economica di aumentarne le dimensioni causa le caratteristiche delle infrastrutture viarie. Costo relativamente basso e confrontato con gli altri tipi di trasporto e rischio di obsolescenza basso. · La capillarità della rete consente di raggiungere un elevatissimo numero di punti sul territorio (molto maggiore rispetto a marittimo e aereo che sono vie naturali) · La regolazione del traffico è relativamente contenuta e ha carattere statico (come la segnaletica) e non dinamico (come il controllo dei voli in un aeroporto o il traffico su una linea ferroviaria. Le infrastrutture stradali consentono nella maggior parte dei casi un uso contemporaneo senza rivalità fra gli utilizzatori, potendo essere utilizzate contemporaneamente da più veicoli nello stesso tempo, senza che l'utilizzo da parte di uno di essi limiti o impedisca l'utilizzo da parte degli altri. Questa circostanza non si verifica nelle altre modalità di trasporto.
Si presta meglio di ogni altro tipo di trasporto a essere utilizzato per esigenze private, intendendo l'uso di veicoli di proprietà privata per le esigenze del proprietario del veicolo e si presta a dar luogo a una importante autoproduzione, o autosoddisfazione della domanda di trasporto.
Il trasporto di persone: privato e pubblico, individuale e collettivo
Nei paesi più ricchi da qualche decennio l'auto è considerata come un bene di prima necessità. In italia nel 2019 alla vigilia della pandemia del covid 19 il possesso di autovetture sfiorava i 40 milioni con una proporzione di circa 600 vetture ogni 1000 autovetture. Il dato preoccupante però è il tasso di riempimento di queste autovetture, circa l'1,3 persone per veicolo che porta al drammatico congestionamento dei centri urbani, che è ovviamente generato molto di più dal traffico privato. Per questo motivo in molti paesi tra cui l'Italia il trasporto collettivo urbano è sovvenzionato in modo preponderante. Taxi, servizi di sharing, car pooling ...
Il trasporto stradale di merci
Nel trasporto stradale di merci le caratteristiche che connotano la produzione del trasporto stradale permangono: limitate economie di scala del veicolo, relativa semplicità dell'esercizio dal punto di vista tecnologico, capillarità della rete infrastrutturale, parziale non rivalità nell'uso delle infrastrutture relativamente limitate esigenza di regolazione del traffico. Da queste caratteristiche conseguono costi di investimento relativamente modesti per l'acquisto di un veicolo , maggiore facilità di accesso al credito necessario, più rapidi tempi di fornitura dei mezzi e di avvio dell'attività. Parco veicoli è fortemente sbilanciato verso i veicoli di piccole dimensioni. La percorrenza media annua dei veicoli è tanto maggiore quanto è la portata, quindi più un veicolo è grosso più viene utilizzato per l' viaggi lunghi e viceversa, dato che i veicoli di piccole dimensioni passano proporzionalmente più tempo nelle operazioni di carico/scarico rispetto a quelli di maggiori dimensioni.In sintesi il trasporto automobilistico ha dato luogo a un prodotto estremamente flessibile, venduto su un mercato estremamente atomizzato, fatto di molti piccoli produttori in forte concorrenza tra loro, con deboli economie di scala, netta separazione fra l'esercizio del veicolo e la rete infrastrutturale.
Un rivoluzionario trasporto terrestre
Il trasporto ferroviario è un trasporto definito a guida vincolata. Il treno correi sui binari. La marcia non è regolata a vista, come nel trasporto stradale, ma con sistemi di segnalamento grazie ai quali il conducente e/o i sistemi automatizzati per la guida del mezzo reagiscono determinando la marcia del treno e la sua velocità. I veicoli sono gruppi di carri o carrozze legati insieme e trainati da un carro dotato di uno o generalmente più motori. Il numero di carri o carrozze che possono comporre il treno non ha altri limiti che la potenza del motore trainante e i vincoli dimensionali imposti dalla via, come la lunghezza dei binari e dei marciapiedi nelle stazioni, o i raggi di curvatura. Il punto di forza del sistema ferroviario e cioè il basso attrito, che consente di ottimizzare il rapporto tra potenza trainante e peso trainato è anche il suo punto di debolezza: l'aderenza è bassa, la pendenza superabile è assai minore, gli spazi di frenata sono molto maggiori, e spesso eccedono la visuale libera (cioè quando si aziona la frenatura non si ha completa visibilità su tutto lo spazio necessario per frenare, che a velocità di 100km/h è di centinaia di metri e intorno ai 120 è di circa un km. La sicurezza della marcia dei treni è garantita dalla segmentazione della linea in sezioni cui si collegano sistemi semaforici volti a garantire il distanziamento dei convogli. Il trasporto ferroviario si utilizza su varie distanze, e nell'epoca della sua introduzione non ha avuto rivali per molti decenni. Oggi tuttavia è meno competitivo dell'automobile sulle distanze molto brevi e meno competitivo della nave (per le merci) e dell'aereo (per le persone) su distanze oltre una certa lunghezza. Questo non impedisce che venga utilizzato anche su distanze brevi, in particolare nel trasporto urbano e metropolitano (nel TPL) soprattutto grazie alla possibilità di evitare la congestione, ma anche in quelle lunghe (raramente lunghissime). Il punto debole però rimane la mancanza di capillarità. La maggiore rilevanza strutturale dei punti di terminale (stazioni per passeggeri e scali merci) e il maggior costo di costruzione delle vie ferrate rispetto alle strade rendono la rete ferroviaria enormemente meno capillare di quella stradale al punto che il suo utilizzo richiede quasi sempre, sia per le persone che per le merci, uno spostamento stradale d'origine e uno di arrivo finale.
L'epopea del treno e il mito del progresso
Le rotaie erano già utilizzate nei secoli precedenti, principalmente nelle miniere e da allora si potrebbe già parlare di trasporto ferroviario, anche se i convogli di carrelli erano trainati da animali o uomini. I romani conoscevano già i solchi carrai, scanalature nella pavimentazione stradale che riducevano l'attrito e quindi l'energia necessaria al traino. È questa la fortuna e la questione fondamentale della ferrovia, aumentandone allo stesso tempo la portata e/o la velocità a parità di energia motrice. Nascono così le ippovie, carrozze appoggiate su rotaie trainate da animali che con questo metodo si poteva ridurre l'attrito e ridurre il numero dei cavalli e stancarli di meno. Mancava solo il motore che in realtà c'era già: era il motore a vapore inventata nel 1775 da James watt. Nel primo ventennio del 1800 si costruiscono le prime locomotive. Negli anni si sviluppa e si modernizza sempre di più aumentando il chilometraggio orario. A metà secolo circa si inaugurano le prime line applicate al traffico interurbano in Inghilterra. La seconda metà del 19º secolo È caratterizzata dalla rapida crescita di collegamenti ferroviari in tutta l'Europa, negli Stati Uniti e in molti altri paesi le velocità raddoppiano. Alla fine del XIX secolo l'intera Europa gli Stati Uniti sono attraversati da linee ferroviarie. Alice del XX secolo esistono già dunque le principali linee ferroviarie tutta Europa e negli Stati Uniti ma altre linee si aggiungono come la Transiberiana in Europa di oltre 9000 km che cambia profondamente l'economia della regione da tuttora divisione del trasporto di merci e di persone. Intanto parallelamente si sviluppa nelle ferrovie urbane chiamate ancora oggi metropolitane.la prima metropolitana sotterranea chiamato infatti underground con motore a vapore fu inaugurata a Londra nella metà del 1800, successivamente si diffondono nelle maggiori città (Istanbul, Chicago, Parigi, new York, Berlino). I tram invece si sviluppano nell'ultimo quarto del 1800 nelle città in cui i volumi di traffico non giustificavano la spesa per la costruzione di metropolitane, perciò nei nei contesti urbani di piccole dimensioni.Dopo la seconda guerra mondiale comincia per la ferrovia un periodo di relativo declino, dovuto all'affermarsi di più pericolosi concorrenti del treno: l'autocarro e l'automobile usati per gli spostamenti di merci e persone sulle brevi medie distanze; e l'aereo che dagli anni 70 e 80 diverrà sempre meno caro e quindi sarà utilizzato da sempre più passeggeri sia per motivi di lavoro che turistici. Un avere propria rinascita luogo quando il progresso della tecnologia ferroviaria si muove nella direzione dell'alta velocità puntando a diventare maggiormente competitivo sulle distanze medie tre 300 e 1000 km sulle quali era stato pressoché totalmente soppiantato dall'aereo salvo per i viaggiatori economicamente più deboli.
L'economia del trasporto ferroviario
Nel XX secolo si affermano sempre di più le gestioni pubbliche delle ferrovie, sia per la parte infrastrutturale che per la produzione del servizio di trasporto ferroviario. La gestione era spesso controllata dai governi nazionali attraverso compagnie pubbliche. Cosi avvenne in Italia con le Ferrovie dello Stato: lo stato rilevò la proprietà e la gestione delle linee ferroviarie, fino ad allora in mani private, e tutt'ora controlla la grande maggioranza della rete, salvo poche e quasi sempre marginali ferrovie in concessione gestite da altre compagnie. Nel trasporto passeggeri si fece strada l'idea che il servizio ferroviario potesse avere le caratteristiche del servizio pubblico, da assicurare al maggior numero possibile di persone, specie quelle che non potevano permettersi altre soluzioni di trasporto, e quindi praticando anche prezzi politici, cioè inferiori ai costi, con la conseguenza di gestioni strutturalmente in perdita, o di sovvenzioni alle compagnie ferroviarie (il che è sostanzialmente lo stesso). Per decidere quale sia il livello di servizio pubblico che deve essere assicurata attraverso le sue obiezioni, vengono definiti obblighi di servizio universale, caratterizzati da determinati livelli quantitativi e qualitativi di servizio, che le compagnie devono comunque assicurare prescindendo dalla loro redditività economica. A fronte di tale obbligo di servizio pubblico viene riconosciuta una sovvenzione. In Italia i servizi universali per i trasporti ferroviari, sia di persone che di merci, sono assegnate a Trenitalia società del gruppo ferrovie dello Stato, con la quale il governo stipula periodicamente un contratto di servizio che definisce gli obblighi di servizio pubblico e il relativo onere sostenuto dallo Stato. Le caratteristiche strutturali del trasporto ferroviario non favoriscono un assetto concorrenziale del mercato. La concorrenza è del tutto mancata finché ha prevalso l'integrazione verticale fra la gestione della rete infrastrutturale e la gestione del servizio. Poiché la rete configura spesso situazione di monopolio naturale, un sistema integrato rete+servizio tende evidentemente incorrere nello stesso problema. Anche il trasporto ferroviario di merci risente spesso dello stesso problema, e la mancanza di sovvenzioni in questo caso marginalizzato nella ripartizione modale. Le gestioni pubbliche, che nel 1900 hanno caratterizzato in molti paesi non solo la gestione dell'infrastruttura ma anche quella del servizio ferroviario, sono per loro natura poco orientate al mercato e scontano le inefficienze X che sono le divergenze del comportamento concretamente evidenziato da un'impresa per effetto della mancanza di pressione competitiva, rispetto al comportamento teorico (ed efficiente) che è attribuito dalla teoria economica.
La separazione fra infrastruttura e servizio
La gestione delle ferrovie dipende il Gruppo Ferrovie dello Stato che è poi suddiviso in diverse tipologie di servizi: servizi di trasporto attraverso Trenitalia S.p.A. (persone) o Mercitalia (merci) e la gestione dell'infrastruttura attraverso Rete Ferroviaria Italiana. RFI gestisce l'infrastruttura ferroviaria in monopolio naturale (in quanto la rete ferroviaria è una), sulla base di una concessione statale. Tutto il sistema ferroviario si basa su un principio di separazione tra la gestione dell'infrastruttura e l'esercizio del servizio di trasporto. Nel caso italiano questo principio è molto critico, perché pur essendo conforme normativa UE, nasconde il rischio di conflitti di interessi, perché rete ferrovia italiana (gestore) si trova nello stesso gruppo societario di Trenitalia S.p.A. e mercitalia cioè i prestatori di trasporto. Quindi c'è il rischio che il gestore abbia un occhio di riguardo nell'assegnazione delle tracce di utilizzo a Trenitalia o mercitalia avvantaggiando il rispetto ad altri operatori fuori dal gruppo fs. La tecnica di liberalizzazione preferibile dipende dai contesti, ed essenzialmente dalla densità del traffico.semplificando un po', possiamo dire che sulle medie lunghe distanze (poiché la densità del traffico è