Le origini della letteratura: sistema feudale, cultura e amor cortese
Slide sulle origini della letteratura. Il Pdf esplora il contesto storico del sistema feudale, la cultura cortese e l'amor cortese, con influenze dalle corti francesi e provenzali. Questo materiale di Letteratura per la Scuola superiore è utile per lo studio autonomo.
Mostra di più38 pagine
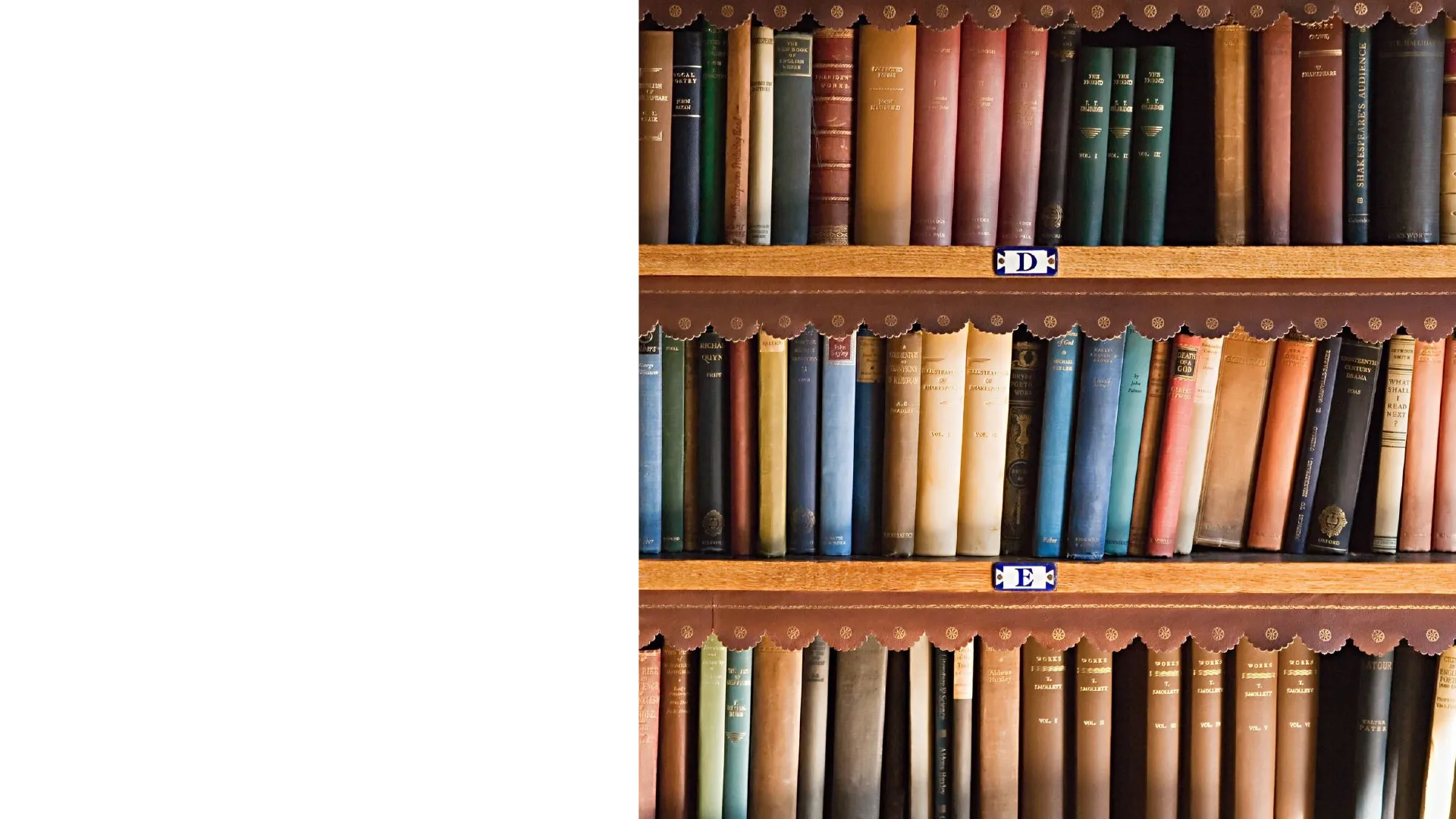

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Le origini della letteratura
L.G. E. HALLIDAY NEW BOOK ENGLISH VERSE VOGAL OSTRY SHERIDAN' HUEND WORKS T I. T. pinkopere's Producing Hand VOL I SHAKESPEARE'S AUDIENCE Calumb PAUL PAUL DUCKWORTH D Ef God A BLARLES DEATH LOSBERT OCHAEL OF A GOD HIGHTEENTH CENTURY DRAMA MEMORIAI OF SHAKESPE POETI WORK SBERT 1 TWALL A.C. RADLEY READ NEXT ? Vor. ( YOU. 10 ADATTO OXFOR OXFORD E Literature & Science PORKS WORKS WORKS WORKS LTOUR RISE MAUGH Aldous Huxley T. T. 134OLLETI T T. T T. EMOLLETY :MOLLET SMOLLETT SMOLLETT VOL. II VOL M VOLI VOL VT VOL V PATER POE . TENCE POLOILLETT Fritert RICHA RALEIGH John TASMENTARY BYMOUR SMITH QUYN TRADITION IXLER FRIPP DRYDE SHAKESPPA TOAS WHAT SHALL ENGI thers PHAREPEAREIl contesto storico: il sistema feudale
Il sistema feudale
- In seguito al crollo dell'impero romano, l'assenza di un potere centrale e il costante rischio dei saccheggi da parte delle popolazioni barbariche costrinsero le popolazioni cittadine a rifugiarsi nelle campagne e a cercare lavoro e protezione presso i ricchi proprietari terrieri, i quali acquisirono sempre più potere all'interno dei loro latifondi.
- Tale processo, base del sistema feudale, fu legittimato da Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero, che divise l'impero in zone affidate a marchesi e conti, i quali esercitavano in suo nome il potere amministrativo. Queste terre, o feudi, erano concesse in usufrutto: alla morte dei signori dovevano essere restituite all'imperatore.
- Con i successori di Carlo Magno tale pratica si consolidò e divenne un sistema fondato su un patto, siglato da un giuramento: il re concedeva ai signori terre in beneficio (non in proprietà), i signori si dichiaravano suoi vassalli e si impegnavano a prestargli aiuto.
- Il sistema feudale si rafforzò ulteriormente quando ai feudatari fu concessa l'immunità (l'esenzione dalle imposte e il potere di amministrare la giustizia) e l'ereditarietà dei feudi, cioè il potere di trasmettere il feudo al primo discendente maschio. Ciò favorì, da un lato, la nascita di un'aristocrazia guerriera, la classe dei cavalieri; dall'altro lato rese sempre più fragile il potere del sovrano, frammentato nelle mani di sempre più persone.
Il monachesimo
- In ondate successive, in un periodo compreso fra V e XII secolo, l'Occidente si era popolato di monaci che conducevano una vita comunitaria in monasteri posti in luoghi isolati. La caratteristica principale della cultura monastica era la fuga e il "disprezzo" del mondo; per questo furono i monaci, in quanto interpreti più fedeli dei precetti evangelici, a fungere spesso da pungolo e da voce critica nei confronti di una Chiesa che si andava sempre più mondanizzando.
- I monasteri prevedevano, insieme alla preghiera, anche la lettura dei libri sacri. I monaci perciò dovevano essere alfabetizzati e tutti i monasteri dovevano essere provvisti di quanto necessario per l'istruzione. Questa esigenza favorì la costruzione di scuole e biblioteche.
- Le biblioteche erano spazi destinati alla lettura, alla riproduzione, al restauro e alla miniatura dei testi, cui provvedevano i monaci amanuensi, che copiavano a mano i libri antichi e li ornavano anche con pitture di colore rosso (il minio). Col passare del tempo le biblioteche, che agli inizi contenevano soltanto una quantità limitata di testi di carattere religioso, si arricchirono di manoscritti degli antichi pagani. Fu per l'opera paziente dei monaci se tanta parte del sapere antico, cristiano e pagano, poté essere salvata e tramandata.
Il valore del libro
- Il lavoro dei monaci sui manoscritti antichi si spiega più col valore morale che essi attribuivano a questa attività che con l'intenzione di far circolare un oggetto destinato alla lettura. In quei secoli non esisteva un pubblico letterario: il latino era sconosciuto alla maggioranza della popolazione e l'analfabetismo era la regola. Il libro era un oggetto prezioso e veniva scarsamente utilizzato anche nelle scuole, dove prevaleva l'insegnamento orale. In sintesi, i libri non erano fatti per essere letti ma per essere custoditi come tesori; come scrive lo storico Le Goff, erano «un bene economico più che spirituale».
- Nel Medioevo i libri erano oggetti rari e costosi, accessibili a un ristretto numero di studiosi. La maggior parte della popolazione era analfabeta, a cominciare dai regnanti, come l'imperatore Carlo Magno, che sapeva a mala pena tracciare la propria firma.
Il libro nell'antichità
- I "libri" dell'antichità erano in realtà dei rotoli, in quanto costituiti da più fogli, di pergamena o di papiro, cuciti o incollati l'uno all'altro in corrispondenza dei margini, a formare una lunga striscia che si conservava, appunto, arrotolata. Tra il IV e il VII secolo tale sistema fu sostituito dal codice: il materiale sul quale si scriveva, generalmente la pergamena, veniva tagliato in fogli delle stesse dimensioni cuciti poi insieme su uno stesso lato, ottenendo un vero e proprio libro come oggi lo conosciamo.
- Nel corso dell'Alto Medioevo i libri, impreziositi da decorazioni e miniature, erano oggetti di lusso; il costo era elevato perché ciascuno di essi, scritto a mano, richiedeva un lungo lavoro; la pergamena era un materiale pregiato. Per recuperare un foglio sul quale scrivere, a volte si raschiava una pergamena usata e la si riutilizzava per un nuovo testo (palinsesto).
- La Chiesa deteneva il monopolio della cultura e custodiva gelosamente i libri tra le mura delle proprie istituzioni, temendo che la diffusione del sapere avrebbe diminuito il prestigio delle autorità religiose: solo i monasteri possedevano biblioteche e i monaci erano le uniche persone in grado di leggere e di scrivere.
Il libro dal XII secolo
- A partire dal XII secolo, con lo sviluppo delle città e la nascita delle scuole urbane e delle università, anche il libro conobbe una nuova fioritura. Da oggetto di lusso si andò trasformando in strumento di studio funzionale allo scopo, anche grazie ad alcune innovazioni grafiche introdotte in questo periodo: la divisione in rubriche e capitoli, l'indice in ordine alfabetico, una punteggiatura più chiara. Nei testi universitari si cominciò a lasciare ampi margini per le glosse, cioè i commenti e le annotazioni degli studiosi.
- L'alfabetizzazione si estese a nuove classi sociali: oltre ai giuristi e agli studenti delle università anche un certo numero di nobili, artigiani e mercanti. Aumentò così la domanda di libri e nacque un nuovo mestiere: il libraio. Con l'introduzione in Europa della carta, nel XII secolo, i libri divennero anche più economici.
- Nonostante questa rinascita, i libri non si diffusero esageratamente. All'epoca dei Comuni vi erano sicuramente in circolazione più libri che nell'Alto Medioevo, ma si trattava comunque di un numero molto limitato. Si consideri, per esempio, che nel Trecento la Commedia di Dante era disponibile soltanto in tre o quattro copie, una delle quali veniva letta in pubblico e commentata da Giovanni Boccaccio.
La cultura cortese
- Nel periodo di maggiore espansione del sistema feudale, tra I'XI e il XIII secolo, la nobiltà europea elaborò una coscienza comune, che si espresse in rituali, valori e codici di comportamento improntati a un'etica fondamentalmente terrena, pur nel quadro della mentalità cristiana dominante. Poiché ciò avvenne nell'ambito delle corti regali e signorili, si è soliti parlare al riguardo di "cultura cortese", che influenzerà nel corso del tempo anche i ricchi ceti urbani.
- In questa cultura confluivano i valori guerreschi e dell'onore propri della cavalleria, il rango più elevato della gerarchia militare, accessibile quasi esclusivamente alla classe nobiliare a causa dei costi elevatissimi che comportava (cavallo, armatura, lungo tirocinio).
- A partire dall'XI secolo, la cavalleria svolse un ruolo importante nelle crociate e nelle guerre contro gli "infedeli", come testimoniano i poemi epici del tempo (le chansons de geste).
I valori della cavalleria
- Progressivamente la società feudale finì per identificarsi con i valori della cavalleria e per accoglierne i riti, le cerimonie e le idealità.
- Il titolo di cavaliere divenne sinonimo di gentiluomo, di nobile.
- Ora il cavaliere aspirava a distinguersi dagli altri uomini non solo per la nobiltà della sua famiglia e il coraggio in battaglia, ma anche per la cortesia, ovvero per l'insieme delle virtù dell'uomo di corte: la nobiltà di sentimenti, l'eleganza, la gentilezza, la generosità e la liberalità, cioè il disprezzo del denaro.
L'amor cortese
- L'amor "cortese", come si deduce dai romanzi cavallereschi e dai trattati dedicati a questo tema - primo tra tutti il trattato De amore di Andrea Cappellano (1150 ca .- 1220 ca.) - non è né quello che si realizza nel matrimonio e nei figli, né quello che ricerca la soddisfazione immediata di un desiderio; è piuttosto un sentimento aristocratico (solo i cuori nobili e gentili possono concepirlo) ed eroico: il cavaliere ama e si mette al servizio di una dama che appartiene a un altro uomo, al re o al signore al quale il cavaliere ha giurato fedeltà.
- Un'avventura molto pericolosa, ma è solo la prima delle tante difficili prove che l'amante dovrà affrontare, per ottenere alla fine dalla dama il giusto compenso per il suo coraggio e la sua dedizione.
- Tale concezione, che confligge con i principi cattolici, propone una religione laica dell'amore, in quanto lo sottrae alla sfera del peccato e lo arricchisce di una tensione ideale.
Le corti e la letteratura volgare
- Al mondo delle corti, in particolare a quelle di Francia e di Provenza, è legata la nascita di una letteratura in lingua volgare, che celebra i valori della classe feudale e gli ideali cortesi della cavalleria.
- I romanzi cavallereschi e le canzoni di gesta, la più celebre delle quali è la Canzone di Orlando, furono scritti in lingua d'oïl, l'antico francese parlato nella Francia del nord (che usava oïl per l'affermazione, per il "sì"), mentre la nuova poesia lirica dei trovatori fu scritta in lingua d'oc, l'antico provenzale (che usava invece oc per il “sì").
- Intorno al XIII secolo anche le corti feudali dell'Italia settentrionale (i marchesi di Monferrato, i Malaspina, i signori della Marca Trevigiana) diedero vita a una raffinata cultura cortese, influenzate dalle letterature romanze francesi e provenzali.