Riassunto del libro Un van gogh per snoopy, Sapienza - Università di Roma
Documento da Sapienza - Università di Roma su riassunto libro Un van gogh per snoopy. Il Pdf, utile per studenti universitari di didattica museale, analizza il ruolo dell'arte nella società contemporanea, il concetto di bellezza e il suo legame con il dolore, con una struttura chiara e concisa.
Mostra di più38 pagine
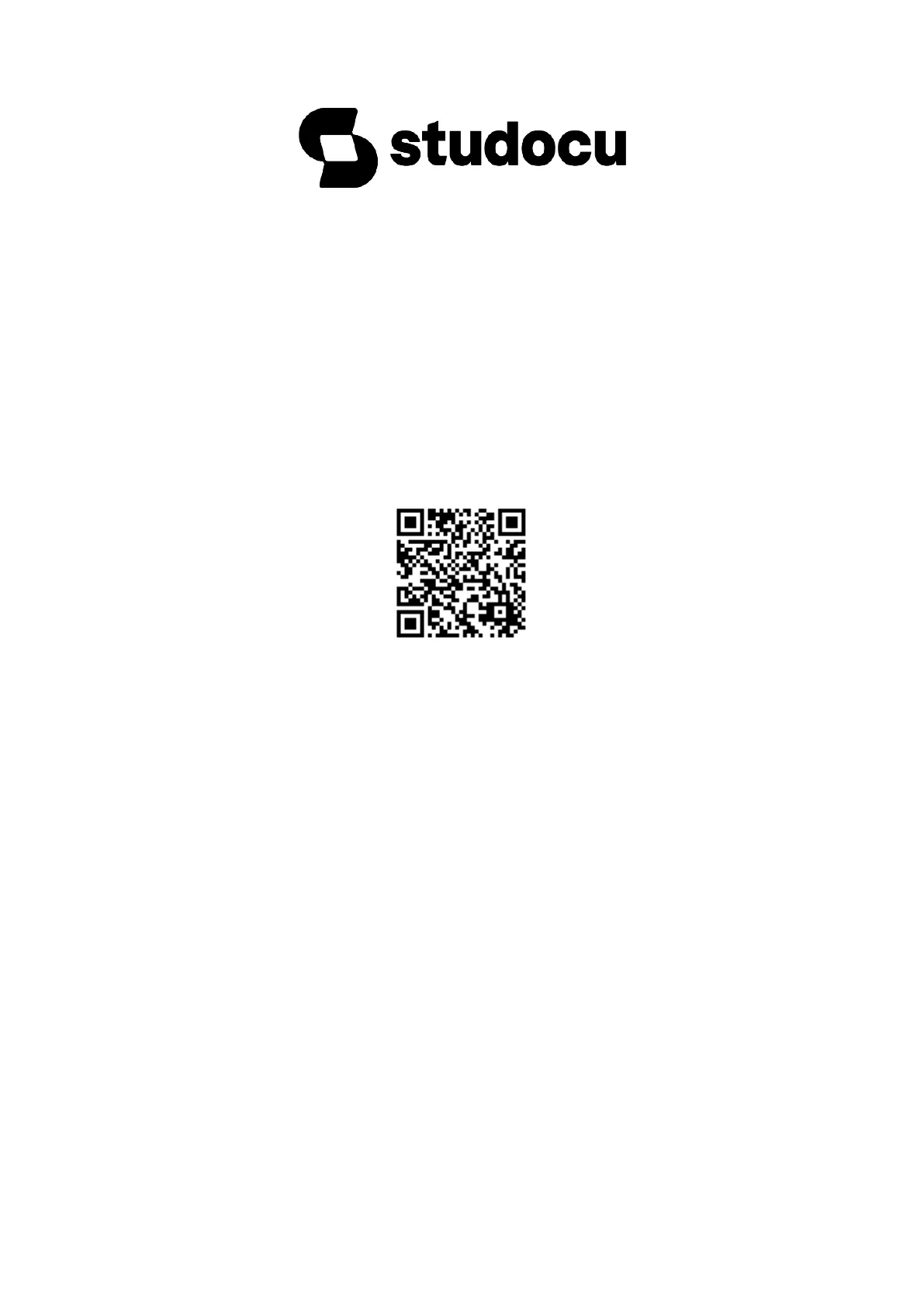
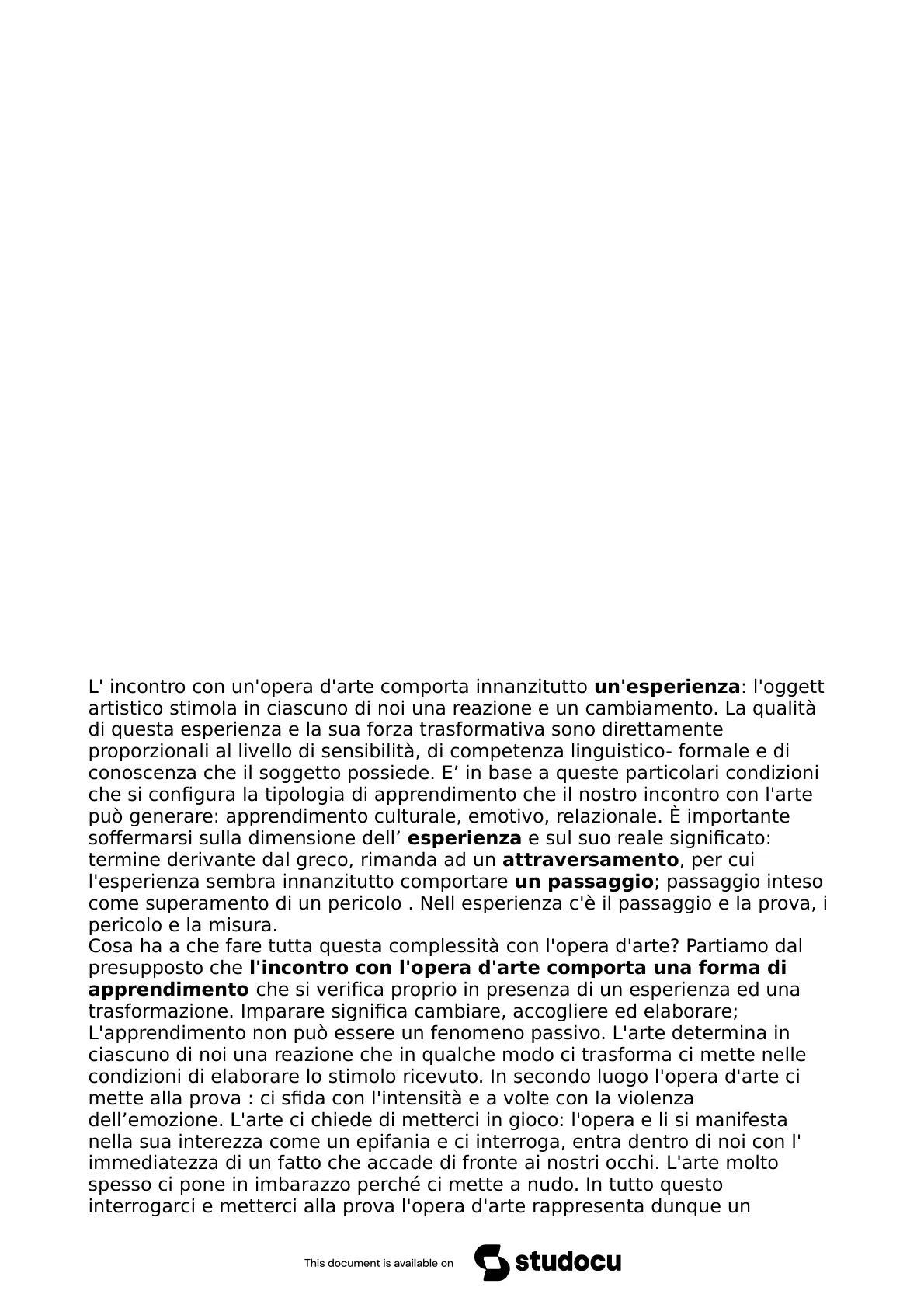
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INTRODUZIONE
Che ruolo svolge l'arte nelle nostre vite di uomini della società globalizzata e complessa? E in cosa consiste l'esperienza estetica, in quale modo essa può aiutare le nostre esistenze? Da anni si parla di questo. L'esperienza estetica sembra dunque aver riconquistato un posto di primo piano nel confronto sociale sul progresso e sulla modernità. Ma, affinchè questo dibattito possa tradursi in progetto, occorre interrogarsi sul significato che oggi l'esperienza dell'arte assume per ciascuno di noi.
Da un lato, infatti, vi è un crescente desiderio di appagamento, dall'altro una difficoltà di comprensione dei linguaggi oggettivi: la ragione primaria sembra proprio essere la complessità di tali linguaggi. Infatti, se da un lato ci abituiamo ad un potente livello di immediatezza della fruizione delle esperienze, l'arte continua ad imporsi con i suoi tempi, le sue difficoltà virgola e le sue regole. Tutti questi stimoli richiedono attenzione, ascolto, pazienza e umiltà: ovvero attitudini, abilità che confliggono con l'età liquida, veloce, ed egocentrica che stiamo vivendo. Il conflitto di fondo, l' incomunicabilità dell'arte verso i moderni pubblici, risiede in questo disallineamento del tempo e del pensiero. l'arte, in quanto operazione non utilitaristica, sfugge ai criteri di pronta consegna ed istantaneità. l'esperienza estetica appare così come un misterioso enigma: attraente, preziosa, unica ( nonostante i sempre più sofisticati tentativi di replicarla e di renderla virtuale ) sembra non piegarsi alle nuove strategie della comunicazione della partecipazione punto ci sfida e resiste.
L'ESPERIENZA DELL'OPERA D'ARTE ED IL PROBLEMA DELLA BELLEZZA
L'incontro con un'opera d'arte comporta innanzitutto un'esperienza: l'oggetto artistico stimola in ciascuno di noi una reazione e un cambiamento. La qualità di questa esperienza e la sua forza trasformativa sono direttamente proporzionali al livello di sensibilità, di competenza linguistico- formale e di conoscenza che il soggetto possiede. E' in base a queste particolari condizioni che si configura la tipologia di apprendimento che il nostro incontro con l'arte può generare: apprendimento culturale, emotivo, relazionale. È importante soffermarsi sulla dimensione dell' esperienza e sul suo reale significato: termine derivante dal greco, rimanda ad un attraversamento, per cui l'esperienza sembra innanzitutto comportare un passaggio; passaggio inteso come superamento di un pericolo . Nell esperienza c'è il passaggio e la prova, il pericolo e la misura.
Cosa ha a che fare tutta questa complessità con l'opera d'arte? Partiamo dal presupposto che l'incontro con l'opera d'arte comporta una forma di apprendimento che si verifica proprio in presenza di un esperienza ed una trasformazione. Imparare significa cambiare, accogliere ed elaborare; L'apprendimento non può essere un fenomeno passivo. L'arte determina in ciascuno di noi una reazione che in qualche modo ci trasforma ci mette nelle condizioni di elaborare lo stimolo ricevuto. In secondo luogo l'opera d'arte ci mette alla prova : ci sfida con l'intensità e a volte con la violenza dell'emozione. L'arte ci chiede di metterci in gioco: l'opera e li si manifesta nella sua interezza come un epifania e ci interroga, entra dentro di noi con l' immediatezza di un fatto che accade di fronte ai nostri occhi. L'arte molto spesso ci pone in imbarazzo perché ci mette a nudo. In tutto questo interrogarci e metterci alla prova l'opera d'arte rappresenta dunque un passaggio, una trasformazione una misura ed un rischio che non tutti sono disposti ad affrontare, ragion per cui molti preferiscono girare i tacchi.
Arte e modernità
Quella dell esperienza è una delle grandi questioni che i filosofi moderni e contemporanei sono posti di fronte all' attualità e il futuro dell'arte. Ad Hegel viene attribuito l' assunto della cosiddetta "morte dell'arte" : ciò che dichiara non comporta un abbandono o una rinuncia dell esperienza artistica bensì una diversa relazione con l'opera. Hegel considera l'esperienza dell'opera d'arte come percorso il riflessivo sulla storia, in una visione del fenomeno espressivo che comporta uno sguardo allargato e trasversale sui linguaggi. Glorifica di fatto la storia dell'arte come fatto pedagogico, come cornice di sviluppo della persona ma soprattutto di conseguimento di uno stato superiore della coscienza individuale e sociale. In altre parole, se da un lato Hegel dichiara il superamento di un processo di dialogo diretto , spirituale, tra uomo e opera d'arte, egli afferma al tempo stesso che ora quel dialogo non si è dissolto ma si è trasformato in un'esperienza diversa e più complessa che trova il suo fondamento nella consapevolezza storica dei fenomeni espressivi.
Non siamo tenuti ad abbracciare la visione di Hegel. Viene naturale riscontrare come proprio negli anni in cui Hegel va formulando le sue teorie estetiche, la ricerca pittorica si concentrasse su esiti di straordinaria e sublime espressività spirituale : le visioni atmosferiche di Turner sembrano sfidare gli assunti Hegeliani di una in attualità dell'arte.
Filosofi contemporanei come Gadamer hanno rivalutato il principio di attualità dell'arte presente. Egli afferma che è un'opera d'arte contemporanea può apparire, al culmine della forza e dell'efficacia espressiva, come una scintilla scoccata dalla trascendenza. Dall'arte del presente egli rileva la sostanziale genuinità, la capacità di trasformarsi e di venirci incontro.
Già all'inizio dell'Ottocento, Hegel riconosceva nell'arte una porta di accesso alla consapevolezza storica, contesto di maturazione di un esperienza vissuta nella coscienza, e dunque , pedagogicamente parlando, come fase utile necessaria al conseguimento di una maturità interiore.
L'utilità dell'arte: una palestra per l'anima e per la mente
La questione educativa e pedagogica dell'arte rappresenta l'altra sponda fondamentale della riflessione sull'arte sulla bellezza, sulla loro natura e utilità. E' proprio la fase del primissimo 800 ad elaborare proposte sull'argomento: spicca il pensiero di Schiller, poeta, storico e filosofo tedesco che nel 1795 scrive "le lettere sull'educazione estetica dell'uomo". Partendo dalle riflessioni di Kant sul bello e sul sublime, Schiller manifesta la disillusione prodotta dalla rivoluzione francese e dall'esaltazione della ragione, per restituire valore alla dimensione spirituale ed il giusto equilibrio tra mente e sentimento. E' attraverso l'educazione estetica, nello spazio specifico della sua esposizione alla bellezza, che l'umanità può ricucire il giusto rapporto tra razionalità e spirito, in una prospettiva che tiene conto del dialogo dell'individuo con la comunità. L'arte e la bellezza, che ne è specifica espressione, sono le palestre dove esercitare l'immaginazione necessaria a costruire il rapporto tra spiritualità e ragione, indispensabile alla conquista di una consapevolezza civica. In questa riflessione shiller ricorre ad un contesto d'azione, quello del gioco, da intendersi proprio nei termini metaforici che gli stessi esplicita: "l'uomo non è ne esclusivamente materia nè esclusivamente spirito. la bellezza come realizzazione della sua umanità non può dunque essere esclusivamente mera vita, e a ciò il gusto del tempo vorrebbe abbassarla. e neppure può essere esclusivamente pura forma. essa è l'oggetto dei due impulsi vale a dire l'impulso al gioco. questo nome vuole designare con la parola gioco tutto ciò che non è soggettivo o oggettivo in senso contingente.
Shiller riconosce nell' essere umano la sola creatura nella quale la sensibilità, legata al dato reale e alla contingenza, si incontra con la ragione, che invece risponde a regole immutabili assolute. Di norma la sensibilità conduce all' azione diretta ( istinto sensibile ), mentre la ragione si esprime nella forma ( stinto formale). L'incontro tra queste due modalità di agire e di pensare si realizza in una terza dimensione quella del gioco ( istinto al gioco ) che appunto mette insieme la sensibilità e la regola ( la vita e la forma ), rendendo l'uomo libero, svincolandolo dai limiti del tempo e dello spazio. Ecco perché il gioco secondo Schiller presenta le stesse caratteristiche che connotano la bellezza.
Queste riflessioni filosofiche ci aiutano a mettere a fuoco alcuni aspetti importanti dell'esperienza dell'opera d'arte:
- la complessità che si cela dietro la parola esperienza
- la controversa e articolata natura dell'esito che tale esperienza può generare (in senso spirituale, trasformativo, culturale)
- il valore pedagogico formativo che assume il rapporto con l'opera d'arte
- la declinazione duale dell'esperienza stessa ( in senso interno ed esterno ovvero soggettivo e proteso verso la socialità ambiente.)
Liquidità dell'arte?
Fino a qui abbiamo illustrato una precisa relazione tra esperienza, opera d'arte /bellezza, e modernità. Ovvero, l'esperienza è un percorso trasformativo che si attiva di fronte all'opera d'arte in un contesto cronologico e culturale che è il tempo attuale , la modernità. Comprendere la reciprocità di questi fattori è decisivo. Una delle questioni da considerare riguarda la natura dell'arte e il suo rapporto con il presente ( cosa è arte? qual è il rapporto tra arte bellezza? ). La trasformazione dei processi culturali e produttivi, specialmente con l'avvento della rivoluzione industriale, ha fatto sì che l'arte si distaccasse in modo definitivo dall'artigianato, acquisendo uno stato di superiorità e fascinazione sempre più selettivo e perfino elitario. Questo fenomeno è anche all'origine della separazione tra arte e società nel senso più ampio, nonché della perdita diffusa dei codici di comprensione di decodificazione del linguaggio artistico. Quando parliamo dell'arte come "Bibbia dei poveri" alludiamo proprio a questo intreccio tra cultura popolare, consapevolezza e produzione artistica . Questo implica che nel medioevo un rilevante allenamento alla comunicazione iconica facesse parte del bagaglio linguistico di ciascuno se non altro per familiarità e abitudine. E' stato più volte rilevato che nel primo 900 emergono due posizioni sul rapporto tra esperienza artistica e dimensione sociale: nella prima, rappresentata dal filosofo Adorno, l'arte risulta del tutto sganciata da una relazione con il flusso della modernità e con la sua concretezza; Nella seconda postata da John Dewey si sostiene al contrario una posizione di continuità tra progresso, quotidianità ed esperienza artistica . Ciò che caratterizza queste riflessioni è soprattutto la valutazione dell'impatto esercitato dai nuovi ritmi produttivi e relazionali -classificabili attraverso le categorie del capitalismo, della grande