Appunti di Diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia dell'UE
Documento del Prof. Rossolillo sul Diritto dell'Unione Europea. Il Pdf esamina la struttura e le funzioni della Corte di Giustizia dell'UE, le tipologie di rinvio pregiudiziale e i limiti di competenza. Questo materiale universitario di Diritto è utile per lo studio autonomo.
Mostra di più47 pagine
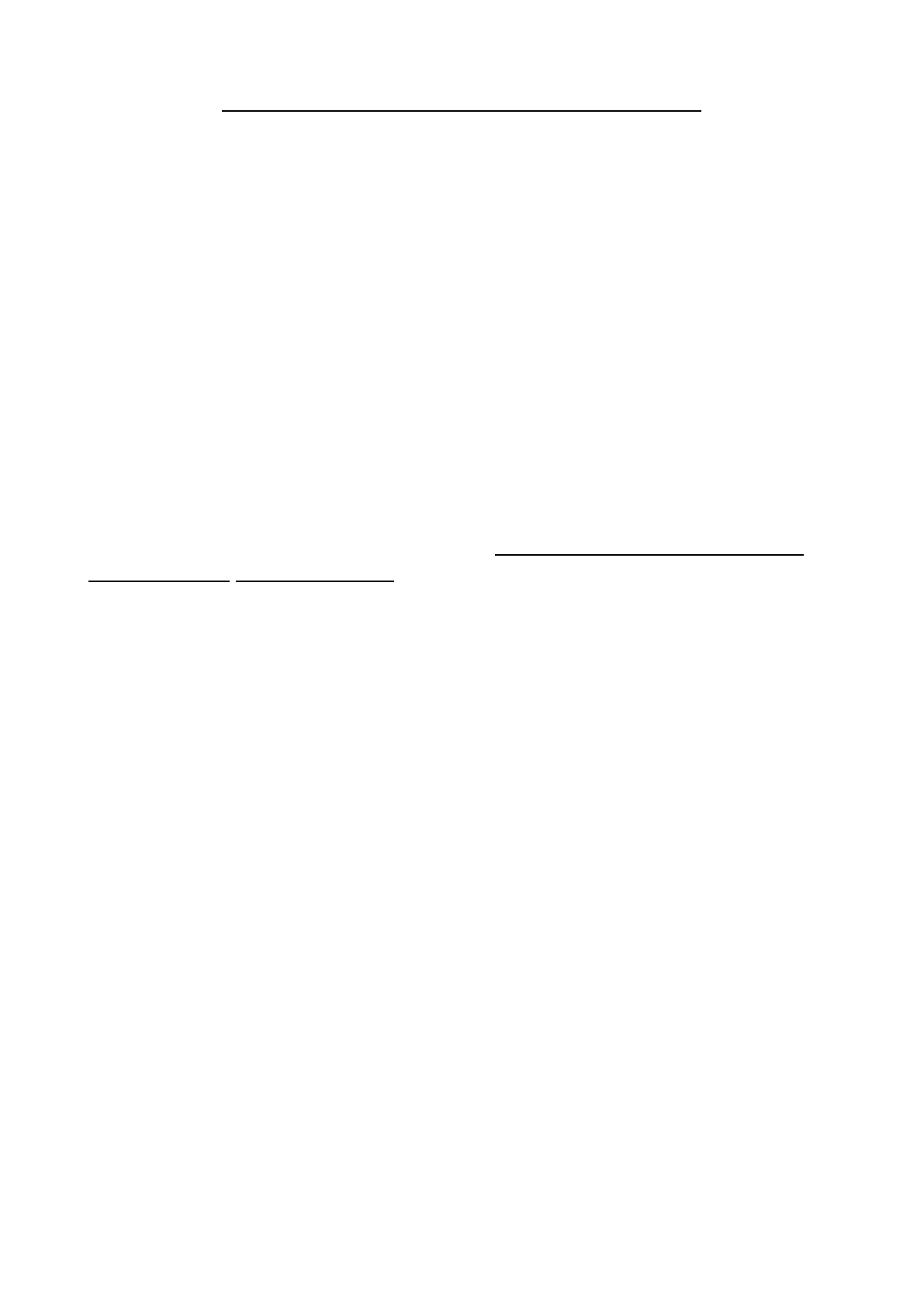
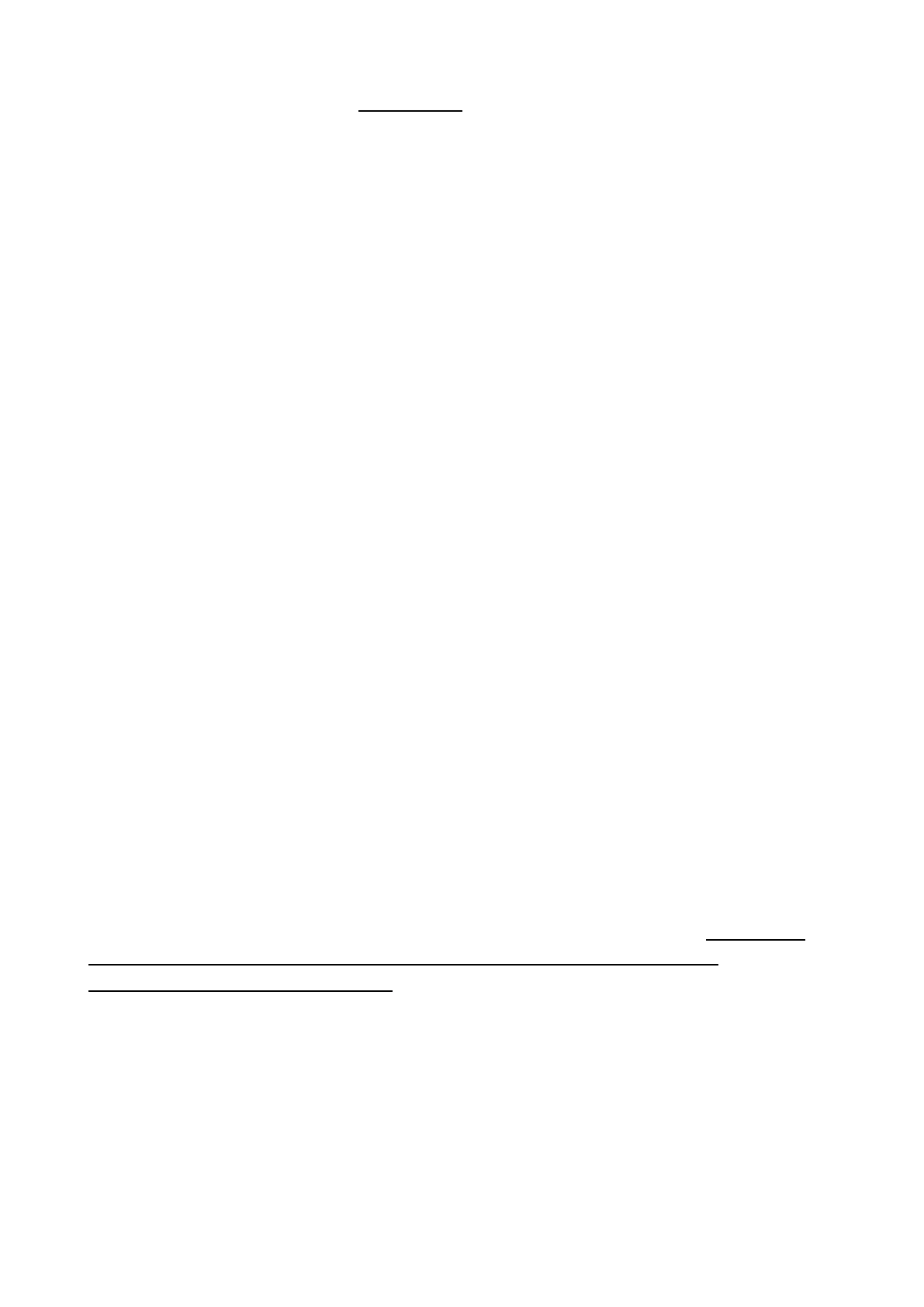
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
La Corte di Giustizia dell'UE: Organizzazione e Funzioni
Con "Corte di giustizia dell'UE" si intende la somma dei due organi giurisdizionali UE (Corte di Giustizia e Tribunale UE). Con la sola dicitura "Corte di Giustizia" si intende, invece, il singolo organo. La disciplina si ritrova nei due trattati TUE (art. 19, par. 1) e TFUE (artt. 251-281) e nello statuto della Corte di Giustizia, un protocollo allegato ai trattati. Per modificare le disposizione dello statuto occorre la procedura di revisione dei Trattati. La Corte e il Tribunale hanno dei propri regolamenti di procedura.
Caratteri generali della giurisdizione UE
La giurisdizione UE ha dei caratteri particolari, alcune delle quali la avvicinano alla giurisdizione dei tribunali nazionali. I tribunali internazionali hanno carattere arbitrale: perché essi possano decidere una controversia, le parti della controversia devono aver accettato la sua giurisdizione. La giurisdizione UE è, invece:
- obbligatoria: nel momento in cui uno Stato diviene membro UE si sottopone alla sua giurisdizione. Dunque, una parte pu essere convenuta unilateralmente dinanzi a alla Corte di Giustizia senza bisogno di accettazione della giurisdizione UE;
- permanente: i giudici siedono all'interno della Corte in maniera permanente;
- esclusiva: le controversie di competenza della CG e del Tribunale UE, non rientrano nelle competenze dei tribunali nazionali: vi è una netta separazione delle competenze.
- Le sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale UE sono equiparate alle sentenze emanate dai giudici nazionali;
- anche le persone fisiche e giuridiche, ad alcune condizioni, possono adire la Corte di Giustizia dell'UE.
Le funzioni degli organi giurisdizionali
La dottrina, nell'individuare le funzioni degli organi giurisdizionali UE, ha paragonato queste ultime alle funzioni che svolgono varie tipologie di tribunali nazionali. Ad esempio, quando la CG decide sul comportamento delle istituzioni UE ha una funzione simile a quella del giudice amministrativo; quando risolve controversie tra Stati ha una funzione assimilabile a quella di un giudice internazionale; quando risolve delle controversie tra funzionari e UE ha una funzione assimilabile a quella del giudice del lavoro.
-
Giurisdizione / funzione contenziosa: la Corte di Giustizia UE deve risolvere una controversia. Essa pu dover decidere sul comportamento degli Stati membri (ricorso per infrazione), pu dover decidere sul comportamento delle istituzioni UE; pu risolvere controversie tra UE e i suoi agenti/funzionari;
-
Giurisdizione / funzione contenziosa: la Corte non deve decidere una controversia, ma, semplicemente emette un parere relativo a una controversia o a trattati internazionale che l'UE intende concludere. Tale funziona si articola in due ulteriori funzioni: la competenza pregiudiziale (rinvio pregiudiziale) e la competenza consultiva (accordi internazionali e verifica della compatibilità con i Trattati). La più importante tra le due competenze è il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE): esso consiste nella possibilità, per i giudizi nazionali, di chiedere alla CG un parere su norme di diritto UE che devono applicare. Il rinvio si è dimostrato uno strumento molto efficace. Nell'ambito PESC la Corte di Giustizia dell'UE non ha competenze, eccetto i casi in cui deve delimitare il confine tra PESC e altri settori e i casi in cui decide sull'impugnazione di atti adottati dal Consiglio, nell'ambito PESC, nei confronti di persone fisiche o giuridiche.
Evoluzione organi giurisdizionali
1957: l'unico organo giurisdizionale previsto era la Corte di Giustizia, con le medesime competenze attribuite oggi a Corte di Giustizia e Tribunale UE; 1968: la CG si trova sommersa di ricorsi, causa per cui nasce il Tribunale di primo grado (oggi Tribunale); 2004: viene istituito il Tribunale della funzione pubblica, camera giurisdizionale a cui si attribuì il compito di risolvere controversie tra funzionari e istituzioni UE; 2009: il Trattato di Lisbona cambia le denominazioni -> CG dell'Unione = CG + Tribunale UE; 2016: il Tribunale della funzione pubblica viene assorbito dal Tribunale.
La Corte di Giustizia
Essa è composta da un giudice per ogni Stato membro (27) e da undici avvocati generali. Non è necessario che i giudici abbiano la nazionalità degli Stati membri che li abbiano nominati o proposti; inoltre non è possibile presentare delle richieste o degli esposti o reclami motivate dalla nazionalità dei giudici. Essi sono nominati di comune accordo dagli Stati membri, rimangono in carica sei anni e sono parzialmente rinnovati ogni 3 anni. Il rinnovo è parziale per fra sì che ogni nuova commissione comprenda dei giudici con esperienza al fine di garantire continuità ai lavori della Corte. Il comitato dei saggi formula un parere sulle nomine proposte dagli Stati membri; è composto sostanzialmente da ex membri della CG, del Tribunale, di governi nazionali o da giuristi di notoria competenza. Il parere riguarda le nomine di giudici e avvocati. Gli avvocati generali hanno il compito, prima che la Corte decida su una certa questione, di elaborare delle conclusioni, ossia di emettere un parere sulle modalità di risoluzione della questione. Essi sono nominati a rotazione (il numero degli avvocati è inferiore a quello degli Stati membri), anche se i 25 Stati grandi ne hanno sempre uno. La Corte decide in sezioni (3-5 giudici) o, su richiesta di Stati membri o istituzioni UE, nella Grande Sezione (15 giudici) o, ancora, in seduta plenaria, solo in casi eccezionali (ad es. pronuncia sulla cessazione di un membro della Commissione). La lingua ufficiale della Corte di Giustizia è il francese; la lingua dei singoli procedimenti è quella del singolo convenuto o quella del giudice a quo (ad es. rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana -> procedimento in italiano). Il procedimento si svolge in una fase scritta e in una, solo eventuale, fase orale.
Il Tribunale
Esso è composto da 54 giudici (2 per ogni Stato membro) che svolgono a turno la funzione di Avvocato Generale.
Ripartizione delle competenze e gradi di giudizio
Inizialmente il tribunale aveva una competenza residuale, mentre la competenza generale era attribuita alla CG. Oggi, invece, è l'inverso: la competenza generale spetta al Tribunale salvo diversa disposizione. Nonostante questa regola generale, la competenza riservata alla Corte è comunque ampia: infatti, in linea generale, il Tribunale non decide sui ricorsi per infrazione e sulle controversie tra Stati membri di cui all'art .. 273 tFUE; inoltre, esso non ha competenza pregiudiziale (se in futuro l'avrà, possibilità di rinviare alla CG). GRADI DI GIUDIZIO: le sentenze del Tribunale sono impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia per motivi di diritto (la Corte è un organo di secondo grado rispetto al Tribunale). La sentenza pu essere impugnata dalla parte soccombente, dagli Stati membri o dalle istituzioni UE. In caso di futura istituzione di camere giurisdizionali/tribunali specializzati si avrà la possibilità di impugnare le decisioni dinanzi al Tribunale come organo di secondo grade. Il Tribunale potrà poi anche chiedere un riesame da parte della CG.
Competenze Contenziose
Il ricorso per infrazione artt. 258-259 TFUE
ART. 258 TFUE: La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa pu adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. ART. 259 TFUE: Ciascuno degli Stati membri pu adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultima incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittoria la loro osservazioni scritte e orali. 3Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
Caratteri generali del ricorso per infrazione
Il ricorso per infrazione è un strumento di controllo del rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri. Vi sono due possibilità: il ricorso pu esser presentato dalla Commissione o da un altro Stato membro. La procedura non si svolge subito dinanzi alla Corte, ma c'è una fase pre contenziosa durante la quale si cerca una soluzione amichevole, in modo da portare davanti alla Corte le sole controversie non risolvibili in via giudiziale. Esso è uno strumento attraverso il quale anche gli individui, implicitamente, possono segnalare alla corte casi di violazione del diritto UE ad opera degli Stati membri. Con "violazione del diritto UE" si intende una violazione di qualunque obbligo discendente dal diritto dell'Unione, con alcune eccezioni: sono sottratte al ricorso per infrazione il divieto di disavanzi eccessivi; la PESC; l'art. 7 TUE. Come avviene una violazione? Una violazione del diritto UE pu derivare da un comportamento commissivo o omissivo da parte dello Stato membro. Quando la Corte ha valutato dei comportamenti degli Stati membri che potevano consistere in violazioni del diritto UE ha sempre tenuto un atteggiamento restrittivo, molto severo: ad esempio, ha ritenuto che il tardivo recepimento di una direttiva costituisce altresì una violazione del diritto UE. Inoltre, sono violazioni del diritto UE anche le violazioni solo potenziali: ad esempio:
- la semplice esistenza di una norma interna contraria al diritto comunitario, seppur non sia mai stata applicata, è sufficiente per essere considerata come violazione del diritto UE;
- l'interpretazione giurisprudenziale tale da conformare al diritto UE una norma interna sostanzialmente contraria non è sufficiente per eliminare la violazione;
- L'interpretazione giurisprudenziale tale da rendere una norma interna conforme al diritto UE incompatibile con lo stesso è sufficiente per costituire una violazione.
La violazione di alcune norme è oggetto di procedure diverse dal ricorso di infrazione.
L'imputabilità della violazione
Il ricorso per infrazione si ha se la violazione è avvenuta da parte di un qualsiasi organo statale, anche enti locali e organismi sottoposti al controllo dello Stato. Una delle particolarità è che è possibile, ed è successo, che sia imputato allo Stato anche il comportamento di privati: singoli dipendenti dai pubblici poteri, nelle ipotesi in cui lo Stato non abbia fatto tutto quanto in suo potere per prevenire o reprimere tale violazione. (V. sentenze Spagna e Regno Unito c. Francia (guerra delle fragole) e sentenza Schmidberger).