Linguaggio e comunicazione: disturbi, lingue dei segni e basi neurologiche
Documento di Agnese Zacchè Discipline Psicosociali - Tutor Cristiana Sanalitro su Linguaggio e Comunicazione. Il Pdf esplora la linguistica, i suoni del linguaggio, l'ontogenesi e i metodi di analisi, con un focus sui disturbi del linguaggio nel bambino, per il corso di Psicologia universitaria.
Mostra di più48 pagine
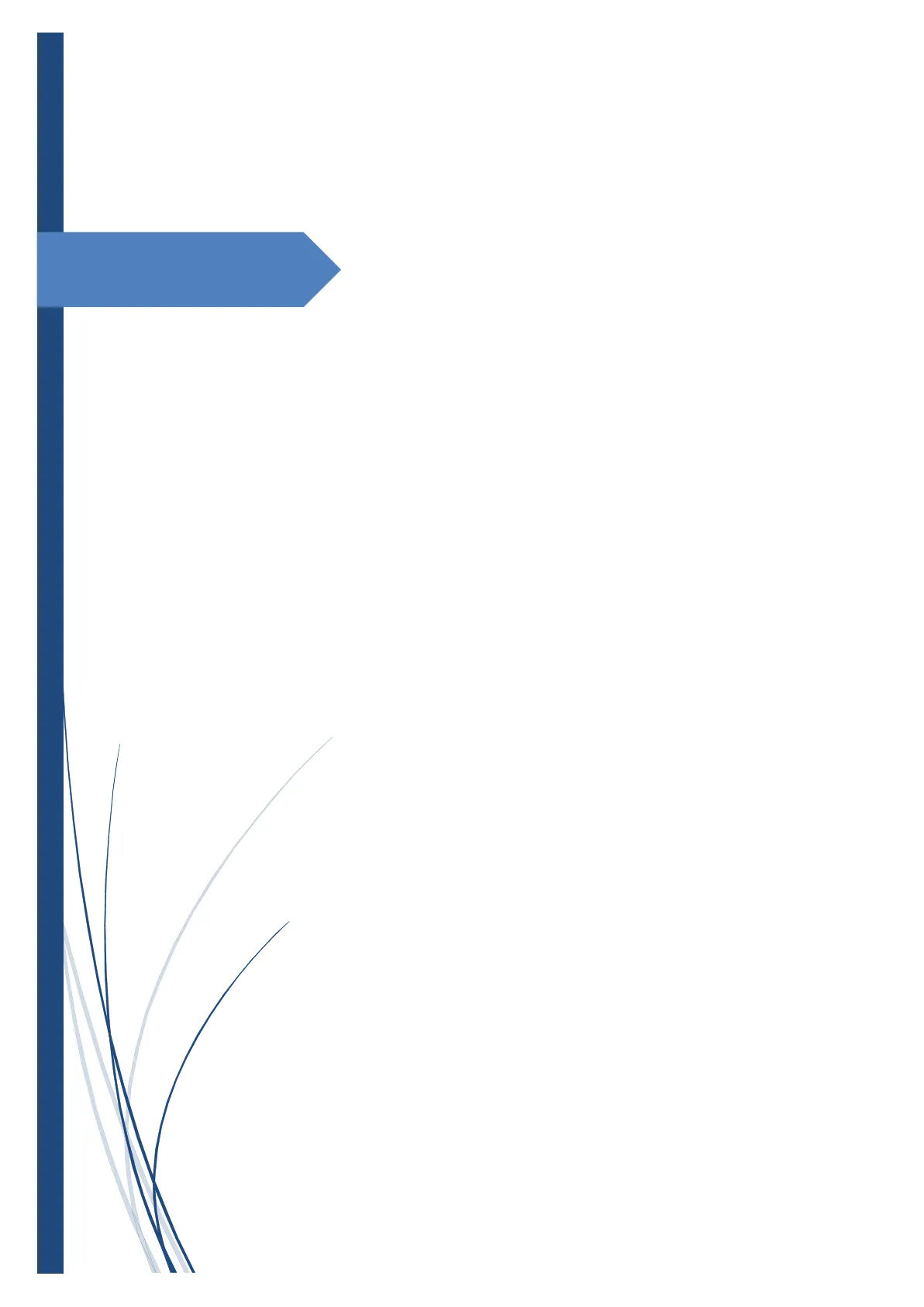

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
2024-2025 LINGUAGGIO e COMUNICAZIONE
Salvatore Maria Aglioti - Virginia Volterra
Agnese Zacchè
DISCIPLINE PSICOSOCIALI - TUTOR CRISTIANA SANALITRO
Sommario VDL
1Sommario
VDL N. 1 - LINGUAGGI E LINGUE
3
VDL N.2 LA LINGUISTICA
......
4
VDL N.3-I SUONI DEL LINGUAGGIO E LA FONOLOGIA
6
VDL N. 4-ONTOGENESI DEL LINGUAGGIO
8
VDL N. 5 METODI COMPORTAMENTALI DI ANALISI DEL LINGUAGGIO
10
VDL N. 6 - TECNICHE DI INDAGINE NEL LINGUAGGIO (prima parte)
12
VDL N. 7 - TECNICHE DI INDAGINE DEL LINGUAGGIO (seconda parte)
14
VDL N. 8 - RAPPORTI TRA MEMORIA E LINGUAGGIO
16
VDL 9 - I PROCESSI DI LETTURA SCRITTURA E CALCOLO
19
VDL N.10 - DISFARSI DELLE LINGUE
22
VDL N. 11 - VALUTAZIONE DEL LINGUAGGIO
25
VDL N. 12-I DISTURBI DEL LINGUAGGIO NEL BAMBINO
27
VDL N. 13 - LA COMUNICAZIONE VERBALE E I SUOI DISTURBI
30
VDL N. 14 - LA COMUNICAZIONE NON VERBALE E I SUOI DISTURBI
32
VDL N. 15 - IL GESTO COME FORMA DI COMUNICAZIONE
36
VDL N. 16 - LE LINGUE DEI SEGNI
37
VDL N. 17 - STORIA DELL'EDUCAZIONE DEI SORDIE RUOLO DELLE LS
39
VDL N. 18 - INIZIO DELLE RICERCHE SULLA LIS
41
VDL N. 19 - CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA LIS
43
VDL N. 20 - IMPARARE LA LINGUA DEI SEGNI
45
VDL N. 21 - LINGUA E CULTURA
47
2
VDL N. 1 - LINGUAGGI E LINGUE
Sistemi di comunicazione
I SISTEMI DI COMUNICAZIONE: sorgente e emittente, il messaggio viene codificato e quindi trasmesso, viene poi decodificato
(tradotto da un sistema all'altro) dal ricevente.
Esempio di codice sofisticato: danza delle api: le api sono in grado tramite la danza di acquisire e codificare informazioni sulla
distanza e sulla direzione di volo per raggiungere il cibo in base alla direzione del sole e alle energie spese. La danza
dell'addome in particolare serve per segnalare la presenza del cibo mentre quella circolare indica la distanza, più altritipi di
messaggio.
Nel canto dei passeriformi poi c'è un codice comunicativo segregato per area geografica. Altri esempi di complessità
comunicativa sono i segnali referenziali nei cercopitechi: c'è un tipo di segnale che ricorda un abbaiare che serve per indicare
la presenza dei leopardi, c'è un segnale che ha un suono più corto e secco, tipo tosse, che indica la presenza dell'aquila e c'è
un suono ripetuto e stridente che indica la presenza di serpenti.
Linguaggio parlato e condizioni richieste
Per linguaggio parlato, s'intende la capacità umana di utilizzare un codice arbitrario e convenzionale per esprimere,
comunicare e rappresentare la realtà interna ed esterna.
Le condizioni richieste perché la lingua udita e parlata venga messa in atto sono:
1) il contesto comunicativo: è necessario essere esposti ad una lingua (il neonato se esposto, può imparare tutte le lingue
del mondo;
2) l'integrità dei sistemi di input e di output (il sistema uditivo deve essere intatto e lo stesso vale per i sistemi d'uscita:
laringe per la produzione e il tratto sovra laringeo per l'articolazione del suono).
Lingue storico-culturali e proprietà
Lingue storico-culturali: la lingua parlata è immersa in un contesto storico, cioè cambia in relazione ai cambiamenti sociali
(vedi "dominazione "anglofona con conseguente introduzione nella lingua italiana di parole inglesi).
Proprietà:
- utilizzo del canale uditivo vocale (sistema d'ingresso e d'uscita);
- duplicità di struttura (prima e seconda struttura diarticolazione);
- creatività o apertura.
L'utilizzo del canale uditivo vocale: per le lingue parlate, il messaggio che per prima cosa è un codice acustico, viene prodotto
dai polmoni, la laringe fa da sorgente e il tratto sovra laringeo lo articola. Ciò che viene prodotto è un'onda sonora che
somiglia a lamenti o ad altri suoni ambientali, che per essere un suono linguistico deve subire una serie di trasformazioni.
All'uscita c'è uno spetto sonoro che si propaga nell'aria e che viene recepito da un altro parlante il quale estrae alcune
proprietà di base che sono l'altezza, l'intensità e il timbro di voce.
La duplicità di scrittura: una caratteristica del linguaggio è la doppia articolazione. Il linguaggio si basa sui fonemi (es. p, b), che
sono di numero limitato (20/30-100/150 lingue africane) che di per sé non significano nulla ma se combinati formano le
parole e acquistano significato. Le parole a loro volta vengono combinate in frasi che sono alla base della comunicazione. Sia
l'utilizzo del canale uditivo vocale che la duplicità di scrittura sono delle proprietà che possono rinvenute anche nei codici
animali (es. nel canto dei passeriformi si trovano delle unità sonore che ricordano i fonemi).
La creatività o apertura della lingua: consiste nella capacitàdi un nativo di una determinata cultura linguistica di interpretare e
produrre enunciati mai uditi o formulati prima. Questa è una capacità esclusiva del codice della lingua storico-culturale perché
gli altri codici (es. danza delle api) sono stereotipati.
Filogenesi del linguaggio
Filogenesi del linguaggio:
· con ontogenesi si fa riferimento allo sviluppo dell'organismo vivente (es. lo sviluppo dell'uomo a partire
dall'embrione).
•
La filogenesi fa invece riferimento dalle differenze fra le varie specie, cioè indica il cambiamento da una specie
all'altra fino ad arrivare in un'ottica un po' antropocentrica all'uomo.
E' stato visto che, a partire dall'Homo sapiens, nelle orme lasciate dai cervelli nei crani, c'è un'asimmetria degli emisferi
cerebrali con predominanza dell'emisfero sinistro, zona che riguarda la messa in atto dei comportamenti linguistici. Nessun
altro organismo sembra aver sviluppato un codice di complessità paragonabile a quello umano. Da studi compiuti da psicologi
americani sulle scimmie antropomorfe, si è rilevato che questi animali hanno una complessità cognitiva, sul piano
emozionale per esempio hanno mostrato comportamenti molto simili a quelli dell'uomo.
Sul piano della comunicazione linguistica però è stato rilevato che:
1) nelle scimmie antropomorfe non c'è l'istinto verso il linguaggio, a differenzadel bambino a cui basta essere immerso in un
ambiente linguistico per svilupparne icodici;
32)
non sono in grado di sviluppare tutta la complessità della lingua storico-culturale (il significato delle parole, il modo in cui
esse si combinano e anche dal punto di vista dellasonorità del linguaggio).
Una prima spiegazione del perché le scimmie non riescano a sviluppare un codice complesso come la lingua storico-culturale
sembra risiedere nel fatto che il cervello delle scimmie non è altrettanto complesso di quello dell'uomo, questo però fa
sorgere dei dubbi perché invece a livello emozionale le scimmie mostrano dei comportamenti sofisticati.
Un'altra spiegazione potrebbe risiedere in una proprietà del tratto sovra laringeo diverso nello scimpanzé e nell'uomo. Nelle
scimmie, come nel neonato, vi sono due canali separati,
•
uno per la respirazione
•
uno per la deglutizione.
Ciòconsente di mangiare e respirare insieme, ma non consente di produrre suoni complessi che sono alla base del linguaggio
vocale. Tra l'undicesimo e diciottesimo mese di vita del bambino, la laringe si sposta verso il basso rispetto al palato molle,
consentendo la formazione di una varietà di suoni.
Linguaggio e genetica: il gene FOXP2
Linguaggio e genetica: le moderne indagini genetiche, si sono focalizzate su un particolare gene chiamato FOXP2 il quale
codifica delle proteine molto importanti per lo sviluppo della corteccia cerebrale, presente in vari organi e in tante specie
(topo, scimmie ecc.). Una particolarità di questo gene è che è cambiato pochissimo nel corso della filogenesi. Questo gene fa
parte del cromosoma 7, differisce di soli due amminoacidi da quello dello scimpanzé e di tre da quello del topo. Secondo i
ricercatori, il gene FOXP2 codifica lo sviluppo normale del cervello nonchè lo sviluppo normale del tratto sovra laringeo che è
fondamentale per la produzione della complessa gamma di suoni linguisticied in particolare di suoni vocalici, e consentono
all'uomo di produrre tutto il linguaggio articolato che è invece assente nelle specie diverse dall'uomo anche se molto vicine.
VDL N.2 LA LINGUISTICA
Linguistica e livelli di analisi
Linguistica: disciplina che studia e descrive il linguaggio.
Linguistica e i vari livelli di analisi del linguaggio:
· la sociolinguistica: è la disciplina che si occupa di descrivere, studiare i cambiamenti, l'evoluzione del linguaggio in
relazione ai vari contesti sociali.
.
Parlando di lingue storico-culturali, c'è un'influenza del contesto culturale e del contesto ambientale sul modo in cui
si usa il linguaggio. La sociolinguistica si occupa ad esempio dell'accento di una persona, non solo sul piano della
fonologia ma anche sul piano delle espressioni che vengono utilizzate.
L'interlinguistica: è una disciplinache si occupa di paragonare le varie realizzazioni della forma del linguaggio, lingua
storiconaturale, di paragonare il modo in cui le varie lingue utilizzano le espressioni, gli accenti e le inflessioni.
· La psicolinguistica: è una disciplina che si occupa dei processi inerenti al linguaggio.
.
La neurolinguistica: studia il modo in cui il linguaggio viene messo in atto, viene compreso e viene prodotto ma
sempre con attenzione verso la struttura nervosa sottostante. Tutte queste discipline riconoscono che il linguaggio è
legato al cervello.
Ci sono poi delle sotto discipline che studiano i vari aspetti del linguaggio: i suoni, i significati, la concordanza fra le varie parti
del discorso. Ad esempio:
➢
la fonetica e la fonologia si occupano di studiare i suoni del linguaggio, cercando di caratterizzando le unità minime
dei suoni del linguaggio, tenendo presente che a questo livello i suoni linguistici non hannoancora un loro significato.
>
La semantica si occupa di studiare il significato delle parole come unità del linguaggio.
➢
La morfologia si occupa di studiare la concordanza fra le parole in genere ed ha a che vedere con gli aspetti
grammaticali della lingua.
➢
La sintassi si occupa di studiare le regole con le quali le parole, le parti del discorso, vengono combinatefra loro.
➢
La pragmatica si occupa di descrivere i significati che vanno al di là dell'espressione linguistica come ad
esempio le ironie, le metafore ed i significati impliciti.
La ricerca psicolinguistica (analisi del testo), si occupa anche di studiare come sia possibile non solo leggere ma capirne il
significato, la coerenza interna, la coesione.
Ciò è possibile in soggetti senza particolari patologie, la neurolinguistica sta iniziandorecentemente ad indagare questa
proprietà in determinati categorie di pazienti, ma ha un livello molto complesso.
Fonetica e fonema
La fonetica: l'unità minima e non significante del linguaggio è il fonema, vale a dire la proprietà di un suono linguistico di
essere distinto da un altro che gli somiglia (es. b/elle e p/elle, parole dal significato totalmente diverso che differiscono per i
fonemi di tipo occlusivo). Il fonema non esiste nella realtà, è un concetto, ma esiste l'allofono cioè la realizzazione fonica del
fonema stesso.
4