Psicologia giuridica: intersezione tra psicologia e diritto
Documento di Università su Psicologia giuridica. Il Pdf esplora la relazione tra psicologia e diritto, trattando argomenti come la Parental Alienation Syndrome, la criminalità minorile e la ludopatia, con un focus sui reati di plagio e atti persecutori. Questo documento di Psicologia è utile per studenti universitari.
Mostra di più50 pagine
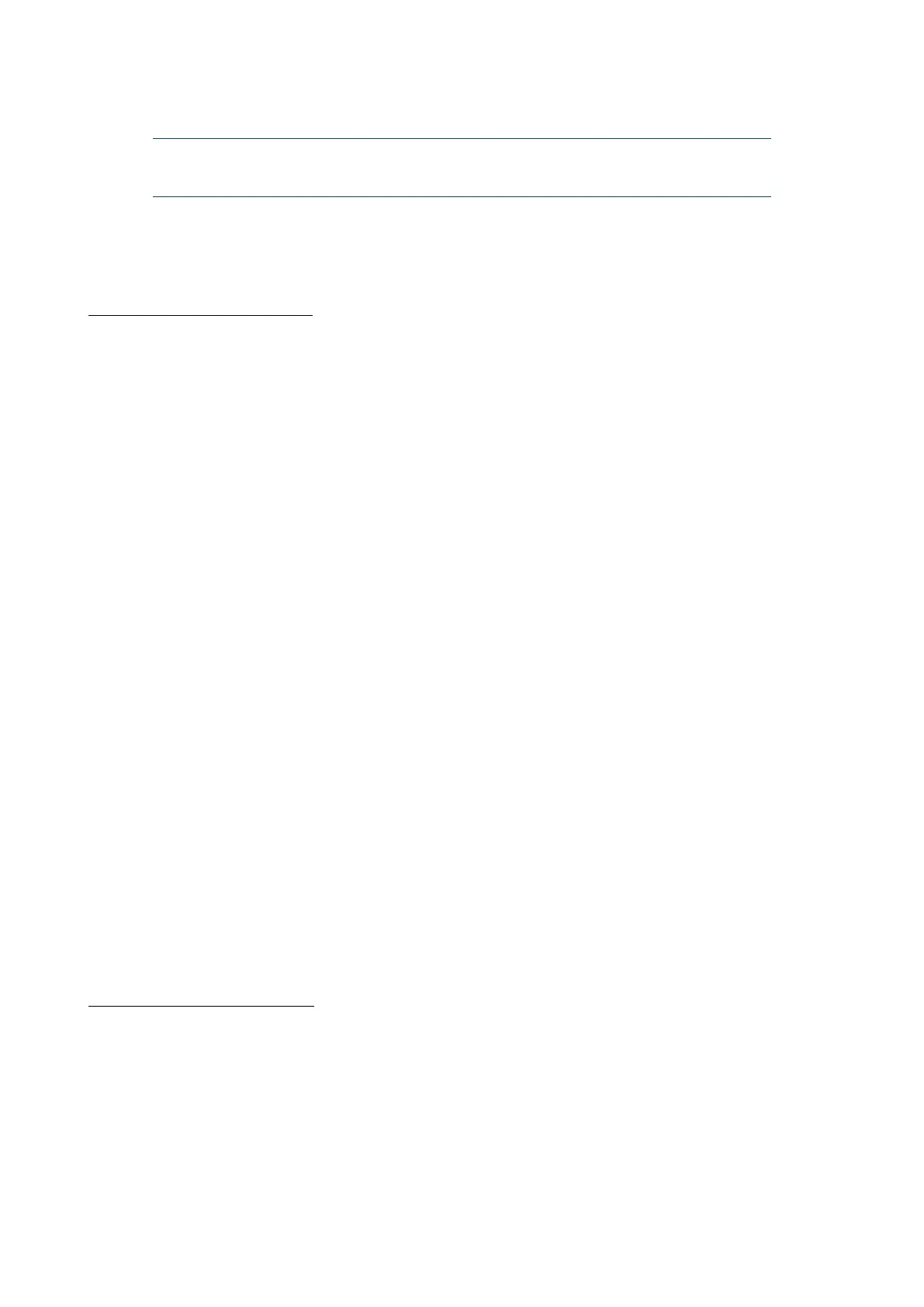

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Modulo Giuridico e Psicologia
La relazione tra psicologia e diritto
Parental Alienation Syndrome (PAS)
La sindrome di alienazione parentale si riferisce all'azione di un genitore che mette in cattiva luce l'altro genitore, influenzando negativamente la relazione tra il minore e quest'ultimo. In ambito psicologico, esiste un dibattito sulla vera natura di questa condizione: alcuni la considerano una sindrome ben definita, mentre altri ritengono che sia una categorizzazione troppo rigida per un comportamento di condizionamento. Questo conflitto si riflette anche nel sistema giuridico, dove i giudici trovano difficoltà a prendere decisioni chiare riguardo a questi casi. La PAS rappresenta un esempio di come le conoscenze psicologiche possano influenzare le decisioni giuridiche.
Criminalità minorile e imputabilità
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a casi di cronaca allarmanti riguardanti adolescenti che commettono atti violenti, arrivando anche a togliere la vita a un'altra persona. La criminalità minorile solleva interrogativi sul rapporto tra psicologia e diritto. In ambito penale, un minore è considerato imputabile se ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Gli psicologi notano che i minori sembrano possedere competenze comportamentali superiori rispetto alle generazioni precedenti, ma non hanno raggiunto un livello adeguato di maturità. Secondo le neuro scienze, la piena maturità si sviluppa intorno ai 20-21 anni. Questo porta a interrogarsi sulla responsabilità penale dei minori e sul loro grado di imputabilità.
La ludopatia, ad esempio, intesa come impulso irrefrenabile al gioco d'azzardo, può compromettere seriamente la vita quotidiana di un individuo, inclusa quella di un minorenne. L'articolo 90 del codice penale del 1930 stabilisce che stati emotivi e passionali non escludono ne diminuiscono l'imputabilità. Tuttavia, il codice non definisce chiaramente cosa si intenda per "stato emotivo" o "stato passionale", e le scienze psicologiche devono fornire questo contesto. La posizione del codice è chiara: tali stati non incidono sulla responsabilità penale.
Dialogo tra psicologia e diritto
Esistono notevoli difficoltà nel dialogo tra le scienze psicologiche e quelle giuridiche. Non è corretto affermare che emozioni come l'ira o la gelosia non possano influenzare il comportamento. Spesso, gli autori di atti violenti giustificano le loro azioni con frasi come "ho agito per gelosia". D'altra parte, il codice del 1930 afferma che tali stati non sono rilevanti per la responsabilità. È importante investigare la condizione psicologica dell'individuo che ha compiuto un gesto violento.
1Imputabilità e vizio di mente: su ciascuno di noi al compimento del diciottesimo anno di età cade una presunzione, presunzione di capacità di intendere e di volere, quindi capacità di autodeterminarsi in relazione alle nostre azioni. Si tratta di una presunzione relativa: può essere smentita dalla prova contraria Se un reato presenta elementi di anomalia, è fondamentale chiedersi se l'individuo avesse disturbi psichici. Un vizio totale di mente esclude l'applicazione della pena, mentre un vizio parziale consente una condanna con pena ridotta.
L'importanza di un approccio interdisciplinare è cruciale per affrontare problemi complessi. È essenziale coinvolgere esperti nei rispettivi campi: l'avvocato per la parte giuridica e lo psicoterapeuta per la parte psicologica, affinché possano collaborare per risolvere le questioni in modo efficace e completo.
Definizione e Ambiti della Psicologia Giuridica
La psicologia giuridica come disciplina
La psicologia giuridica è una disciplina relativamente recente, priva di una tradizione storica consolidata. Le cattedre dedicate a questa materia sono emerse solo negli ultimi decenni, segnando un nuovo approccio interdisciplinare ai problemi psicologici legati al diritto.
Non esiste una definizione precisa e univoca della psicologia giuridica; sono state proposte diverse definizioni, ciascuna delle quali mette in evidenza sfumature che riflettono l'approccio di ciascun studioso. In generale, la psicologia giuridica può essere intesa come l'applicazione della psicologia (scienze del comportamento) al diritto in senso lato, con un focus su approcci psicosociali e ampi spazi dedicati al lavoro clinico e alla ricerca criminologico-clinica.
Un aspetto centrale di questa disciplina è il lavoro clinico, che si ricollega alla psicologia clinica. Questo implica l'analisi di comportamenti attraverso la ricostruzione e la diagnosi. La psicologia giuridica include quindi indagini cliniche e ricerche sul campo, contribuendo anche allo studio del crimine, un ulteriore ambito disciplinare di interesse.
Definizione di Enrico Ferri (1925)
Una delle definizioni di psicologia giuridica è del 1925, proposta da Enrico Ferri, esponente della scuola positiva, che si interrogava su cosa fosse la psicologia giuridica. Si tratta di una definizione contenuta in una prefazione, Torino, 1925 La psicologia giudiziaria di Altavilla: lo studio del delinquente ha determinato la formazione di quattro branche scientifiche per la formazione psicologica della personalità:
- Psicologia criminale: studia il delinquente in quanto autore di un delitto, di un reato.
- Psicologia giudiziaria: studia il delinquente, il suo contegno, in quanto imputato di un delitto, quindi già collocato nella dimensione processuale.
- Psicologia carceraria: studia il delinquente quando è già stato condannato, in espiazione di una pena carceraria.
- Psicologia legale: coordina le nozioni psicologiche, quindi entrano le conoscenze psicologiche nel mondo giuridico, e psicopatologiche che occorrono per l'applicazione delle vigenti norme penali. Ne emerge la cooperazione tra psicologia e diritto rapportata ad un testo normativo, norme penali che contengo elementi di riferimento psicologico.
2La definizione si concentra su un ambito specifico: il soggetto che commette un reato, il soggetto delinquente. Ogni definizione ha però una sua autonomia e identità. Vediamo prospettive differenti e tante definizioni elaborate nel corso del tempo, ma si fa riferimento a quella di Ferri in quanto più aperta e differenziata.
Partizione della psicologia giuridica secondo Guglielmo Gulotta
Guglielmo Gulotta Si è resa ora molto più complessa la definizione di psicologia giuridica, vediamo una partizione della psicologia giuridica:
- Criminale: studia l'uomo autore del reato, la vittima e la situazione criminale vittimologica.
- Investigativa: relativa alle attività cognitive e di azione necessarie per le indagini sui delitti. Identica anche l'ambito delle indagini, andare alla ricerca di elementi che facciano comprendere la commissione di un reato è un'attività di tipo investigativo.
- Forense: attiene alla dimensione processuale. Si occupa dei fattori patologici rilevanti al fine della valutazione giudiziaria.
- Rieducativa: studia il significato, il valore, l'utilità e l'effetto sull'individuo della pena o di altro trattamento. Ambito strettamente collegato alle funzioni della pena. Fondamento ritrovato nell'articolo 27 della costituzione: le pene non devono e non possono coesistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per rieducazione intendiamo una promozione del comportamento.
- Legislativa: contribuisce alla produzione e al miglioramento delle norme giuridiche.
- Legale: affine alla legislativa, coordina le azioni psicologiche utili all'applicazione di norme penali e civili.
- Giudiziaria: studia l'imputato e gli altri attori del processo, testimoni, giudici e avvocati.
Negli ultimi sviluppi, la psicologia ha ampliato le sue competenze, includendo, ad esempio, lo studio della condizione psicologica di soggetti responsabili di significativi dissesti aziendali. Dietro scelte azzardate che hanno avuto conseguenze negative si trovano persone con tratti psicologici specifici. Un esempio è lo "psicopatico aziendale", il quale prende decisioni disastrose a causa di impulsività e scarsa empatia.
La psicologia giuridica si occupa anche di altri ambiti, come la psicologia dell'età evolutiva e delle relazioni familiari, la psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, nonché la psicologia cognitiva applicata ai processi decisionali e al problem solving.
Questi nuovi scenari e ricerche dimostrano come la psicologia giuridica rappresenti una collaborazione tra diverse scienze, progettata per affrontare i problemi attuali. Inoltre, si cerca di stabilire una cooperazione tra competenze diverse, assicurando che ciascun esperto mantenga la propria autonomia.
Il Reato di Plagio
Vincolo di realtà e di razionalità
REATO DI PLAGIO: articolo 603 c.p. (*) (non esiste più, in quanto inserito nel codice penale del 1930) la corte costituzionale con sentenza 8 giugno 1981 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Si può definire un reato comune: chiunque poteva incorrere a questa sanzione; la pena è abbastanza importante.
Noi per plagio intendiamo un profondo condizionamento psicologico, una persona plagiata non ha capacità di decidere per conto suo. Una norma che richiama molto da vicino una verifica delle condizioni psicologiche del soggetto passivo del reato. Per verificare se la norma funziona è necessario capire se la persona offesa, è effettivamente in condizione di totale stato di soggezione.
Era comunque una norma problematica nel momento della sua applicazione, in quanto i giudici, nel cercare di applicare la norma, si sono trovati di fronte a grandi difficolta: il plagio esiste, ma come si fa a plagiare così tanto? Si pena quindi all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o all'esercizio di azioni di tipo fisico. Ma se si tratta di condizionamento solo sul piano psicologico siamo sicuri che riusciamo a vedere realizzato questo reato? Parliamo di Impossibilità di dimostrare che una persona possa essere completamente plagiata.
C'è stato quindi l'intervento della corte costituzionale, i giudici di primo grado sono stati investiti di procedimenti penali dove una persona veniva accusata di plagio, essi hanno quindi accusato dubbi sulla razionalità di questa norma. Si sono rivolti alla corte costituzionale, la quale ha dato ragione ai dubbi dei giudici. Nella sentenza dell'8 giugno 1981 n.96, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, l'articolo 603 è contrario all'articolo 25 comma 2 della costituzione.
Sorgono spesso dubbi rispetto al plagio, nella realtà può accadere che una persona subisca un condizionamento o un'influenza da parte di un'altra. La corte costituzionale è stata però chiarissima: questa norma non esiste più.
4