Geografia: pensiero meridiano e decolonizzazione della storia
Documento universitario di Geografia sul pensiero meridiano e la decolonizzazione della storia. Il Pdf esplora come le narrazioni storiche siano influenzate dai rapporti di potere, analizzando capitalismo, colonialismo e patriarcato, e discute la linea abissale e il tempo lineare come strumenti di controllo.
Mostra di più61 pagine
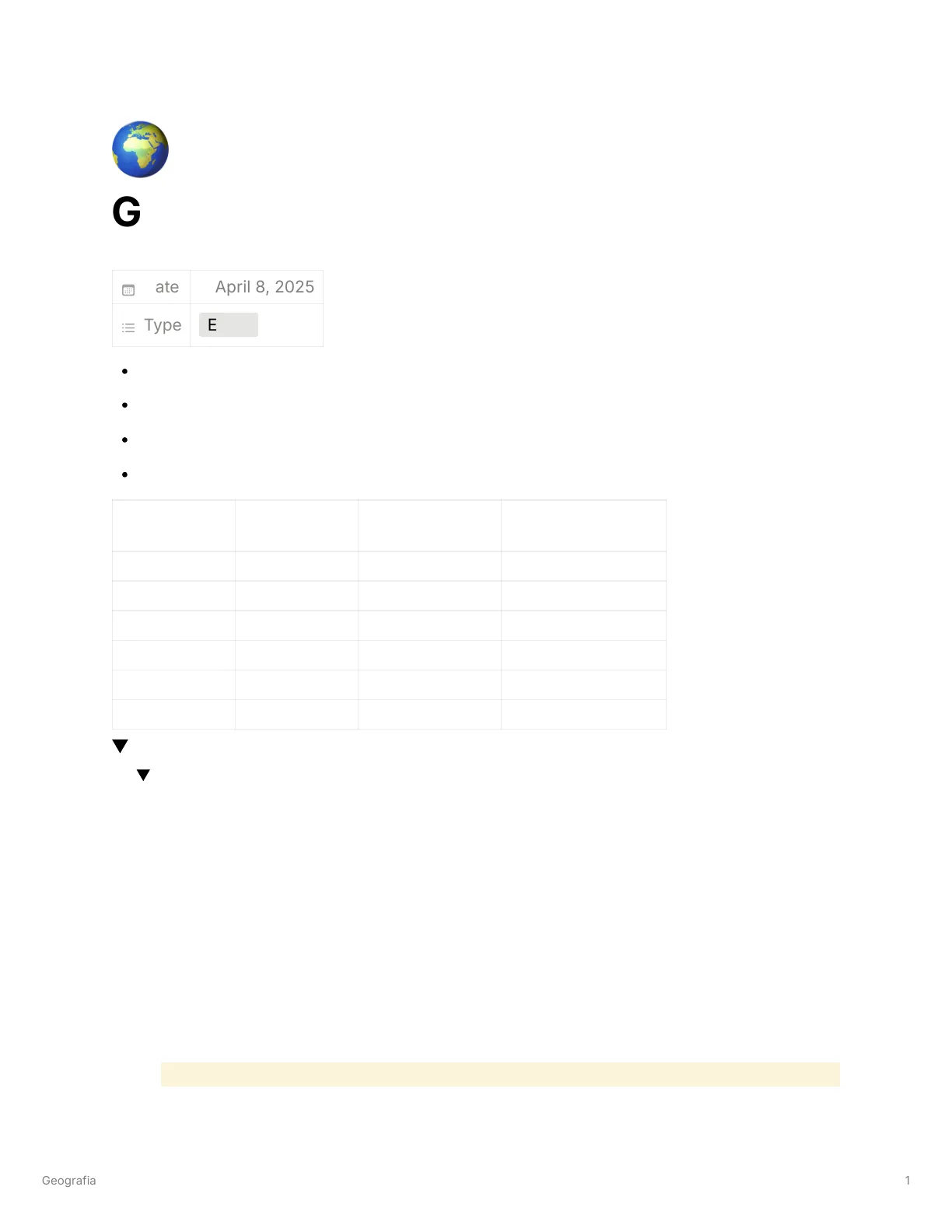

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Geografia
Date
@April 8, 2025
= Type
Exam
- il pensiero meridiano= 150p
- appunti di geografia= 313 p
- decolonizzare la storia= 116p
- 579p per (25) 31gg= 24xday
giorni
app. geografia
pensiero
meridiano
decolonizzare la
storia
2
3
4
5
6
7
V
Il pensiero meridiano di Franco Cassano
Prefazione
Il Pensiero meridiano nasce dalla riflessione sul lato d'ombra delle identità e dall'esperienza dell'«altro», come risposta alle rappresentazioni negative del Sud nella cultura dominante. L'autore evidenzia l'ambiguità della verità, sostenendo che "nessuna identità possa pretendere un rapporto privilegiato con la verità". In questo quadro, il revisionismo, un tempo sfida contro le narrazioni ufficiali, oggi appare come un adeguamento ai nuovi rapporti di forza. Il Pensiero meridiano si articola esplicitamente su due piani: la scissione, intesa come la rottura con i modelli dominanti per affermare l'autonomia del Sud, e la mediazione, volta a difendere la pluralità delle esperienze e a contrastare l'arroganza dei vincitori. In sostanza, il testo invita a un riequilibrio del mondo, fondato sull'idea che "la ragione del futuro o sarà plurale o non sarà".
Autonomia del Sud
1La rivendicazione dell'autonomia del sud significa affermare che il sud non è semplicemente un "non-ancora" del nord, ma un punto di vista autonomo e portatore della propria dignità. In questo senso, "il cuore del progetto è quello di restituire al sud l'antica dignità di soggetto del pensiero", cioè di far emergere un'identità che non debba essere definita in relazione al nord, ma che abbia valore in sé stessa. Si parla di un primo passaggio fondamentale: la rottura della vecchia gerarchia che relegava il sud a uno stadio incompiuto, rifiutando l'idea che il futuro debba essere un continuo inseguimento di un modello imperfetto.
Parallelamente, il testo sottolinea l'importanza di trasformare il rapporto con i luoghi, superando una visione limitata ai confini nazionali e abbracciando una prospettiva più ampia che connette il sud italiano con gli altri sud del mondo. Questo significa "riguardare i luoghi" non solo dal punto di vista geografico, ma anche trasformare il rapporto cognitivo ed affettivo con essi, curando e ricostruendo i beni pubblici che rappresentano identità, solidarietà e sviluppo. In sostanza, l'autonomia proposta è "grande" e va oltre una semplice rivendicazione locale, poiché vuole superare la condizione di periferia imposta dalla storia e dai modelli culturali dominanti, aprendo la strada a un futuro in cui "la ragione del futuro o sarà plurale o non sarà".
Lentezza
L'autore riflette sul valore della lentezza in contrapposizione alla frenesia del mondo moderno, sottolineando come l'accelerazione costante comprometta esperienze fondamentali come l'amore, la riflessione, l'educazione e la convivialità. Il progresso, identificato spesso con la velocità, porta con sé nuove possibilità, ma al tempo stesso distrugge forme di conoscenza e relazioni umane che necessitano di tempo per svilupparsi.
L'ossessione per la rapidità è un tratto distintivo della modernità, che si è evoluta da una fase solida e strutturata a una condizione fluida e instabile, come descritto da Bauman. Questo processo ha portato allo smantellamento di istituzioni e certezze che garantivano stabilità, creando un individualismo esasperato e una società priva di memoria storica. L'innovazione incessante, simbolo del capitalismo globale, sacrifica ogni forma di durata, generando un presente effimero e un futuro incerto.
La velocizzazione influisce non solo sulle relazioni sociali, ma anche sulla democrazia, che appare sempre più come una perdita di tempo rispetto alle esigenze del mercato e del profitto. In questo contesto, rivendicare la lentezza non significa abbandonarsi a una nostalgia reazionaria, ma riscoprire il valore del tempo lungo come spazio essenziale per il pensiero, la cultura e la costruzione di un'alternativa alla deriva distruttiva del presente. L'Europa, se vuole ritrovare un'identità autonoma, ha molto da imparare da una visione più equilibrata del tempo, come suggerisce lo sguardo del sud.
Geografia
Mediterraneo
Il Mediterraneo, tradizionalmente visto come uno spazio di incontro e scambio, negli ultimi decenni ha assunto una doppia natura. Da un lato, si configura come via di comunicazione e speranza per i migranti, che intravedono in esso il passaggio verso una nuova vita; dall'altro, viene trasformato in un confine che delimita l'accesso e, in termini politici, trasforma chi lo attraversa in "illegali". L'immagine di una barca carica di migranti, dunque, non solo richiama l'idea del viaggio e della rinascita, ma diventa anche simbolo di esclusione e del giudizio imposto dalla legge e dalle politiche nazionali.
Il Mediterraneo si presenta così come un "luogo di inclusione ed esclusione": da un lato, rappresenta la possibilità di raggiungere nuove terre e culture, mentre dall'altro l'atto stesso del transito viene marcato da una condizione di illegalità. È importante sottolineare che questa visione del mare non è un dato naturale, ma il risultato di scelte politiche esplicite. Le decisioni politiche determinano, infatti, dove finiscono i confini fisici e dove hanno inizio le lotte per i diritti umani, trasformando il Mediterraneo in una costruzione ideologica che decide chi può attraversarlo e chi no.
Da un punto di vista storico, tuttavia, il Mediterraneo è sempre stato molto più di una mera barriera: per secoli è stato un crocevia di popoli, culture e civiltà. Franco Cassano, nel suo "Pensiero Meridiano", sottolinea come questo mare rappresenti un concetto ricco di significati culturali e politici, un'area capace di unire anziché dividere. Tale visione storica mette in luce come le divisioni attuali siano il frutto di scelte moderne, che ignorano la tradizione di connessione e incontro che da sempre caratterizza il Mediterraneo.
Un ulteriore spunto di riflessione riguarda la relatività dei concetti di Oriente e Occidente. Queste categorie, spesso presentate come opposte e immutabili, sono in realtà costruzioni eurocentriche e dipendono dal punto di vista adottato.
ll concetto di Oriente, analizzato da Edward Said nel quadro dell'Orientalismo, si rivela non come una realtà fissa, ma come un'invenzione che serve a definire i confini simbolici tra mondi. Il Mediterraneo, collocato proprio tra queste dimensioni, sfida tali dicotomie e apre la strada a una nuova interpretazione dello spazio, in cui le categorie tradizionali vengono messe in discussione.
Infine, l'analisi della carta di Bertan, che ribalta la classica prospettiva nord-sud per porre il Mediterraneo al centro, evidenzia come questo mare non sia soltanto un elemento fisico, ma anche un laboratorio in cui si intrecciano le scelte politiche, storiche e culturali. In questo modo, il Mediterraneo diventa un luogo che stimola una riflessione ampia sulle connessioni e le divisioni, sulle modalità di inclusione ed esclusione, invitandoci a riconsiderare le nostre percezioni di confine e di appartenenza.
Questa visione integrata del Mediterraneo ci spinge a comprendere che la realtà geografica non è predeterminata: è il risultato di scelte politiche e ideologiche che
Geografia
possono trasformare un limite in un ponte, un confine in un percorso di connessione e speranza.
Riassunto per capitoli
Ecco un riassunto dettagliato capitolo per capitolo della fonte "Il pensiero meridiano" di Franco Cassano, basato sugli estratti forniti:
Prefazione: Paralleli e meridiani
In questa prefazione, l'autore riflette sulla molteplicità di reazioni che "Il Pensiero meridiano" ha suscitato dalla sua pubblicazione nel 1996, spaziando dall'adesione incondizionata alla contrapposizione sospettosa. Cassano nota come non siano mancate semplificazioni dell'ordito del discorso e come spesso l'analisi delle tesi del libro non abbia tenuto conto di tutte le sue dimensioni. Riconosce che l'autore stesso potrebbe non aver reso espliciti i fili che connettevano la trama teorica di questo libro a quelli precedenti e al dibattito internazionale, ritenendoli evidenti. Lo scopo principale della prefazione è quindi ricostruire l'intersezione di piani contenuta nel "Pensiero meridiano" per consentire una discussione più precisa.
L'autore spiega che il suo avvicinamento al sud e al pensiero meridiano non è nato da una passione identitaria, ma dalla categoria dell'«altro», da una riflessione sul lato d'ombra di ogni identità. La spinta verso la rivendicazione del valore del sud è scaturita dalla ribellione alle sue rappresentazioni nella cultura dominante, al razzismo talvolta inavvertito. Chi proveniva da questo percorso verso il sud non cercava il ripristino di una tradizione integra, ma nutriva una diffidenza sistematica verso le maiuscole e gli inchini ad esse, convinto che nessuna identità possa arrogarsi un rapporto privilegiato con la verità. L'attenzione costante per i punti «deboli» di ogni discorso «forte», la difesa della molteplicità e della varietà culturale sono state le motivazioni principali.
Il "Pensiero meridiano" intreccia due dimensioni: quella della scissione e della mediazione. Da un lato, il bisogno di rottura e rivendicazione dell'autonomia del sud contro una falsa neutralità universale; dall'altro, la difesa della pluralità culturale. L'obiettivo del libro è elaborare una forma di intersezione tra rottura e mediazione per affrontare la complessità del compito.
Un passaggio essenziale è la rivendicazione radicale dell'autonomia del sud, con
Geografia
l'obiettivo di restituirgli l'antica dignità di soggetto pensante, interrompendo la sequenza in cui è stato pensato solo da altri. Il sud non deve essere visto come un "non-ancora" che deve imitare il nord, ma deve comprendere che il futuro può non essere un inseguimento fallimentare. Questa autonomia nasce dalla relativizzazione dell'universo simbolico dominante, dalla neutralizzazione della sua pretesa di centralità e unicità. Un sud che riprende a pensarsi autonomamente capovolge la rappresentazione dominante, scardinando la concezione del tempo sottesa a essa.
Parallelamente, si afferma una trasformazione del rapporto con i luoghi, connettendo il sud italiano con i sud del mondo, non per assimilazioni equivoche, ma per contrastare l'idea che l'emancipazione del sud italiano sia una questione separata. Si rivendica la specificità della sua posizione geografica e culturale, sottolineando l'importanza di «riguardare i luoghi» nel duplice senso di averne riguardo e di tornare a guardarli. Ciò implica dilatare lo sguardo oltre i confini nazionali, scorgere nuove connessioni e inserire la discussione sul sud nel dibattito teorico internazionale, ma anche trasformare il rapporto cognitivo e affettivo con i luoghi, basato sulla cura e sul rispetto. L'idea-forza è quella di un riscatto del sud, della sua uscita dalla minorità in autonomia.
L'autore riflette sul riscontro avuto dal libro, attribuendolo all'intersezione tra un quadro teorico nuovo e un bisogno diffuso di riscatto nel sud. Respinge le accuse di connivenza con i "vizi" meridionali o di leghismo del sud, spiegando che l'orgoglio inteso nel libro designa la fiducia nei propri mezzi e la volontà di accettare le sfide senza tutori. Molti dei cosiddetti "vizi" meridionali sono l'effetto di una lunga emarginazione. Il pensiero meridiano non è indulgente verso il sud esistente, ma ne costituisce la negazione spingendo verso l'azione e l'apertura. L'autonomia sottesa è dura ed esigente, mirante a mutare il rapporto tra Italia, Europa e Mediterraneo. Una possibile obiezione è il titanismo del progetto e la sottovalutazione della sproporzione tra ambizione e forze in campo.
Il pensiero meridiano non è una difesa della tradizione, così come la rivendicazione dell'autonomia femminile non è un'idealizzazione della posizione tradizionale della donna. Si tratta di una critica della falsa neutralità e universalità dei modelli culturali dominanti, un ampliamento del futuro e delle libertà. L'autore nota come la rivendicazione di una differenza screditata sia comune a molte forme di ribellione, come l'emancipazione coloniale e gli studi post-coloniali. La strategia migliore è far circolare le esperienze senza privilegiarne una come originaria.