Psicologia dello sviluppo e dell'educazione applicata all'esercizio fisico
Documento sulla psicologia dello sviluppo e dell'educazione applicata all'esercizio fisico. Il Pdf, di livello universitario e materia Psicologia, analizza stili educativi, processi di apprendimento e conflitto cognitivo, presentando uno studio sull'efficacia di un programma motorio-cognitivo per bambini in età prescolare.
Mostra di più64 pagine
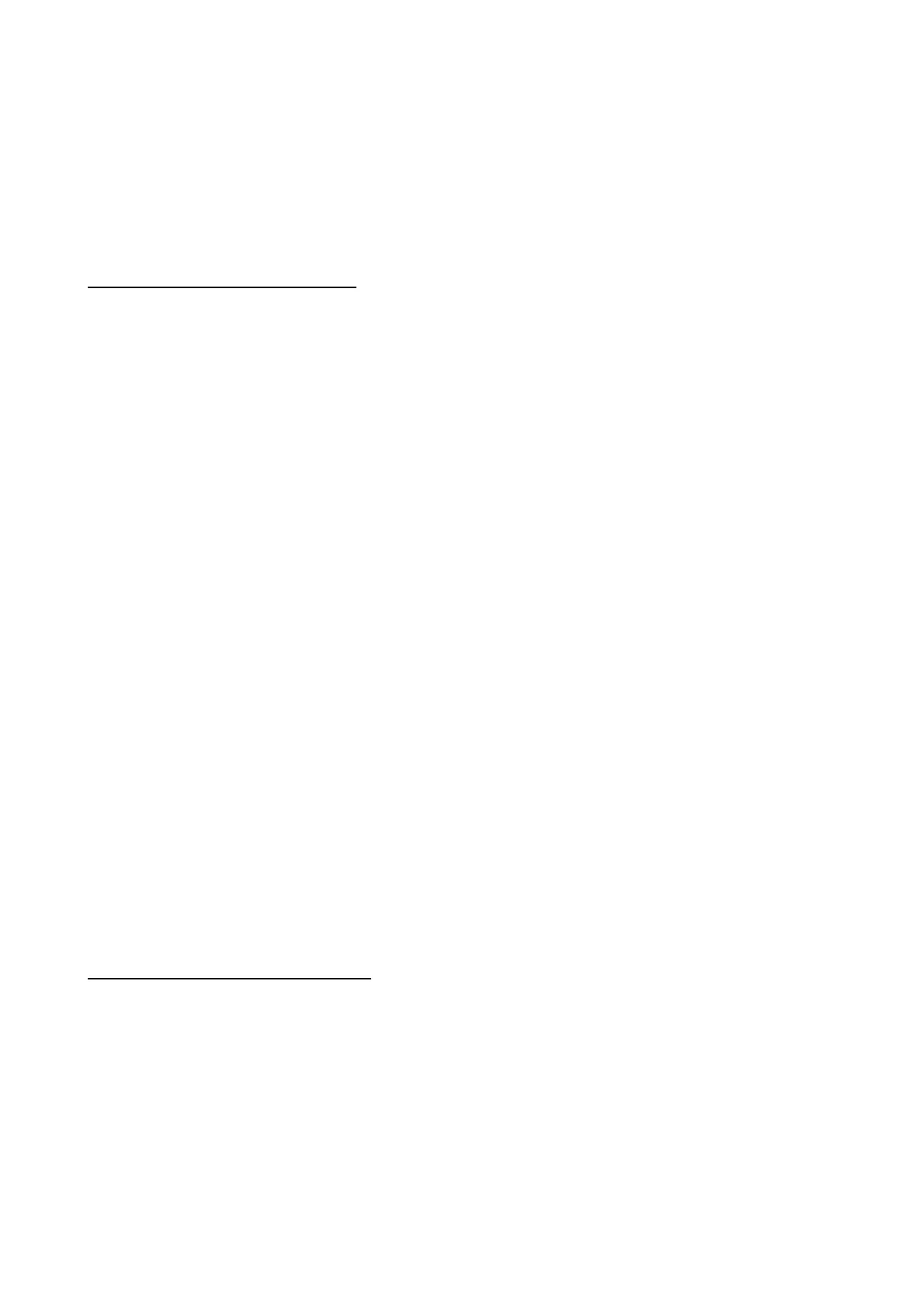
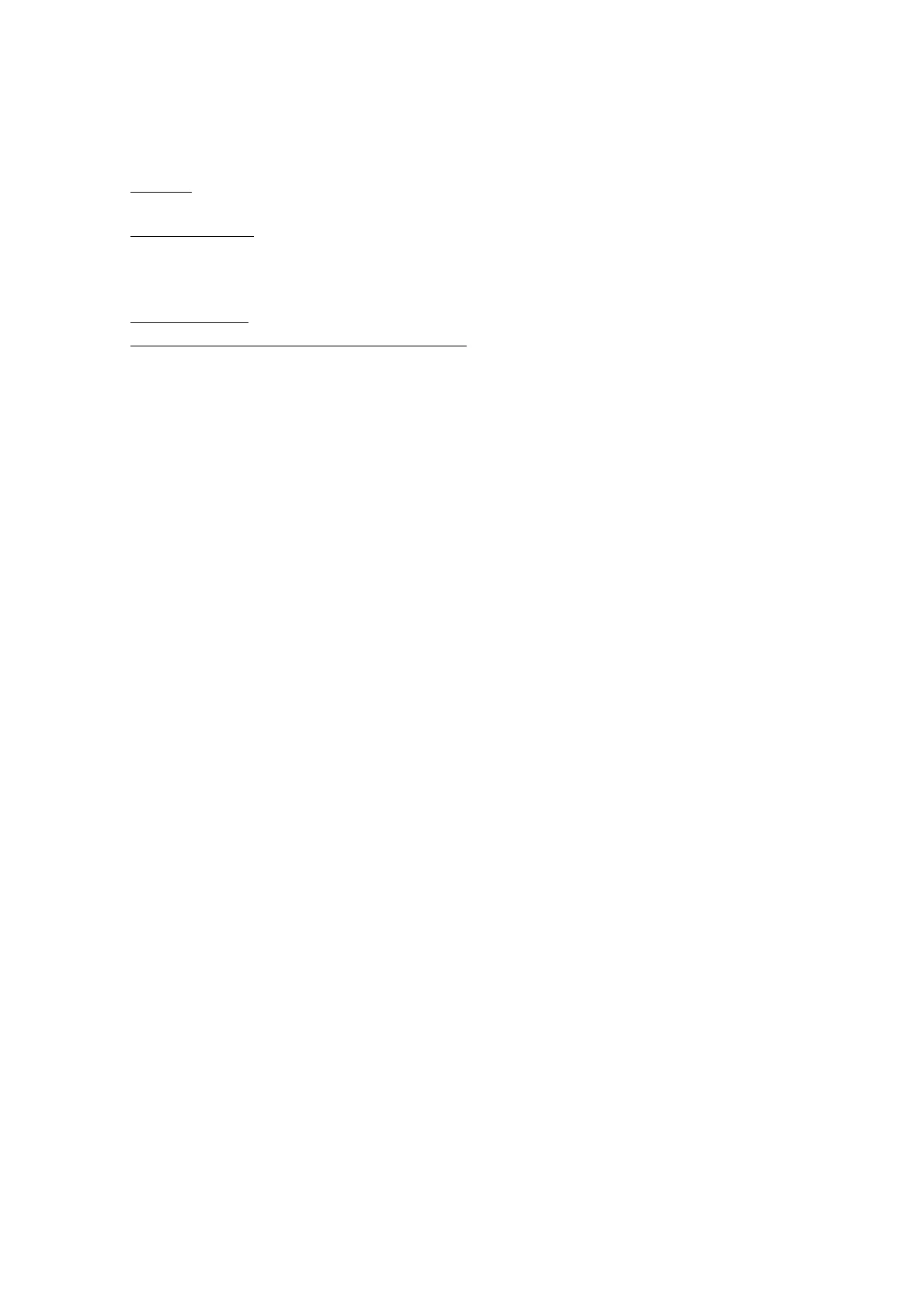
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione Applicata all'Esercizio Fisico
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE APPLICATA
ALL'ESERCIZIO FISICO
La Psicologia è la scienza che studia il comportamento, inteso non solo come stimolo-risposta ma in senso
più ampio perché riguarda tutti i cambiamenti che si manifestano lungo l'arco della vita (lifespan).
Psicologia dello Sviluppo
Cosa è la Psicologia dello Sviluppo? È una disciplina che studia l'evoluzione e lo sviluppo del
comportamento, i cambiamenti del comportamento (esterno ed interno) nel corso dello sviluppo
(psicologia dell'età evolutiva, psicologia del ciclo di vita).
Prima si parlava di psicologia dell'età evolutiva, studiava i cambiamenti dalla nascita fino al diciottesimo
anno di vita circa; oggi si parla di ciclo di vita e di sviluppo, si studiano i cambiamenti che caratterizzano
l'individuo dalla vita intrauterina fino alla senescenza e morte.
I cambiamenti che caratterizzano tutto l'arco di vita sono cambiamenti sia qualitativi sia quantitativi.
Un altro ambito di cui si occupa la psicologia dello sviluppo riguarda lo sviluppo atipico (la Disabilità).
I Compiti delle teorie dello sviluppo sono:
- descrivere i cambiamenti entro una o più aree del comportamento
- descrivere i cambiamenti nella relazione fra diverse aree del comportamento
- spiegare il corso dello sviluppo di cui si è fatta la descrizione
La psicologia dello sviluppo studia la complessità del comportamento, visto come risultato della co-
occorrenza (quindi di manifestazione contemporanea) di fattori collocati in diversi livelli del funzionamento
individuale e legati da relazioni di reciprocità con il contesto. Non studia la persona isolata ma il
funzionamento dell'individuo che è in relazione di reciprocità con il contesto (micro e macro contesto).
Corollario della rilevanza attribuita alla complessità dello sviluppo è l'esistenza delle differenze individuali,
a lungo trascurate dalla ricerca a causa di un eccessivo riduzionismo volto a privilegiare la norma evolutiva
(ci sono differenze tra le persone e spesso in passato sono state trascurate).
Stili Educativi
Gli Stili educativi sono:
- Stile autoritario > il bambino è tenuto a rispettare le rigide regole imposte dal genitore o da una qualsiasi
figura che svolge una funzione educativa, non riesce a spiegare le motivazioni per le quali il bambino
dovrebbe rispettare le regole (dice no e basta). - Stile permissivo > al bambino è permesso tutto.
- Stile autorevole > è una via di mezzo tra lo stile autoritario e il permissivo; anche se il genitore dice no,
questo è accompagnato dalla spiegazione. Richiama il bambino all'utilizzo del pensiero critico cioè capire
perché è no. Si può usare la metafora del bastone e della carota, perché il bastone rappresenta i no che si
danno, la carota rappresenta il rinforzo.
Psicologia dell'Educazione
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
Cosa è la Psicologia dell'educazione? In questo ambito è rilevante l'apprendimento (inteso non come
apprendimento scolastico).
Secondo Hilgard e Bower, l'apprendimento è qualsiasi modificazione relativamente stabile del
comportamento.
Quindi l'apprendimento è un processo trasversale, riguarda tutte le età e tutti i contesti di vita.
La Psicologia dell'Educazione riprende le dinamiche di APPRENDIMENTO - INSEGNAMENTO.
Nel 1964, Metelli Di Lallo definì la Ricerca psicoeducativa, intesa come la ricerca che si occupava delle
relazioni tra « ... i caratteri che la condotta presenta ad un certo momento dello sviluppo e quegli obiettivi
educativi e didattici cui la condotta dovrebbe risultare disponibile»; quindi fa riferimento all'insieme dei
processi che si sviluppano e che modificano il comportamento della persona in tutti i contesti educativi e
formati. Tuttavia oggi questa visione è superata ed è sbagliato il riduttivismo: bambino = scolaro.
1Il Contesto di analisi -> non è solo la scuola ma è un contesto più ampio: educativo e formativo.
Il contesto educativo è considerato qualsiasi contesto che promuove l'apprendimento e la crescita della
persona.
- Obiettivi: comprendere e supportare i processi di insegnamento e apprendimento nella loro
evoluzione e relazione tra studente/formando e insegnante/formatore/educatore. - Oggetto di studio: apprendimento inteso come «interiorizzazione», come conoscenze nuove, che
entra a far parte dell'individuo ancorandosi (anchoring ideas di Ausbel, 1968) alle conoscenze ed
esperienze pregresse e divenendo così significative nel processo di sviluppo, contribuisce alla crescita
della persona.
Lifelong learning: l'apprendimento si sviluppa lungo tutto l'arco di vita per la plasticità cerebrale.
La psicologia dell'educazione è interdisciplinare: è una «sperimentazione psicodidattica
sull'apprendimento e sui singoli contenuti di studio, relazione tra fasi dello sviluppo e metodi-
obiettivi educativi, processi motivazionali, strumenti di misura e valutazione» (Pontecorvo, 1999),
procede in modo metodico.
Ci sono diverse fasi di sviluppo, ogni stadio ha delle caratteristiche ben precise che non sono solo
caratteristiche dal punto di vista fisico (è normale che un bambino è fisicamente diverso e ha competenze
diverse rispetto ad un'adolescente o ad un anziano) ma sono caratteristiche che investono tutta la persona.
Bisogna conoscere i metodi e gli obiettivi educativi perché non si deve procedere in maniera casuale ma
con obiettivi e metodi specifici.
I processi motivazionali sono importanti per il bambino perché gli permettono di acquisire fiducia nelle sue
capacità.
Quando si propone una forma di intervento, un programma di lavoro, ciò che lo rende scientifico e
attendibile è la verifica; quest'ultima presuppone l'utilizzo di strumenti di misura e la valutazione.
Si deve misurare ciò che la persona era in grado di fare prima (valutazione iniziale: baseline) e ciò che è in
grado di fare dopo, valutando così il cambiamento e misurare l'efficacia del trattamento rispetto alla
crescita personale.
La valutazione è effettuata in due tempi: si valuta tra il Tempo 0 e il Tempo 1, che tipo di incremento si è
verificato.
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione Applicata all'Esercizio Fisico
COSA SIGNIFICA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE APPLICATA ALL'ESERCIZIO FISICO?
- QUALI SONO I CAMPI DI APPLICAZIONE?
- A CHI È RIVOLTA? È rivolta a tutti (bambini, adulti, anziani)
- IN QUALI FASI DEL CICLO DI VITA?
Conflitto Cognitivo e Conflitto Sociocognitivo
CONFLITTO COGNITIIVO E CONFLITTO SOCIOCOGNITIVO
Piaget nel suo ultimo lavoro "Il giudizio morale nel fanciullo" (1934) dimostra che la cooperazione favorisce
lo sviluppo morale del bambino. In quanto gli altri hanno un ruolo fondamentale nella presa di coscienza
delle regole morali. Il concetto di sviluppo morale è sovraordinato rispetto il concetto di sviluppo cognitivo;
quindi il conflitto sociocognitivo riguarda non solo lo sviluppo morale ma anche lo sviluppo cognitivo in
senso ampio.
Piaget parla di CONFLITTO COGNITIVO (intracognitivo)-> è il processo che si attiva quando non si possono
applicare gli schemi cognitivi già posseduti a dei contenuti nuovi e si origina un disequilibrio del sistema
cognitivo che sollecita una riorganizzazione degli schemi posseduti (questo è apprendimento).
Il termine conflitto per assonanza terminologica fa pensare a qualcosa di negativo, invece, in termini
psicologici, il conflitto, spesso, ha un'accezione positiva, nel senso che rappresenta il confronto tra due
punti di vista, tra due situazioni da cui si genera un processo di crescita; il conflitto viene inteso come il
venir meno di una situazione di equilibrio, che era stata raggiunta precedentemente, e porterà poi ad un
nuovo equilibrio e una nuova crescita nell'età successiva (ad esempio l'adolescenza è un'età di conflitto con
gli adulti, con altre fasce evolutive ma è una fase fisiologica, normale che porta ad uno sviluppo ulteriore).
Il gioco cooperativo viene affrontato dai neopiagetiani Doise e Mugny (1981) nel libro "La costruzione
sociale dell'intelligenza". L'interazione sociale che si sviluppa durante il gioco cooperativo è un luogo
2privilegiato di apprendimento e di crescita. Inoltre parlano di conflitto sociocognitivo, nel 1978 (il passaggio
da Piaget ai neopiagetiani sta nella dimensione sociale perché aggiungono la componente sociale).
Il CONFLITTO SOCIOCOGNITIVO -> è il disequilibrio cognitivo che si attiva all'interno di un gruppo di lavoro,
quando il soggetto affronta un compito con un altro soggetto di pari livello cognitivo e si confronta con un
punto di vista e un'interpretazione diversi. Si ha anche un disequilibrio sociale che deve essere superato
con un'efficace gestione dell'interazione con l'altro.
Impariamo quando si viene a creare di nuovo un equilibrio tra le diverse individualità, viene superato il
disequilibrio sociale perché c'è una gestione efficace dell'interazione con l'altro.
Le interazioni sociali con i pari avviano il progresso cognitivo attraverso il conflitto che viene risolto con
l'elaborazione di una soluzione nuova, originale, diversa da quella dei singoli che scaturisce
dall'integrazione dei punti di vista di tutti.
Il confronto con i pari favorisce il realizzarsi dei potenziali di sviluppo e di apprendimento.
Vjgotski affronta il potenziale di sviluppo o sviluppo potenziale; il potenziale è qualcosa che potrebbe
svilupparsi ma al momento non c'è quindi è frutto del contesto educativo, a sua volta il contesto educativo
deve lavorare per far si che qualsiasi potenziale di sviluppo si trasformi in competenza.
Il concetto conflitto sociocognitivo è alla base del lavoro di gruppo.
Nel gruppo di lavoro si mettono insieme le diverse parti, ogni componente dà il proprio contributo;
dal confronto del contributo dei diversi componenti del gruppo, si sviluppa un prodotto unico. Spesso si
dice che il gruppo di lavoro è più e meno della somma delle parti: si acquisisce perché ognuno dà un
contributo e meno perché si perde l'individualità, infatti il gruppo di lavoro funziona quando si crea il "noi"
(anche la squadra è un gruppo di lavoro, funziona quando c'è il noi e quando viene avviato un processo di
crescita perché si verifica il confronto tra i diversi punti di vista, tra le diverse modalità di risoluzione del
compito).
Apprendimento Collaborativo
L'APPRENDIMENTO COLLABORATIVO promuove:
- pensiero divergente: ci consente di arrivare attraverso molteplici vie ad una stessa soluzione;
- pensiero creativo
- un'elaborazione più profonda e sofisticata: perché deriva dal confronto con gli altri;
- maggiore autostima: valorizzo maggiormente la mia persona, ciò che sono in grado di fare;
- leadership: deve essere una leadership condivisa cioè gli altri attribuiscono e riconoscono il ruolo di leader
a una persona; - comunicazione: è fondamentale per confrontare i diversi punti di vista;
- decision making: quando ci sono diversi punti di vista, si deve prendere una decisione che deve
massimizzare il risultato, quindi si deve avviare un processo di scelta che ci porta ad una soluzione.
In questo modo, ognuno è responsabile del proprio e dell'altrui apprendimento, il gruppo
nell'apprendimento collaborativo funziona come gruppo di lavoro. Il contesto educativo deve far si che il
potenziale diventi competenza, capacità. - 3- 7 partecipanti
- A 7-8 anni il gruppo ha prestazioni migliori dei singoli. L'effetto interazione è minore sia a 5-6 anni
(il compito risulta troppo difficile) che a 9-10 (il compito risulta troppo facile).
I bambini, se troppo piccoli, non sono in grado di lavorare in gruppo perché il bambino è egocentrico,
non è in grado di decentrarsi e assumere il punto di vista dell'altro.
Tra i vari esperimenti di Piaget, è importante ricordare il compito delle tre montagne: c'è un plastico
con tre montagne, il bambino viene posto di fronte allo sperimentatore (quest'ultimo si trova dietro il
plastico), se al bambino viene chiesto cosa pensa che lo sperimentatore stia vedendo, lui risponde che
vede ciò che lui vede; questo perché il bambino non è capace di decentrarsi. - A 7-8 anni forniscono risultati migliori i gruppi spontanei (senza direzione dall'esterno
o senza direzione dall'interno quindi senza capo), a 9-10 i gruppi gerarchizzati in cui c'è un capo ma
devono essere sempre guidati da una figura educativa esterna. - A 7-8 anni il compito risulta più difficile se non si può comunicare verbalmente (Vianello).
3