Sistemi Socio-economici: Lavoro, Industrializzazione e Migrazioni
Documento dall'Università sui Sistemi Socio-economici, che esamina l'influenza dell'economia sulla società. Il Pdf analizza il lavoro, l'industrializzazione e le migrazioni, con riferimenti storici e sociologici, per studenti universitari di Economia.
Mostra di più64 pagine

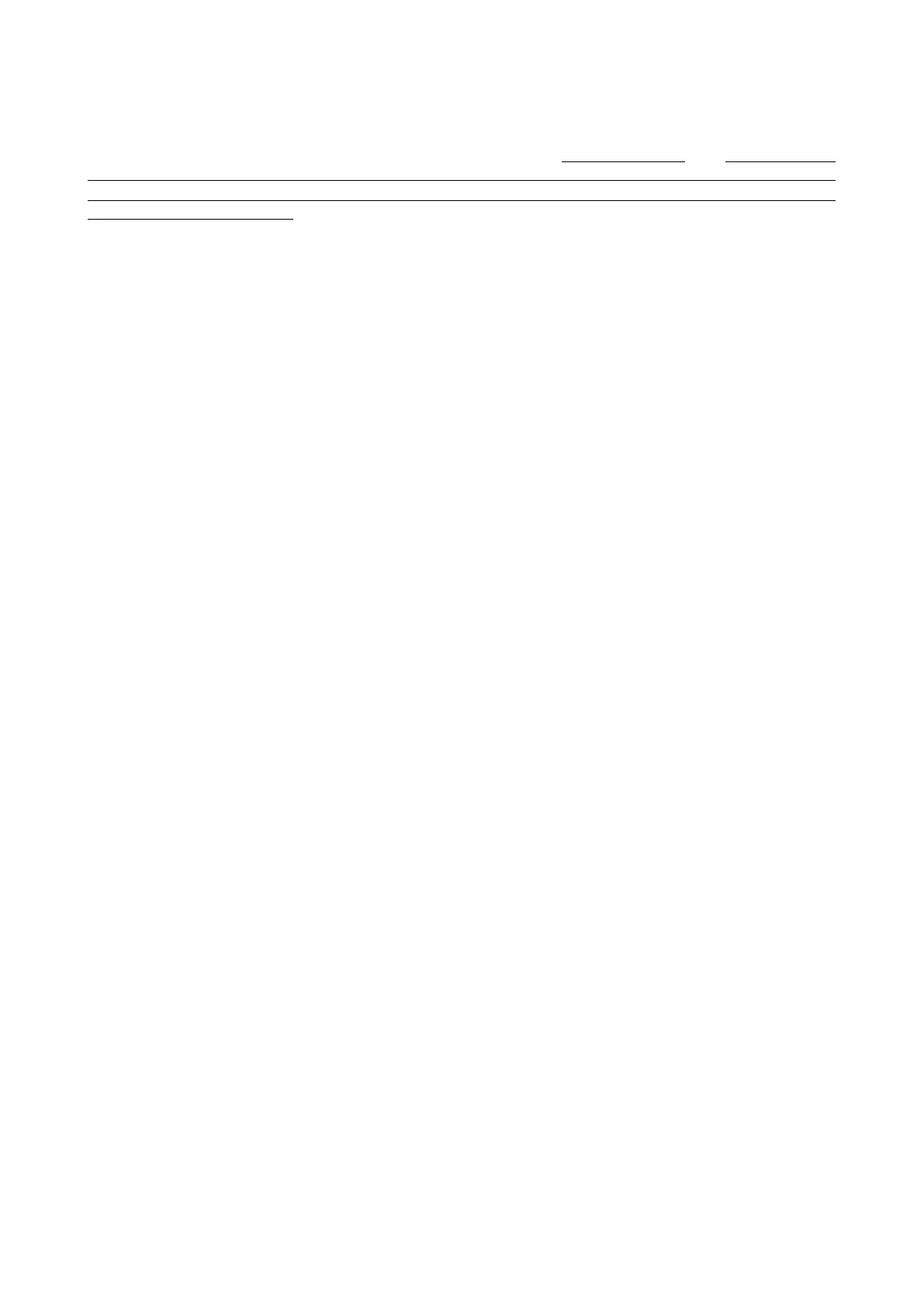
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
GIULIA SEPE
Sistemi Socio-Economici
La materia di sistemi socio-economici mira ad analizzare come l'economia influenza la società. La disponibilità economica incide sulla quotidianità delle persone e ciò accade sopratutto in una società caratterizzata da un capitalismo maturo. Analizzare le disponibilità economiche di un individuo o di una famiglia significa analizzare il lavoro e dunque il salario che ne deriva. Analizzeremo il lavoro e le sue dimensioni, in quanto rappresentata un valore altamente importante all'interno della nostra vita ed è il contesto sociale che ci esprime il fatto che il lavoro produca significati (pressione sociale che ad esempio fa sentire inadeguata una persona che ha perso il lavoro). Anche gli inoccupati (coloro che devono ancora esordire nel mondo del lavoro) sono determinati da una forte pressione sociale ed emotiva.
Il lavoro e le professioni influenzano anche il panorama urbano (negozi, botteghe artigianali) che caratterizza la città è tutto ciò che non è riconducibile ad una dimensione abitativa.
Il Lavoro e la Valenza Identitaria
Il lavoro come lavoro significante aveva anche una valenza identitaria: per intere generazioni il lavoro aveva un valore talmente espressivo da essere quasi significante ("dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei"). Nel passato la dimensione lavorativa era talmente solida che non solo si agganciava alle esistenze di tutti noi ma si agganciava anche alle strutture e agli edifici. Quando si conosceva una persona nuova e si dichiarava la professione o il lavoro spesso si collegava anche lo spazio e l'edificio fisico in cui l'individuo svolgeva la propria attività (operaio= fabbrica). Molti quartieri delle città nacquero proprio come quartieri abitativi di operai accanto alle fabbriche. Per l'industriale, infatti, era vantaggioso che l'operaio abitasse vicino alla fabbrica per permettere a quest'ultimo di ridurre al minimo gli spostamenti e di conseguenza di aumentare e di massimizzare le ore di lavoro e l'efficienza del lavoratore (meccanismo di "razionalizzazione" degli spazi dei quartieri operai).
Densità Lavorativa e Svantaggi per l'Industriale
La densità lavorativa della fabbrica e la grande massa degli operai poi si rifletteva nella grande densità di persone e di famiglie nel quartiere operaio. Tuttavia la densità fuori dalla fabbrica per l'industriale poteva avere degli aspetti svantaggiosi: si confrontano idee, ci si lamenta insieme, scopri di non essere l'unico in quella situazione. Tutto ciò potrebbe portare a far scattare rivoluzioni, manifestazioni, portando a fra si che nel corso del tempo il numero degli operai nelle fabbriche diventò sempre minore (dato anche dallo sviluppo tecnologico e dall'avvento delle macchine). Inoltre il taglio dei lavoratori portava anche ad un taglio di costi fissi anche se le macchine potrebbero rompersi e dare vita a costi per il pagamento dei tecnici. Dietro al progressivo snellimento della forza lavoro generalizzata (classe operaia) ci sono motivazioni non sempre economiche ma anche politiche (più stanno insieme più potrebbero confrontarsi e dare vita ad idee pericolose per gli industriali).
Innovazione e Vantaggio del Datore di Lavoro
I cambiamenti innovativi nel mondo del lavoro vanno sempre a vantaggio del datore del lavoro: logica conseguenza del fatto che l'innovazione non è neutra politicamente, l'innovazione va a vantaggio di chi la produce e di chi è in grado di gestirla ed è la classe dominante a farlo. Le innovazioni tecnologiche danno in un primo momento vantaggio all'azienda.
Etimologia del Lavoro e dell'Industria
Il termine lavoro è una parola prendente in tanti contesti, paesi e lingue, non ha una radice etimologica comune e in ogni lingua ha un termine diverso per determinare il lavoro. Il termine industria invece ha un'etimologia comune in molte lingue, poiché viene utilizzata, se pur con accentuazioni diverse, la stessa parola. Questo perché per molti secoli il lavoro si identificava con l'industria, partendo nel '700 con la rivoluzione industriale in Inghilterra. La rivoluzione industriale ha portato delle conseguenze importanti determinando il passaggio dalla produzione artigianale a quella in serie. Il termine industria è una parola che per tanto tempo hagoduto di un'ottima fama: è come se ogni società riconoscesse e apprezzasse l'importante di tale attività e di tale luogo fisico in quanto erogazione di servizi e di fatica. L'industria produce ricchezza e porta vantaggio non solo al "capitano di industria" ma all'intera società. L'autore scozzese, Carlyle, a meta dell'800 (1830) coniò il termine "industrialismo" per indicare come l'industria avesse acquisito una grande importanza nel vivere quotidiano, apportando una vera e propria critica al concetto stesso di industria e al concetto di produzione (impostare la produzione sull'industria). Già a quel tempo alcuni studiosi e intellettuali erano consapevoli del fatto che la produzione industriale modificava la natura umana, gli stili di vita e la mentalità. Da quel momento in poi inizio un vero e proprio filone di pensiero che criticava la società moderna industrializzata, che rimpiangeva la vecchia idea di un mondo più semplice, contadino e rurale (desiderio di città meno inquinate, lavoro meno coinvolto nella produzione). Già dall'800 si scontrano le due visioni sociali-politiche ed economiche: da un lato l'esaltazione del lavoro e della produzione industriale (corrente del futurismo = esaltazione di un mondo in cui le macchine iniziano ad avere un'importanza fondamentale, concetto di progresso) e la consapevolezza che non ci potesse essere sviluppo della civiltà senza un miglioramento dell'industria) e dall'altro un rimpianto ad un mondo più semplice, libero dalla produzione industriale stretta e più contadino, meno inquinante.
Illuminismo Francese e Sviluppo Industriale
Anche nell'Illuminismo francese si fa un continuo e un denso riferimento al concetto di produzione industriale, lo sviluppo delle macchine viene visto in maniera favorevole e rivoluzionaria dai grandi studiosi illuministi come ad esempio Diderot e d'Alembert, Condoret: gli illuministi nello sviluppo industriale vedono la razionalità, la ragione che vengono incarnati dalle stesse macchine.
Critica al Mondo Industriale e Rimpianto del Passato
Contemporaneamente pero nasce un movimento di chi rimpiange il vecchio mondo pre industriale, si rimpiange l'aspetto dell'inquinamento visivo dei paesaggi e delle città, le industrie deturpavano il paesaggio, le industrie sorgevano spesso in prossimità dei corsi d'acqua per procurarsi dell'energia. Il primo impatto visivo delle costruzioni industriali era pessimo a livello visivo. Vi era una precisa localizzazione del rimpianto della nuova realtà industriale ed era presente nel mondo agricolo: vi è la netta impressione che l'industria significhi il superamento della società agricola e delle relazioni presenti all'interno della stessa comunità. Ferdinand Tonnies , nella seconda metà dell'800 e inizio del 900, era un docente dell'Università di Kiel ed uno dei maggiori esponenti della scuola sociologica tedesca. Partendo da Tonnies si inizia a formare un gruppo di studiosi che si inizia ad assembleare e a riflettere insieme sui cambiamenti della nuova società industriale. Tonnies era uno dei studiosi che fece spesso riferimento al rimpianto del nuovo mondo, soprattutto in un'opera di nome "Comunità e Società" (gheimanshut): nell'opera viene definito il superamento del concetto di comunità in favore del concetto di società. Le due forme di organizzazioni si distinguono per essere due tipi diversi di organizzazione umana. La comunità si identifica con l'ambiente agricolo e pre industriale (si conoscono tutti, vi è più solidarietà, rapporti sinceri e genuini). La comunità viene piano piano sostituita dal mondo della società in cui i rapporti sono formalizzati dal lavoro, rapporti per cosi dire forzati, anafettivi). L'uomo societario sta insieme agli altri individui nella società (che possiamo localizzare nella grande città) perché glielo impone il lavoro. Diversamente dal contesto comunitario in cui vi era il piacere di stare insieme. La società impone una tipologia di uomo- donna ben diverso e che in relata non esiste, con rapporti formalizzati da contratti, vi sono dei doveri e delle norme da seguire quotidianamente. Tonnies proveniva da un realtà agricola e contadino e quindi rimpiange un mondo agricolo anche per la sua storia di vita e per la sua infanzia.
Artisti e Scrittori Critici dell'Industrializzazione
William Blake, artista inglese della meta del 800, che attaccava il paesaggio quotidiano rovinato dalle satanic mills = ciminiere che rovinavano ed inquinavo il paesaggio della campagna inglese. Anche l'autore Thomas Hardy, scrisse un romanzo a puntate negli anni '70 del '900 di nome "Via dalla pazza folla" e "Tess dei d'Ubervilles", i quali trattavano delle difficoltà incontrate nel trasferimento delle individui dalle campagne alle città. Le persone infatti desideravamo migrare in città per potere avere maggior possibilità di lavoro, Hardy dunque parla dello sradicamento delle persone proveniente dalla comunità agricole ed evidenziando la difficoltà e gli svantaggi di tale migrazione, invitando a non spostarsi nella città.Lawrence, rappresenta un altro autore inglese, il quale migrò in Italia meridionale in cerca di piccoli paesini, desiderando di ritornare quelle relazione e quella sincerità che credeva di aver perso per sempre.
Critica Economica all'Industria: Fisiocratici e Marx
Vi è anche una vera e propria critica economica all'industria mossa dai cosiddetti fisiocratici: gruppo di studiosi economisti francesi che nel '700 criticarono la nascente industria opponendosi all'idea che lo sviluppo economico e sociale della società si potesse effettuare solo con l'industria (contro L'industrialismo). Il futuro della società non è l'industria ma è ancora la produzione agricola, si crea in questi anni un vera e prosai contrapposizione tra industria e agricoltura a livello produttivo: tale distinzione però era futile e fittizia poiché industria significava e delle città e l'industria era dunque fondamentale che aumentasse poiché vi era il bisogno di più generi alimentari. La stessa produzione agricola aumento grazie alle le scoperte scientifiche industriali che elaborarono nuovi concimi che permisero di rendere più produttivi i campi e di aumentare l'agricoltura, dunque la contrapposizione non è reale e corretta poche I fisiocratici a tal proposito proponevano come riflessione l'aumento dell'agricoltura, l'agricoltura è ancora fondamentale (il pezzo di ferro dell'industria siderurgica non è altro che la materia prima lavorata dagli operai, tuttavia le voci di spesa della produzione del ferro è uguale alla cifra spesa per quel pezzo di ferro). La ricchezza si ritrova solo nell'agricoltura (quando produco la zucchina la posso vendere ad un prezzo superiore rispetto alla fatica e al costo del contadino che la produce, poiché li vi è l'intervento della natura che non viene pagato).
Fisiocratici e Tradizionalismo
Tutti questi economisti e pittori che elogiavano il mondo agricolo si identificavano all'interno di una posizione politica piuttosto conservatrice, nella loro rappresentazione e concezione l'agricoltura e la natura sono qualcosa di immutabile, esattamente l'opposto dell'industria che è trasformazione e cambiamento veloce, forse più veloce della capacità di ricezione del cambiamento da parte dell'individuo. Il sociologo tedesco Weber definirebbe tale convinzione il cosiddetto "eterno ieri" che fa riferimento al concetto di tradizionalismo e weber I definito a tale tipo di pensieri e di azioni non razionali ma anzi abitudinarie, consuetudinarie e tale società agricola incarnava questi senso di tradizionalismo e l'esempio di una società che non doveva cambiare, esempio di uno status quo che aveva paura del cambiamento (rappresentato dall'industria).
La Teoria del Plusvalore di Marx
Una critica ai fisiocratici viene proposta dalla teoria di Marx del plusvalore: nella sua teoria economica introduce il concetto di plusvalore il quale spiega poiché secondo Marx solo l'industria produca un guadagno economico e non con l'agricoltura, nell'agricoltura non vi sono i macchinari e il pezzo di ferro prodotto dall'industria, secondo marx, non è la somma del costo dell'operaio (salario moltiplicato per il numero di ore) e dal valore dell'energia per azionare il macchinario è come se nel pezzo di ferro fossero inglobate sia l'energia che il tempo e la fatica effettuata dall'operaio che, unite all'utilizzo del macchinario, producono un valore aggiuntivo. Dunque il plusvalore rappresenta il lavoro e la fatica in più svolto dall'operaio per produrre quel prodotto e che non viene pagato dal capitalista e che rappresenta salario per quest'ultimo. La combinazione tra prestazione umana dell'operaio e utilizzo del macchinario è maggiore di una produzione manifatturiera e artigianale ( l'artigiano non usa macchinari ma usa utensili che sono suoi e se dunque ci fosse un plusvalore sarebbe guadagnato dall'artigiano ma nell'industria tale plus valore dell'utilizzo dei macchinari non se lo guadagna l'operaio ma l'imprenditore poiché sono i suoi i mezzi di produzione). Secondo marx le enclosures sono state fondamentali per determinare l'industrializzazione.
Dibattito Fisiocratici e Marx: Condizioni Materiali
Il dibattito tra fisiocratici e Marx è un dibattito puramente teorico ma vi sono delle condizioni materiali che hanno fatto si che ad un certo punto si sviluppasse l'industria: i fisiocratici avrebbero comunque avuto torto nel considerare solamente l'agricoltura poiché le condizioni strutturali e materiali si sarebbero comunque indirizzate verso l'industria. Le condizioni strutturali sono diverse ma una delle più importanti è l'inurbamento ovvero lo spostamento di massa dalle campagne alle città, il quale apportò e favorì l'offerta di lavoro, gli individui erano in cerca di occupazione ed trasferendosi in città avrebbero potuto avere tale opportunità nelle industrie. L'imprenditore di fatto, aumentando le persone in città in cerca di lavoro, aveva facilita a pagarle poco e di conseguenza il costo di lavoro in città.