Capitolo 1: Introduzione alla difesa integrata in agricoltura
Documento universitario sulla difesa integrata in agricoltura, principi e tecniche di controllo dei parassiti. Il Pdf esplora l'evoluzione delle tecniche di difesa, dalla lotta chimica cieca a quella integrata, con un focus sugli acari fitofagi come Tetranychus urticae e Panonychus ulmi, utile per Scienze.
Mostra di più67 pagine
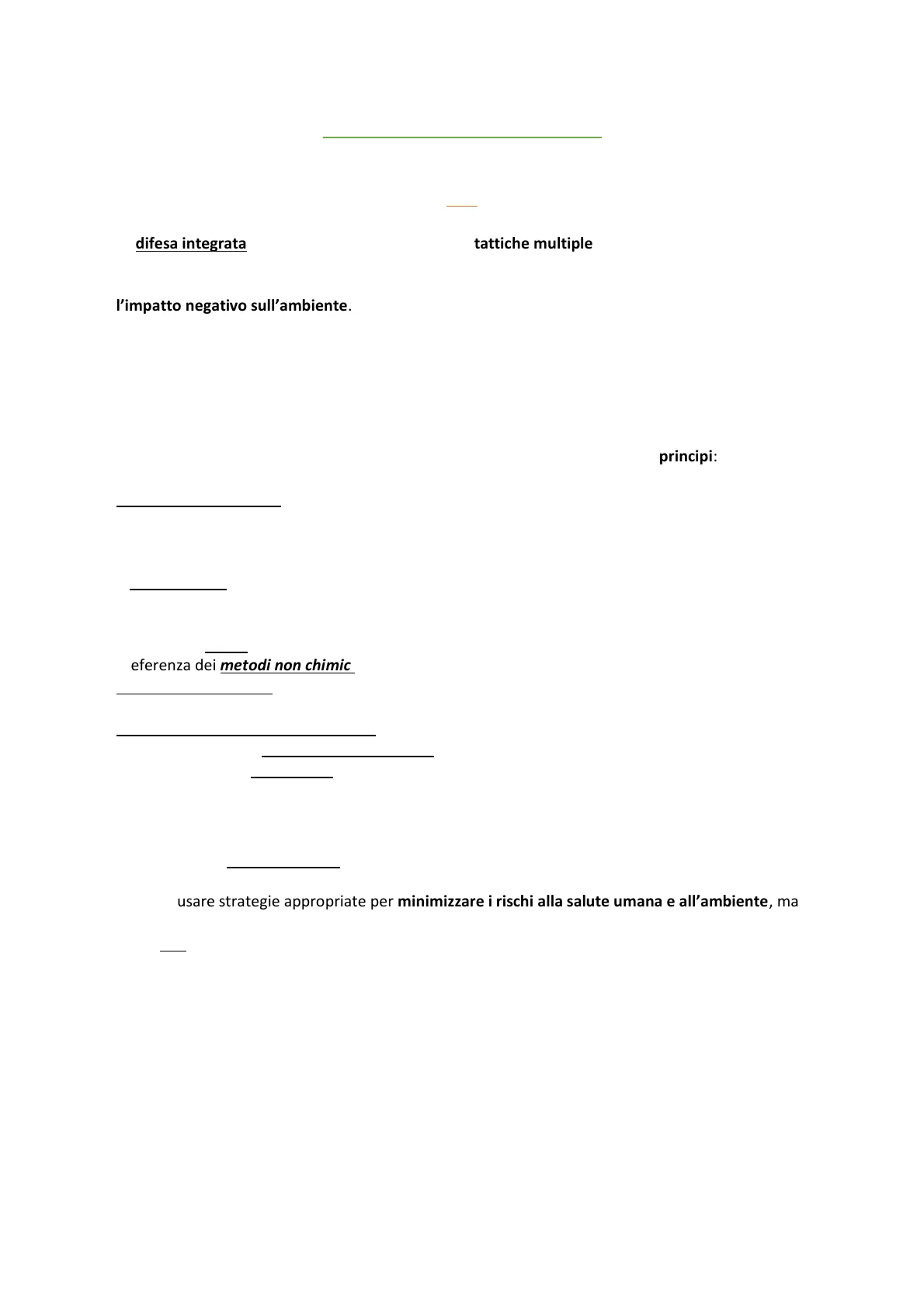
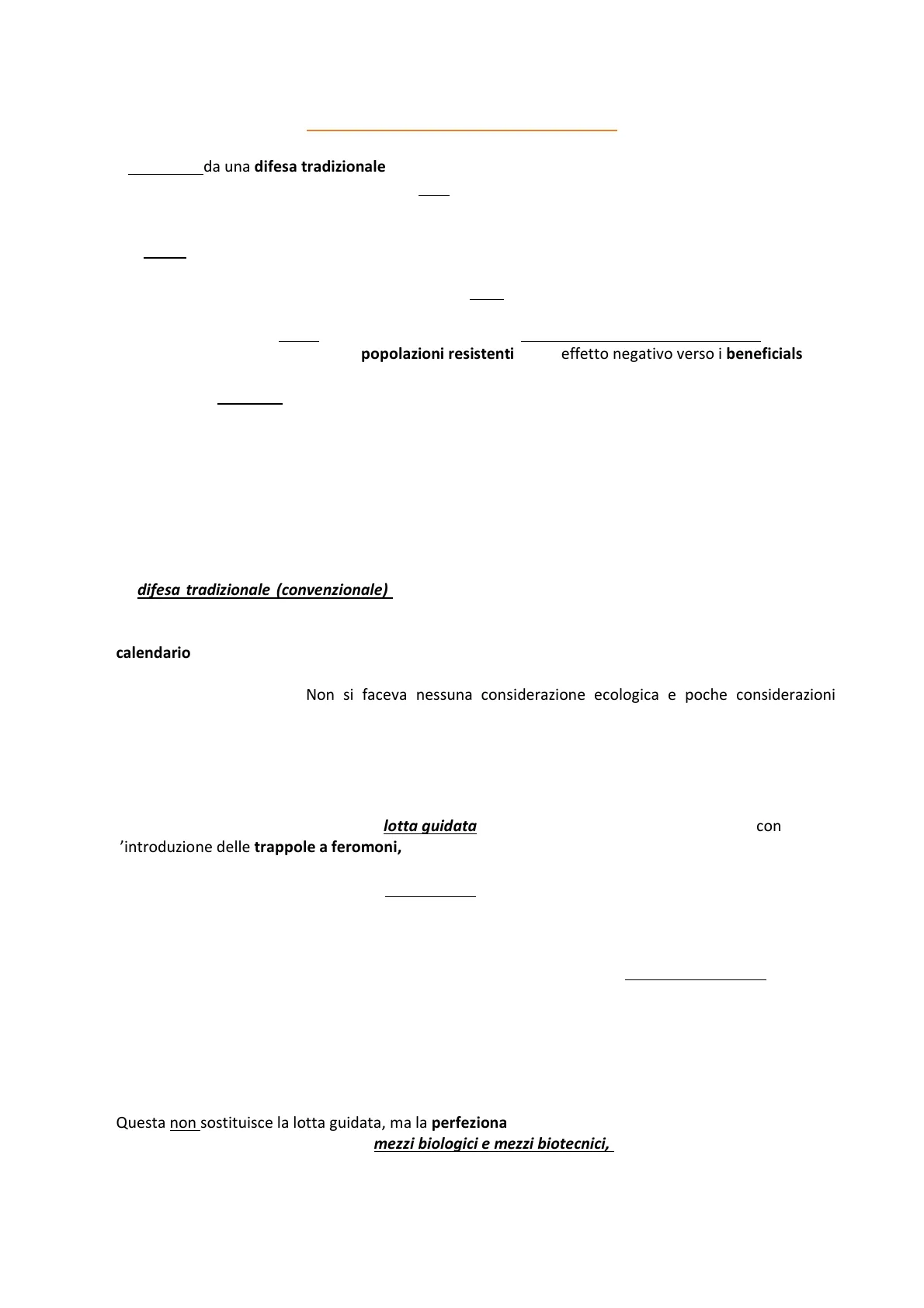
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Introduzione alla Difesa Integrata (IPM)
Capitolo 1: INTRODUZIONE IPM DIFESA INTEGRATA
- La difesa integrata è un processo basato sull'uso di tattiche multiple, finalizzate a migliorare il controllo di tutti i pests, in modo economico ed ecologico. Questa, infatti, deve: garantire la produzione, massimizzare il profitto della coltura e minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente.
Cosa fondamentale è il monitoraggio, ovvero, il controllo di tutti i parametri. Questo è utile per avere informazioni, in base alle quali, si fanno scelte accurate, dal punto di vista produttivo e di protezione della coltura.
Principi della Difesa Integrata
PRINCIPI IPM
- La difesa integrata è qualcosa di totalmente dinamico e si basa su una serie di principi:
- Prevenire e sopprimere l'azione degli organismi antagonisti e degli organismi nocivi. Questo, per esempio, tramite: l'adozione di particolari tecniche di coltivazione, sistemi di lotta agronomica (concimazioni e le irrigazioni), utilizzo di cultivar resistenti, materiale certificato, nutrizione bilanciata, pulizia delle macchine.
- Il monitoraggio ha segnato il passaggio da una agricoltura convenzionale (arcaica) ad una agricoltura moderna. Gli organismi nocivi è necessario che siano controllati devono essere poi sviluppati dei piani di monitoraggio che siano in grado di fornire delle informazioni al fine di prendere delle decisioni.
- Definire una soglia
- Preferenza dei metodi non chimici: approcci di tipo biologico, culturale e fisico,
- Selezione dei pesticidi: minimi effetti secondari, minor impatto tossicologico sia verso chi li usa e chi li consuma.
- Ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari al minimo necessario;
- Sviluppare e inserire strategie anti-resistenza.
- L'ultimo punto è la valutazione.
Definizione Europea di IPM
DEFINIZIONE EUROPEA DI IPM
- Secondo l'UE la difesa integrata è la considerazione attenta di tutti i mezzi di protezione delle piante e la conseguente loro integrazione. Significa usare strategie appropriate per minimizzare i rischi alla salute umana e all'ambiente, ma anche finalizzate a massimizzare le produzioni. L'IPM non cancella l'uso dei prodotti chimici ma lo riduce al minimo indispensabile.
Evoluzione delle Tecniche di Difesa Fitosanitaria
1EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI DIFESA
- Il passaggio da una difesa tradizionale (poco ragionata), basata su una applicazione a calendario di prodotti fitosanitari, ad una lotta integrata, non è qualcosa di netto, ma è un passaggio graduale. Infatti, il minor apporto chimico, come anche la maggiore sicurezza per gli operatori, non è un qualcosa che funziona a compartimenti stagni Nel 1944, l'industria chimica inizia la produzione di insetticidi di sintesi dotati di straordinaria efficacia, inizia così un periodo di completa fiducia nella lotta chimica. La svolta è stata sancita dalla scoperta del DDT nel 1939. Si trattava di un prodotto ad uso bellico mancato, data la sua elevata tossicità. Col passare del tempo (1950), iniziarono a manifestarsi gli effetti negativi della lotta chimica. Parliamo, infatti, della comparsa di popolazioni resistenti, di un effetto negativo verso i beneficials (primi insetticidi troppo efficaci e non selettivi), tossicità ambientale. A partire dagli anni '60, inizia ad esserci una presa di coscienza. Rachel Carson, biologa marina, inizia a studiare gli effetti del DDT sulle reti trofiche e pubblica un libro "Primavera silenziosa". Così l'opinione pubblica diventa consapevole dei rischi derivanti dagli antiparassitari. In particolare, si scopre che il DDT è scarsamente solubile in acqua, è una sostanza estremamente lipofila che tende ad accumularsi causando così grossi problemi eco-tossicologici.
Lotta Chimica Cieca
LOTTA CHIMICA CIECA
- La difesa tradizionale (convenzionale), anche definita "lotta chimica cieca", si basa sul fatto che una coltura può essere suscettibile all'attacco di un certo antagonista in un determinato periodo, periodo durante in quale noi effettueremo il trattamento. Proprio per questo motivo veniva definita "a calendario". Chiaramente, con questo criterio di difesa, non ci si preoccupava di capire l'entità della presenza del fitofago. Non esisteva nessuna forma di assistenza tecnica, pubblica o privata, per cui i costi non erano tanto elevati. Non si faceva nessuna considerazione ecologica e poche considerazioni tossicologiche.
Lotta Guidata
LOTTA GUIDATA
- Il passo successivo è stato quello della lotta guidata, la quale ha avuto il suo grosso impulso con l'introduzione delle trappole a feromoni, che diventano uno strumento di monitoraggio semplice, relativamente economico e piuttosto efficacie. Ovviamente, bisogna conoscere la biologia della specie e sapere quanto può essere il livello di proterandria, fenomeno che si basa sul fatto che i maschi compaiono prima delle femmine. Questa caratteristica dipende dalla specie e dalle condizioni ambientali, le quali possono ritardare o accelerare il sviluppo di questo processo. Quindi, è necessario aver un'idea del livello di proterandrie al fine di definire correttamente i trattamenti insetticidi e comprendere le curve di sfarfallamento, con le quali nasce il concetto di soglia di intervento. Parallelamente, vi è maggiore tutela nei confronti degli antagonisti naturali, aumenta il livello di assistenza tecnica, come anche si ha una maggiore attenzione economica, ecologica e tossicologica.
Lotta Integrata
LOTTA INTEGRATA
- Questa non sostituisce la lotta guidata, ma la perfeziona. Nella lotta integrata prendono piede mezzi biologici e mezzi biotecnici, cambiano le strategie colturali, c'è una maggiore attenzione nel non accentuare i problemi fitosanitari, nel limitare le concimazioni in certi momenti e in determinate fasi vegetative della pianta. Dunque, gli obiettivo dell'agricoltura moderna non è solo l'efficacia, ma anche la sicurezza dell'operatore, del consumatore e dell'ambiente.
Difesa Fitosanitaria e Cambiamenti Climatici
2DIFESA FITOSANITARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
- I Cambiamenti Climatici hanno avuto un impatto complesso sulla difesa, sul comportamento della pianta, sui fitofagi e, in generale, sull'intero ecosistema. In generale, vi è: un incremento della temperatura; un incremento dei gas serra legato al consumo di combustibili fossili; una forte aleatorietà nelle precipitazioni. Inoltre, cambia il rapporto C/N, questo spesso vuol dire che la pianta sembra più produttiva ma è da un punto di vista nutrizionale, meno efficiente per il fitofago. Cambiano anche le sostanze volatili che possono allontanare o richiamare i fitofagi e i loro antagonisti. Una maggiore concentrazione di CO2 aumenta la sintesi dell'acido jasmonico, il quale è coinvolto nei percorsi metabolici di difesa contro i fitofagi. L'acido salicilico, invece, è coinvolto nei percorsi metabolici contro i batteri. Il risultato è che si hanno piante meglio difese contro i patogeni e meno difesa contro i fitofagi. Ci sono poi effetti sulla morfologia della pianta: aumenta la superficie fogliare, cambia la quantità di tessuti suscettibili, cambia il microclima della pianta. Gli insetti sono animali a "sangue freddo", dunque, il loro metabolismo e la loro attività dipende strettamente dalla temperatura a cui si trovano. In generale, t più alte comportano una maggiore velocità di sviluppo, cicli più rapidi, aumento del voltinismo (ovvero un incremento del numero di generazioni).
Requisiti per i Prodotti Fitosanitari
REQUISITI PER I PRODOTTI FITOSANITARI
- La difesa integrata riduce l'uso dei prodotti fitosanitari, ma comunque lo comporta. La conoscenza dei prodotti fitosanitari è quindi necessaria per ottimizzare le nostre strategie di difesa. Un prodotto fitosanitario ideale dovrebbe essere caratterizzato da:
- Ottima efficacia: ampio spettro, efficacia duratura, nuova modalità di azione.
- Sicurezza per l'utilizzatore: bassa tossicità, basse dosi di impiego, utilizzo facile e sicuro.
- Buona compatibilità ambientale: sicuro peer gli insetti utili e per gli organismi non target; rapida degradazione.
- Proprietà agronomiche eccellenti: ampia applicabilità, soluzioni innovative, buon rapporto qualità- prezzo.
Un'alternativa ai prodotti fitosanitari sono i botanicals, ovvero prodotti di origine naturale, oli essenziali o altre molecole. Spesso hanno dei meccanismi di azione multipli, quindi, il loro sviluppo di resistenza è meno probabile o comunque ritardato.
- Un aspetto importante è quello di selettività ovvero la capacità di un pesticida, di un trattamento, di eliminare la specie dannosa, rispettando quelli che sono i non target. Possiamo distinguere tra:
- Selettività fisiologica: dipende dalla sensibilità del fitofago e dell'antagonista naturale, ovvero dall'organismo.
- Selettività ecologica: dipende dal tipo di esposizione che il prodotto può dare al fitofago o all'antagonista. Questa, dunque, dipende dal momento di applicazione.
- Poi abbiamo la specificità ovvero la capacità di un prodotto di causare una morte elevata in una certa specie.
Nematodi: Caratteristiche e Morfologia
3Capitolo 2: NEMATODI
- I nematodi sono un phylum, un gruppo zoologico abbastanza numeroso.
- Sono molto diffusi in natura, fortemente adattabili a diversi habitat e caratterizzati da comportamenti alimentari diversi.
- Alcuni di questi si comportano da parassiti, anche nei confronti degli animali, con conseguenze sanitarie abbastanza pesanti.
- Tutti necessitano di vivere in un ambiente ricco di acqua, infatti, anche quelli che vivono nel terreno, necessitano di un velo di acqua per muoversi e per sopravvivere.
- Il termine che viene usato per indicarli è "anguillule", in quanto la maggior parte dei nematodi ha un aspetto vermiforme.
Caratteristiche Generali dei Nematodi
CARATTERISTICHE GENERALI
- La variabilità morfologica, nei nematodi fitoparassiti, è abbastanza ampia.
- Le dimensioni variano in lunghezza da 200um a vari mm e in larghezza da 50 a 100um.
- La forma generale è allungata. I maschi generalmente mantengono questa struttura filiforme, mentre, le femmine possono assumere una struttura a ciste, a pallina.
- Non c'è segmentazione metamerica: la sezione trasversale è di solito circolare e la simmetria è bilaterale.
- Non ci son appendici esterne.
Morfologia Esterna dei Nematodi
MORFOLOGIA ESTERNA
- Mancando la suddivisione metamerica, il corpo del nematode è un qualcosa di convenzionale, ovvero, a partire dall'estremità anteriore abbiamo:
- Il capo: zona dove si trova l'apertura boccale;
- Il collo: zona che va dal capo alla base dell'esofago;
- Il tronco
- La coda: che va dall'apertura anale fino alla parte più distale del corpo del nematode.
- Nelle femmine, l'apertura vulvare è più o meno centrale.
- Viene considerata regione ventrale quella in cui sono ubicate: l'apertura anale; la vulva e il foro escretore: (struttura localizzata nella parte prossimale del corpo).
Regione Caudale dei Nematodi
REGIONE CAUDALE
- Nei maschi, l'apertura anale coincide con lo sbocco degli organi genitali.
- Ci sono tre diverse forme di coda, la quale è un carattere tassonomico.
- Nella zona caudale troviamo i fasmidi, strutture sensoriali e forse anche secernenti, anche queste usate a scopo tassonomico. 4