Didattica della musica: sviluppo delle abilità musicali nell'infanzia
Documento dall'Università Cattolica del Sacro Cuore su Riassunto, Elementi di didattica della musica. Il Pdf esplora il ruolo formativo della musica e il suo impatto sullo sviluppo cognitivo ed emotivo, analizzando la percezione sonora, del ritmo e la produzione musicale nell'infanzia e preadolescenza, con la Music Learning Theory di Gordon.
Mostra di più11 pagine
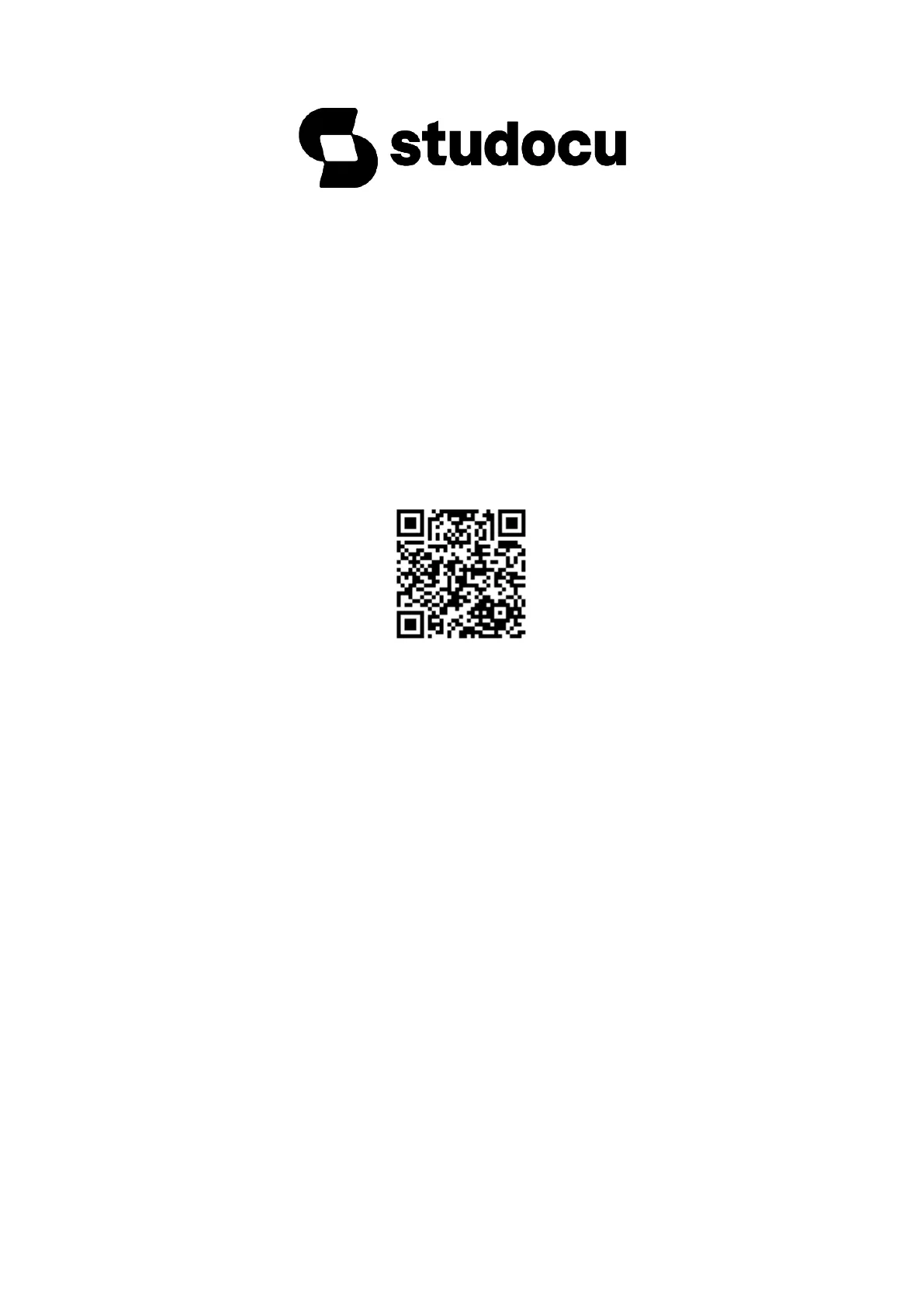

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Riassunto, Elementi di didattica della musica
Storia Della Musica (Università Cattolica del Sacro Cuore) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Alessandra Anticoli (alessandra.anticoli@gmail.com)ELEMENTI DI DIDATTICA DELLA MUSICA MICHELE BIASUTTI
Musica come materia formativa
La musica ha diverse potenzialità educative evidenziate sin dalle origini della storia, quando ci si era resi conto degli effetti a livello emotivo, cognitivo e psicofisiologico. Si è dovuto aspettare però diversi secoli perché si studiassero scientificamente e si comprendesse come i programmi educativi musicali influissero sulle abilità scolastiche quali la lettura, la scrittura, la matematica. Le attività musicali stimolano anche capacità di base quali l'ascolto, la concentrazione, l'autodisciplina e la cooperazione tra studenti. Hallam ad esempio, ritiene chele attività musicali siano funzionali allo sviluppo dell'intelligenza dei bambini, accrescendo il pensiero divergente e favorendo l'apprendimento di altre materie. Le attività musicali attivano inoltre dei meccanismi, detti "transfert degli apprendimenti", ossia dei meccanismi attraverso i quali le competenze acquisite in un determinato contesto influiscono sulle abilità cognitive in altri ambiti. Si tratta di un processo centrale nelle ricerche che studiano come le persone sviluppino le competenze ed è considerato un effetto da promuovere e un indice di qualità dei programmi didattici; esso dipende inoltre dalla nature delle attività e da alcuni aspetti motivazionali. Rispetto alla promozione del transfert gli stessi insegnanti possono creare delle condizioni favorevoli che consentano il suo realizzarsi come: indurre delle aspettative sull'utilità degli apprendimenti precedenti, definire i collegamenti tra apprendimenti precedenti e situazioni nuovi, supportare gli studenti sull'utilizzo della loro conoscenza, promuovere la responsabilità critica, cognitiva e di azione degli studenti e proporre delle attività di problem solving. Si può parlare inoltre di transfert positivo o negativo nel caso in cui rispettivamente si forniscano proposte che rendano o meno possibile lo svolgimento di altre attività, oppure di attività di transfert vicine o lontane a seconda della presenza o assenza di aree di conoscenza che permettano l'attivazione di questi meccanismi. In ambito musicale il transfert degli apprendimenti avviene quando si trasferisce la lettura della musica con la voce a quella con uno strumento musicale, che comporta la lettura delle note. Diverse ricerche inoltre hanno evidenziato l'influenza che la musica ha rispetto a determinati ambiti:
- musica e sviluppo personale e intelligenza emotiva;
- musica e abilità sociali;
- musica e abilità motorie;
- musica e intelligenza;
- musica e linguaggio;
- musica e abilità di lettura;
- musica e abilità logico-matematiche;
- musica e abilità spazio-temporali.
Musica, sviluppo personale e intelligenza emotiva
La partecipazione ad attività musicali può favorire lo sviluppo personale incrementare la fiducia in sé. Suonare uno strumento può generare un senso di realizzazione, di efficacia, di fiducia verso le proprie capacità, riuscendo a superare le frustrazioni. La pratica musicale può influenzare positivamente anche le emozioni, l'impegno, le relazioni interpersonali. Tutto questo genera dunque un incremento dell'intelligenza emotiva, intesa come la capacità di comprendere le emozioni proprie e altrui. Stimolare i bambini a riconoscere le emozioni all'ascolto della musica, può aumentare la capacità di saper cogliere le emozioni in generale. Attività didattiche quali l'associazione della musica al movimento, il canto e la libera espressione possono attivare cariche interiori positive, ridurre lo stress psicofisico, sviluppando il benessere in generale, come si è potuto rilevare anche attraverso la pratica della musicoterapia. Anche il 1 This document is available on studocu Scaricato da Alessandra Anticoli (alessandra.anticoli@gmail.com)genere di musica ascoltato ha una sua incidenza poiché sviluppa l'identità, definendo un gusto personale, attivando così processi informali che hanno una valenza formativa.
Musica e abilità sociali
I rapporti tra le attività musicali e lo sviluppo sociale, evidenziano che la partecipazione a proposte musicali accresce le abilità sociali. I bambini di 6 mesi esposti ad un programma di coinvolgimento attivo nella musica, dimostravano un miglioramento della abilità interpersonali, rispetto a bambini esposti passivamente alla musica. La partecipazione a esercizi di gruppo, oltre a garantire la coesione della classe, sviluppa la condivisione, la capacità di interagire con gli altri, di fare nuove amicizie e di sincronizzazione soprattutto.
Musica e abilità motorie
Le attività musicali inducono diversi effetti positivi sullo sviluppo motorio: suonare uno strumento e rispondere alla musica con il movimento potenziano le abilità motorie, come l capacità di coordinamento oculo manuale e la destrezza muscolare. Alcuni studi hanno rilevato che i musicisti, rispetto ai non musicisti, svolgono meglio i compiti motori e l'esperienza musicale può facilitare l'apprendimento di nuove abilità motorie; le conseguenze sono ovviamente più evidenti dopo diversi anni di apprendimento musicale. Anche il funzionamento del sistema immunitario e respiratorio, è stato rilevato, può essere influenzato e trarre beneficio dalle attività musicali.
Musica e intelligenza
Diverse ricerche hanno studiato i rapporti tra educazione e sviluppo delle capacità intellettive, utilizzando strumenti standardizzati per la misurazione del quoziente intellettivo. Considerando delle attività svolte per trenta settimane con bambini di 4-6 anni, si è rilevato che questi fanciulli hanno riportato punteggi più alti nel test musicale e nel sub test della memoria. Altri studi hanno evidenziato invece come i ragazzi, soggetti a pratica musicale, presentano idee più creative e complesse e un livello di astrazione più alto. Nonostante questo non è chiaro se l'aumento del quoziente intellettivo sia riconducibile all'aumento dell'intelligenza in generale o al miglioramento di singole abilità quali l'intelligenza visto-spaziale e quella linguistica.
Musica e linguaggio
Musica e linguaggio sono considerati simili in quanto entrambi utilizzano il sistema uditivo per raccogliere informazioni, presentano aspetti comuni poiché sia nella comunicazione verbale che in quella musicale vengono adottati dei medesimi parametri come l'intonazione, il ritmo e l'estensione del tempo. Inoltre, sia per quanto riguarda il linguaggio, sia la musica coinvolgono le capacità di saper cogliere, rispettivamente, il contorno sonoro e il contorno melodico. È stata inoltre verificata l'efficacia di training musicale per lo sviluppo della consapevolezza fonetica in bambini in età prescolare, rilevando una maggiore scioltezza fonetica nel gruppo che svolgeva attività musicali. L'ipotesi è infatti che l'apprendimento musicale attivo e l'associazione di suoni a simboli, possano incentivare processi analoghi a quelli utilizzati per la segmentazione delle parole in fonemi nella lingua parlata. Si è inoltre constatato come i musicisti fossero in grado di cogliere meglio le variazioni dell'altezza del suono della lingua poiché esperienze di ascolto e training anche brevi migliorano non solo le abilità uditive ma sviluppano anche la codifica corticale dei suoni linguistici. Imparando a studiare uno strumento sin genera un'espansione delle regioni temporali del cervello, stimolando una maggiore capacità di ricordare le parole.
Musica e abilità di lettura
Le analogie tra lettura musicale e lettura di testo coinvolgono ad esempio processi come la traduzione di un testo scritto in suono con uno strumento o con la voce. L'abilità di lettura richiede la capacità di distinguere le unità fonologiche, così come le abilità musicali richiedono una sensibilità nel distinguere le note. Alcune ricerche hanno considerato l'influenza di singole abilità musicali, come le capacità di anticipazione. Si tratta di strategie che consentono di avanzare previsioni su ciò che si sta leggendo in base alle caratteristiche del testo letto sino a quel momento. Attraverso ulteriori studi si è giunti poi alla considerazione che esistano cinque abilità sottostanti 2 Scaricato da Alessandra Anticoli (alessandra.anticoli@gmail.com)l'acquisizione della lettura, quali la consapevolezza fonologica, la percezione del linguaggio con rumore, la percezione del ritmo, la memoria di lavoro uditivo e la capacità di imparare schemi sonori, e che vengano sviluppate dall'esperienza musicale, postulando che condividano una dipendenza a livello neuronale. Tra gli aspetti salienti, il ritmo particolarmente significativa, ma anche il timbro potrebbe facilitare l'acquisizione della dizione e il controllo della voce durante la lettura, favorendo la riflessione sull'intonazione e sulla cedenza.
Musica e abilità logico-matematiche
L'apprendimento della musica e della matematica si ritiene siano collegati e che l'attitudine alla musica sia sinonimo di inclinazione per la matematica. Oltre alla frequenza dei suoni, anche il ritmo musicale si presta a interpretazioni matematiche, poiché si fonda su relazioni matematiche. Nonostante questo l'associazione tra musica e matematica potrebbe non essere diretta, ma mediata da fattori come l'autostima e l'attenzione indotte da esperienze musicali quali ascoltare la musica preferita e cantare con uno dei genitori.
Musica e abilità spazio-temporali
L'abilità di ragionamento spazio- temporale è definita come la capacità di elaborare immagini mentali senza un modello fisico. I processi spazio-temporali sono utilizzati in compiti che richiedono di combinare diversi aspetti di uno stesso oggetto in un'unica totalità, collocandoli in uno specifico ordine spaziale. Per fare ciò si richiede sia la capacità di ordinare temporalmente gli oggetti, sia rappresentare mentalmente lo spazio. L'abilità di ragionamento spaziale è rilevante per la presa di decisioni, per il ragionamento scientifico e il pensiero artistico. Le ricerche sulle abilità spazio- temporali si dividono in quelle sull'ascolto, relative all'effetto Mozart, e quelle sulle attività musicali.
Effetto Mozart
Parlando d effetto Mozart : i intende una ricerca svolta dalla Rauscher, pubblicata sulle riviste "Nature", che evidenziava gli effetti positivi derivanti dall'ascolto della musica di Mozart. Si riteneva che questa musica facilitasse vari compiti cognitivi, facendo registrare punteggi di circa otto volte punti più alti rispetto alle altre condizioni; tale effetto aveva però una durata limitata a una quindicina di minuti dopo l'ascolto. Questa affascinante ipotesi non ha trovato però riscontro negli studi successivi, nei quali i ricercatori hanno replicato le prove sperimentali senza ottenere risultati simili.
Le ricerche sull'effetto Mozart hanno evidenziato che difficilmente il semplice ascolto di un brano musicale può indurre un miglioramento di altre abilità. Altri ricercatori ritengono che attività musicali implicano un coinvolgimento attivo possono dare esiti più significativi. Il coinvolgimento attivo nelle attività musicali sembra essere una condizione rilevante per il miglioramento delle abilità spazio-temporali, mentre l'ascolto passivo e la mera esposizione alla musica sono meno significativi. Rimane però da determinare quanto l'educazione influisca direttamente sulle abilità parallele o quanto agisca, attraverso la mediazione di altri fattori quali l'attenzione, l'interesse e la motivazione.
Contributo delle neuroscienze
Le neuroscienze hanno offerto informazioni sullo sviluppo della plasticità cerebrale considerando l'anatomia del cervello e registrando le variazioni delle attività cerebrali indotte dalla musica. I cambiamenti coinvolgono diverse aree neurologiche, con un conseguente miglioramento di specifiche funzioni cognitive. Alcuni studiosi hanno teorizzato dei modelli per spiegare come l'insegnamento della musica possa influenzare le prestazioni in compiti spazio-temporali: è il caso della teoria delle connessioni neurali e del near transfert. La teoria delle connessioni neurali presuppone che centri di elaborazione musicale e spaziale siano sovrapposti nel cervello e dunque lo sviluppo di alcune abilità musicali e spaziali è legato alla presenza di connessioni neurologiche condivise nella corteccia. Nella teoria del near transfert si fa riferimento alle diverse modalità di pensiero coinvolte nelle abilità musicali. Il problema è stabilire il grado di indipendenza tra abilità musicali e altri domini della cognizione, aspetti considerati in alcuni modelli, come quello di Gardner sulle intelligenze multiple.
Implicazioni didattiche
3 This document is available on studocu Scaricato da Alessandra Anticoli (alessandra.anticoli@gmail.com)