Dieci Tesi per l'Educazione Linguistica Democratica del GISCEL
Documento da Giscel su Dieci Tesi per l'Educazione Linguistica Democratica. Il Pdf, di livello universitario e materia Lingue, analizza i limiti dell'approccio tradizionale e propone nuovi principi per un'educazione linguistica democratica, discutendo competenze e attività linguistiche.
Mostra di più25 pagine
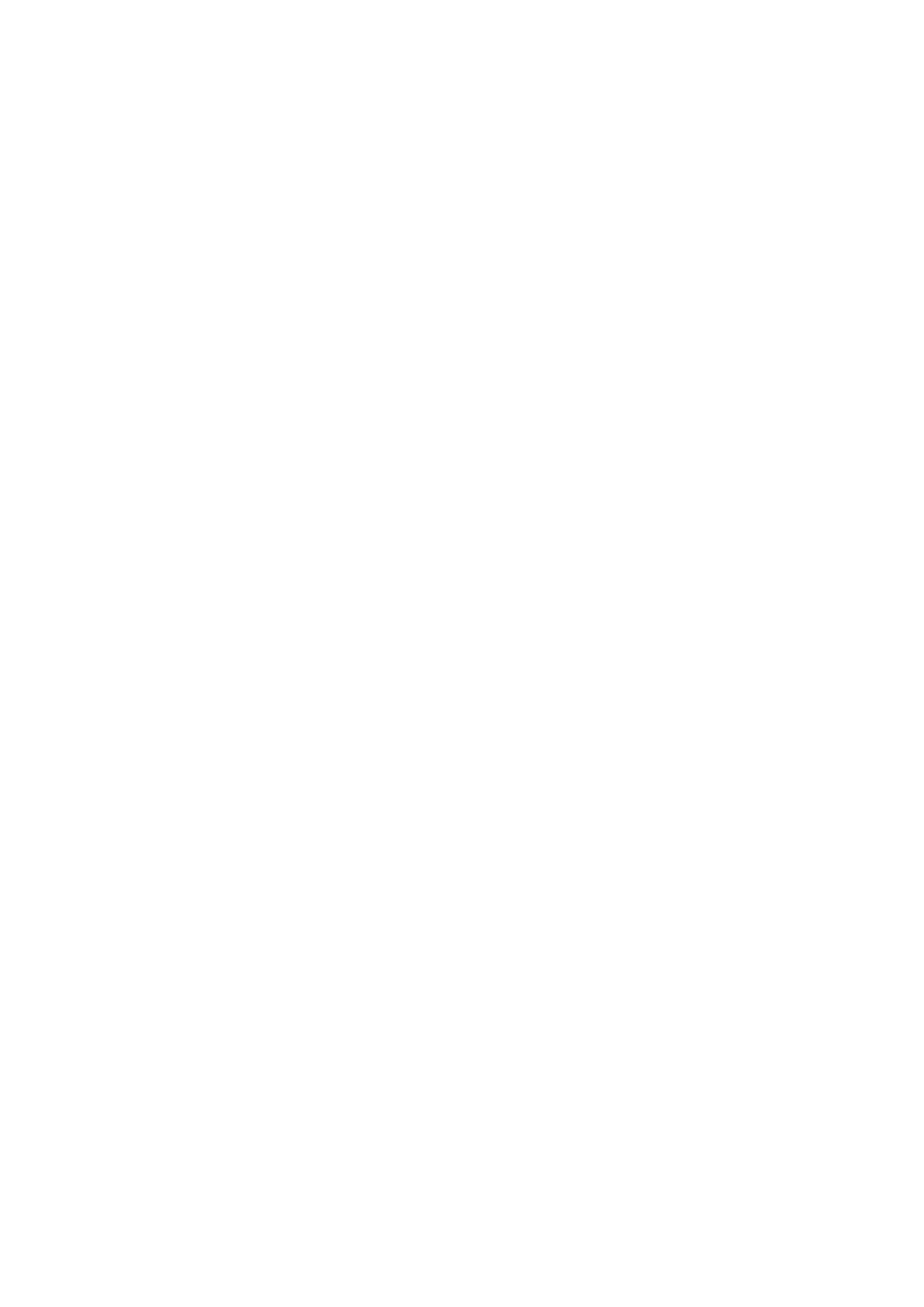

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
DIECI TESI PER L'EDUCAZIONE LINGUISTICA DEMOCRATICA
Testo collettivo formulato dai soci del GISCEL (Gruppo d'Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica) proposto e approvato nel 1975 alla Casa di Cultura di Roma.
- CENTRALITÀ DEL LINGUAGGIO VERBALE Il linguaggio verbale è di fondamentale importanza nella vita sociale e individuale perché, grazie alla padronanza sia ricettiva sia produttiva di parole e fraseggio, possiamo intendere gli altri e farci intendere; ordinare e sottoporre ad analisi l'esperienza; intervenire a trasformare l'esperienza stessa. Esso è una delle forme assunte dalla capacità di comunicare, che si è variamente denominata capacità simbolica fondamentale o capacità semiologica (o semiotica).
- RADICAMENTO NELLA VITA BIOLOGICA, EMOZIONALE, INTELLETTUALE, SOCIALE Le capacità linguistiche trovano le proprie radici nello sviluppo totale dell'uomo, in particolare nello sviluppo dell'organismo sano. Una buona capacità linguistica richiede un organismo sano, una persona denutrita difficilmente riuscirà a comunicare bene. Si propaga poi a livello fisico, emozionale, intellettuale e sociale.
- PLURALITÀ E COMPLESSITÀ DELLE CAPACITÀ LINGUISTICHE Il linguaggio verbale è dotato di molteplici capacità. Alcune più esplicite e visibili, come la capacità di creare frasi in maniera corretta, e altre meno visibili come quella di cogliere il senso delle cose e di analizzare.
- DIRITTI LINGUISTICI DELLA COSTITUZIONE La pedagogia linguistica deve badare al rapporto che c'è tra capacità linguistiche e le capacità correlate come quella fisica, mentale, affettiva e sociale dell'individuo per quanto riguarda l'importanza del linguaggio verbale. La pedagogia linguistica efficace è democratica (non sono necessariamente coincidenti) se e solo se mette in atto principi esposti in testi come l'articolo 3 della Costituzione, che riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini 'senza distinzioni di lingua'. In un Paese come l'Italia in cui il tasso di analfabetismo è molto alto, è fatale il coordinamento delle istituzioni che attivano vita culturale di massa per una piena attivazione delle capacità verbali. Questo è da ricercare soprattutto ma non esclusivamente nelle scuole.
- CARATTERI DELLA PEDAGOGIA LINGUISTICA TRADIZIONALE La pedagogia linguistica tradizionale si basa su vecchie pratiche, spesso troppo datate e nemmeno più in linea con le disposizioni del ministero. Punta i suoi sforzi in quelle che sono le capacità scritta, le abilità produttive, la capacità scritta e orale di fare commenti su testi classici.
- INEFFICACIA DELLA PEDAGOGIA LINGUISTICA TRADIZIONALE Della pedagogia linguistica tradizionale dobbiamo criticare l'inefficienza. Nel 1859 entra in vigore in Italia la legge sull'istruzione obbligatori sin dalle classi elementari. Enormi masse sono passate attraverso queste classi ma ha la pedagogia insegnato loro l'ortografia? No. Eppure ha puntato su quella tutti i suoi sforzi, ma ancora oggi in Italia 1 su 3 è semianalfabeta. I problemi ortografici si riscontrano anche in persone colte, ciò fa comprendere quanto questo sia dovuto adeviazioni radicate e non lapsus freudiano. La pedagogia non realizza bene perciò neanche quegli obiettivi a cui, seppur datati, aveva puntato. Bisogna perciò cambiare tipo di insegnamento.
- LIMITI DELLA PEDAGOGIA LINGUISTICA TRADIZIONALE La pedagogia linguistica tradizionale non pecca solo di inefficacia ma anche per la parzialità dei suoi scopi. A) Pretendere di operare settorialmente solo nelle ore di italiano non contando il fatto che dovrebbe farlo anche nelle altre ore e coinvolgere gli altri insegnanti. Inoltre da importanza soltanto alle abilità produttive e le ricettive sono ignorate. B) Bada soltanto alla produzione scritta, non cura la capacità orale e questo è perfettamente evidente durante le interrogazioni in cui è valutato il contenuto ma il metodo di esposizione è messo da parte. C) Nella produzione scritta viene considerato solo il fattore "discorrere più a lungo possibile su un fattore" che è utile soltanto in poche situazioni, altre caratteristiche come quella riassuntiva o la capacità di prendere appunti non sono valorizzate. D) Si fonda sull'insegnamento della grammatica, regole, paradigmi e analisi grammaticale e logica. Diversi studiosi concordano sul fatto che l'insegnamento della grammatica tradizionale
Riflessione sui fatti linguistici
- Se la riflessione sui fatti linguistici deve esserci a scuola essa deve tener conto anche di: storia della lingua, storia linguistica, sociologia, psicologia, semantica
- Lo studio delle regole per sviluppare le capacità è poco utile. È come pretendere di studiare un manuale di anatomia e credere di correre più veloce.
- È nocivo, spesso le nozioni che si apprendono fanno acqua da tutte le parti, disordinate e anche sbagliate.
- Non si conta il fatto che vi sia un rapporto tra capacità verbali e altre capacità (come danza, disegno, ritmo ... ). Non da valore alle capacità non verbali spesso chiave per la memorizzazione.
L'educazione linguistica tradizionale è funzionale in altri sensi: è rivolta all'insegnamento delle classi sociali più colte cui mancanze nelle altre competenze vengono colmate al di fuori delle mura scolastiche. E questo è stato evidente solo quando sono stati messi accanto a figli di classi popolari e operaie. Senza colpa perciò insegnati continuano ad applicare un metodo che vige in Italia, facendosi esecutori di un progetto politico.
- PRINCIPI DELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA DEMOCRATICA L'educazione linguistica democratica ha dei tratti basati su 10 principi:
Principi dell'educazione linguistica democratica
- Lo sviluppo di capacità verbali va promosso in stretto rapporto reciproco con tutti gli altri tipi di capacità
- Lo sviluppo e l'esercizio delle capacità linguistiche non vanno mai proposti e perseguiti come fini a sé stessi, ma come strumenti di più ricca partecipazione alla vita sociale e intellettuale. Quindi l'addestramento delle capacità verbali va sempre motivato entro leattività di studio, ricerca, discussione, partecipazione, produzione individuale e di gruppo.
- Occorre partire dall'individuazione del retroterra linguistico-culturale personale, familiare, ambientale dell'allievo, per poi arricchirne il patrimonio linguistico.
- Da qui giungere a esplorare la varietà spaziale e temporale, geografica, sociale, storica presente in ogni lingua.
- Sviluppare e tenere d'occhio sia le capacità produttive che ricettive.
- In queste, va sviluppato l'aspetto sia orale sia scritto.
- Nelle capacità produttive-ricettive e nell'aspetto scritto-orale, stimolare la capacità di passaggio dalle formulazioni più locali, colloquiali, informali, a quelle più generalmente usate, più meditate, riflesse e formali.
- Quindi, necessità di addestrare alla conoscenza e all'uso di modi istituzionalizzati d'uso della lingua comune (linguaggio giuridico, linguaggi letterari e poetici ... )
- Nella cornice complessiva delle varie capacità linguistiche, occorre curare e sviluppare in particolare, fin dalle prime esperienze scolari, la capacità, inerente al linguaggio verbale, di autodefinirsi e autodichiararsi e analizzarsi.
- In ogni caso e modo occorre sviluppare il senso della funzionalità di ogni possibile tipo di forme linguistiche. La vecchia pedagogia linguistica era imitativa, dittatoriale ed esclusiva.
- PER UN NUOVO CURRICULUM PER GLI INSEGNANTI La nuova educazione linguistica non è pigra. Richiede attenzioni e conoscenze sia da parte degli alunni che dagli insegnati cui vecchie prospettive facevano controllare soltanto l'uso di regole cristallizzate. Seguire i principi della pedagogia democratica richiede un salto di qualità e quindi nel bagaglio dei futuri docenti, nella loro formazione, deve essere inclusa la formazione delle competenze sul linguaggio e i processi educativi con le sue tecniche.
- CONCLUSIONE Ci troviamo davanti a un problema amministrativo e civile, un problema politico. Queste analisi hanno senso soltanto se le forze sociali sono disposte a riorganizzare l'egemonia e a gestire la scuola secondo obiettivi democratici.
LE SFIDE DI BABELE, P. BALBONI.
Capitolo 1. Il quadro di riferimento.
La didattica delle lingue attuale si fonda sul lancio del modern language project da parte del Consiglio d'Europa nel 1967. La glottodidattica (o didattica delle lingue) è la disciplina che analizza e mette in pratica approcci teorici, metodi e tecniche per l'insegnamento delle lingue. Studia l'educazione linguistica, l'azione che mira a far emergere la facoltà di linguaggio ovvero la capacità spontanea di acquisire una lingua che sia parziale o meno. Trae le sue conoscenze da diverse aree scientifiche, che per essere usate hanno il bisogno di essere organizzate e gerarchizzate.Gerarchizzazione di Anthony Spazio della RICERCA glottodidattica APPROCCIO METODO Teorie di riferimento, mondo delle idee - fondato/infondato - adeguato/non sulle teorie adeguato a realizzare l'approccio Metodologia, mondo dell'azione didattica - generativo/sterile di metodi -coerente/incoerente al suo interno Spazio dell'AZIONE glottodidattica La glottodidattica è una scienza teorico- pratica. Il grafico scinde conoscenza teorica elaborata in proprio (approccio) e l'uso di tale conoscenza (metodo). Le frecce bidirezionali indicano lo scambio dal mondo delle idee all'insegnamento. L'approccio è la filosofia di fondo, è l'idea di come è fatta una lingua e di come la si apprende. Il metodo è la traduzione dell'approccio in procedure operative concrete. Per trasformare il metodo in azione gli insegnanti selezionano delle tecniche adeguate al metodo e coerenti con l'approccio. Il cognitivismo indica due tipi di base di conoscenza, dichiarativa e procedurale: - Dichiarativa: una dichiarazione è espressa da una frase semplice retta di solito da verbi quali "è", "c'è"; - Procedurale: una procedura è basata su dichiarazioni come "mettiamo che" "se" L'insegnamento e l'apprendimento si basano sull'etica. I parametri o variabili (le variabili in gioco) su cui si basa la glottodidattica, quindi gli approcci e metodi sono: - Teorie di riferimento; - Percorso: induttivo (lo studente scopre da solo seppur guidato un minimo dall'insegnante) o deduttivo (si danno delle regole e si deduce attraverso quelle); - Studente: tabula rasa oppure protagonista; - Docente: totalitario oppure regista; - Lingua: insieme di regole o strumento di comunicazione più libera - Cultura: letteraria classica o quotidiana; - Strumenti operativi; - Tecniche didattiche: varie attività; - Materiali: manuali; - Strumenti tecnologici.
Capitolo 2. Come nasce la glottodidattica
2.1. Approcci e metodi della tradizione
Nel mondo classico, nel Medioevo e nel Rinascimento, l'insegnamento linguistico è essenzialmente "comunicativo", basato sull'uso prima che sulla forma. Iniziano poi a nascere centri che studiano la lingua come oggetto, si creano i primi dizionari e le prime grammatiche, e così via. Approccio formalistico: domina in Italia dal seicento fino agli anni settanta. Focalizza l'attenzione sulla grammatica e la fonologia è concepita come regole di pronuncia. È condannata ogni variante regionale, l'unico registro è quello formale, lo studente è una tabula