Metodologia della ricerca: grounded theory e studi di caso in Psicologia
Slide da Università su Metodologia della ricerca. Il Pdf esplora la ricerca qualitativa, la grounded theory e gli studi di caso singoli e multipli, argomenti di Psicologia per l'Università.
See more16 Pages
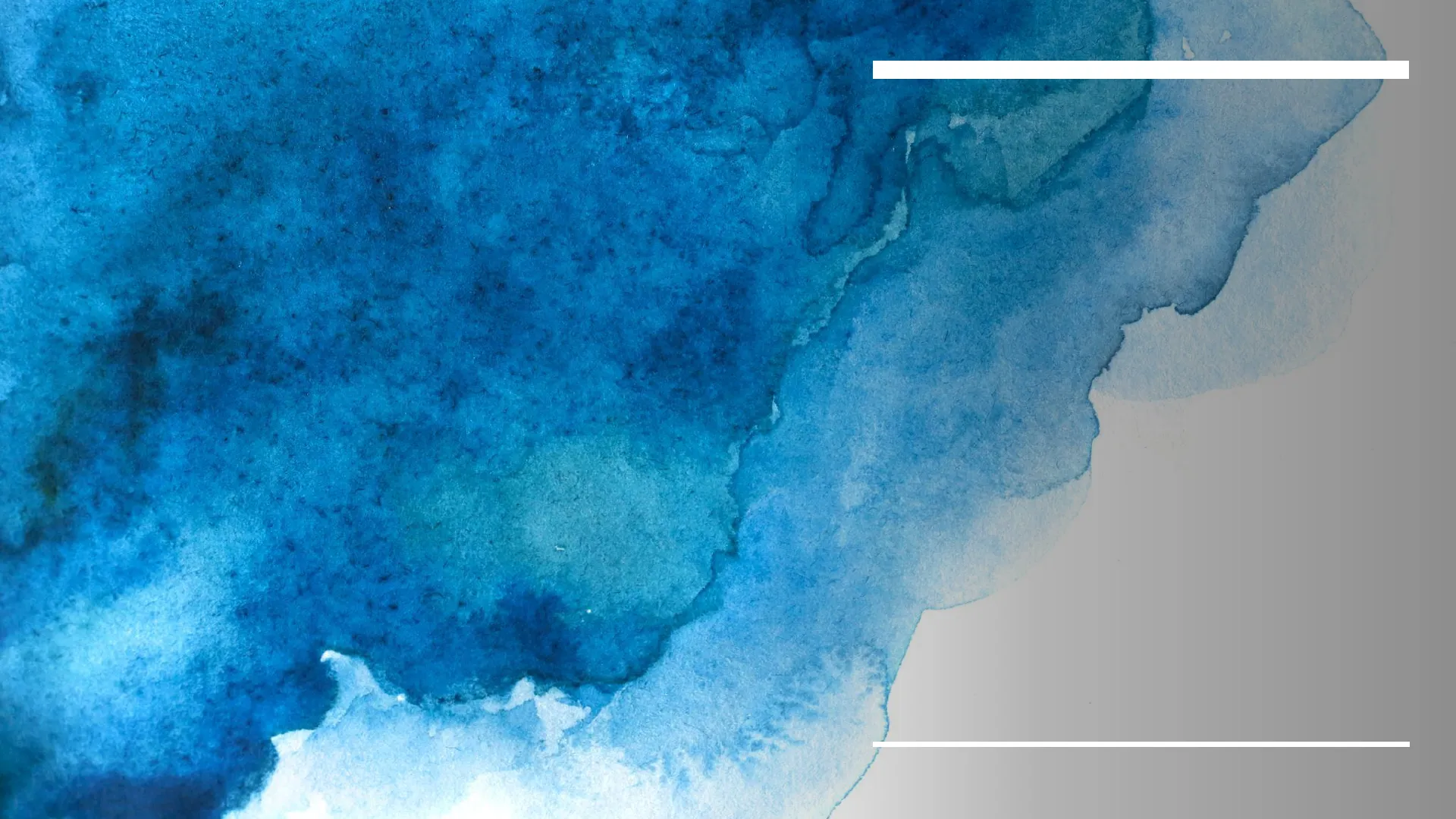
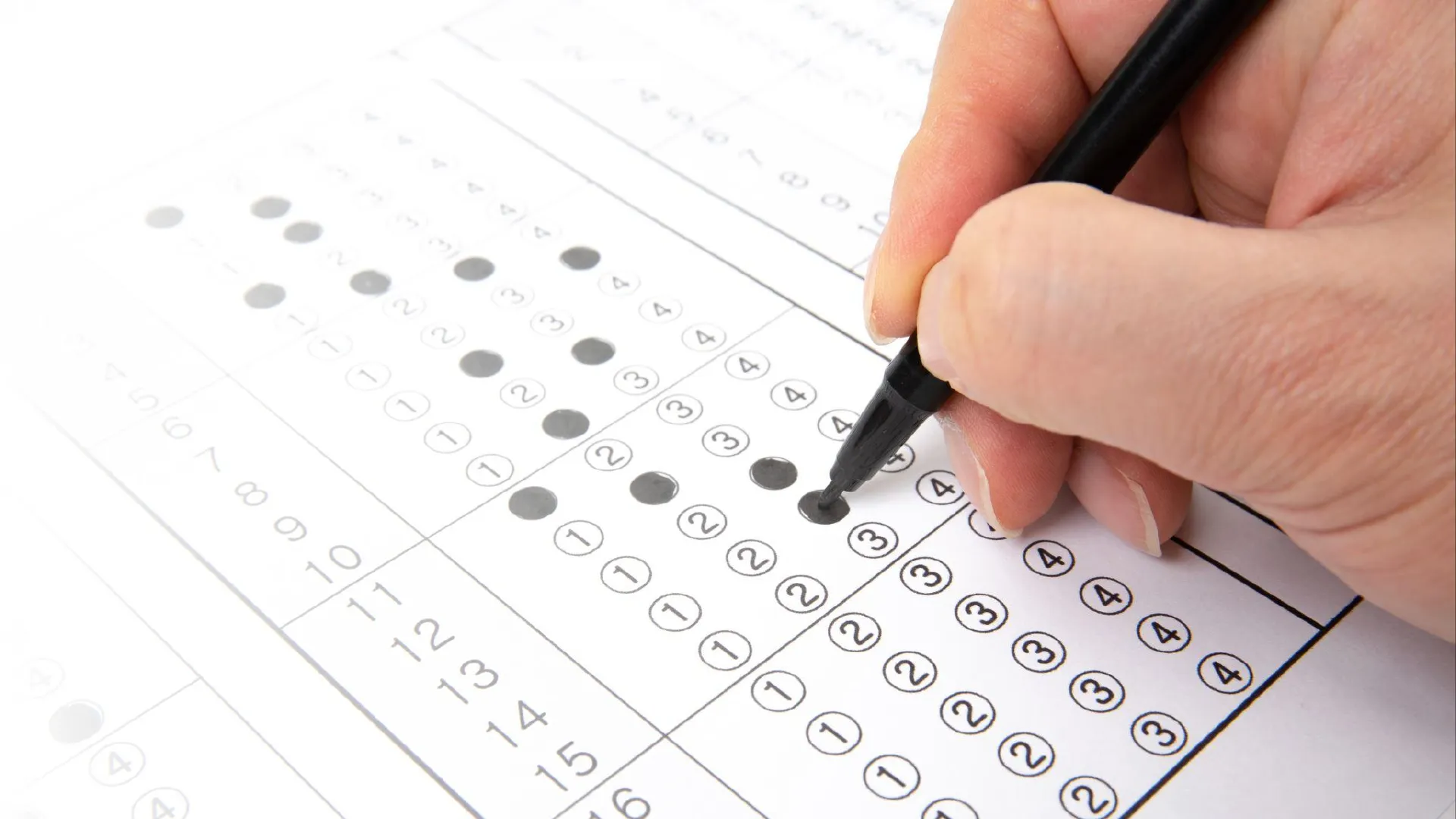
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Metodologia della ricerca
La ricerca Prof.ssa Deborah FasoliD 4 0 D 3 4 3 S 2 2 2 3 2 1 2 4 3Che cos'è un questionario?
Un questionario è uno strumento di ricerca costituito da una serie di domande o altri tipi di suggerimenti che mira a raccogliere informazioni da un rispondente. Un questionario di ricerca è in genere un mix di domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta . ?
Le domande aperte e di lunga durata offrono al rispondente la possibilità di elaborare i propri pensieri. I questionari di ricerca furono sviluppati nel 1838 dalla Statistical Society di Londra.
I dati raccolti da un questionario di raccolta dati possono essere di natura sia qualitativa che quantitativa . Un questionario può essere consegnato o meno sotto forma di sondaggio , ma un sondaggio consiste sempre in un questionario.Vantaggi di un buon questionario
- Con un questionario di indagine, puoi raccogliere molti dati in meno tempo.
- Ci sono meno possibilità che si insinuino pregiudizi se si dispone di una serie standard di domande da utilizzare per il proprio pubblico di destinazione. Puoi applicare la logica alle domande in base alle risposte degli intervistati, ma il questionario rimarrà standard per un gruppo di intervistati che rientrano nello stesso segmento.
- Il software per sondaggi online Surveying è rapido ed economico. Offre un ricco set di funzionalità per progettare, distribuire e analizzare i dati di risposta.
- Può essere personalizzato per riflettere la voce del tuo marchio. Pertanto, può essere utilizzato per rafforzare l'immagine del tuo marchio.
- Le risposte possono essere confrontate con i dati storici e comprendere il cambiamento nelle scelte e nelle esperienze degli intervistati.
- Gli intervistati possono rispondere al questionario senza rivelare la propria identità. Inoltre, molti software per sondaggi sono conformi a importanti regolazioni sulla sicurezza dei dati e sulla privacy.
L'intervista
L'intervista, per definizione, è uno scambio verbale tra più persone nel quale uno o più esperti cercano di raccogliere informazioni su dati personali, comportamenti e atteggiamenti di uno o più soggetti intervistati su un particolare tema.
Per tanto è presente l'elemento partecipativo tra i soggetti durante la raccolta- produzione dei dati, sia che si tratti di interviste individuali, in cui l'intervistatore pone domande a un singolo soggetto, sia che riguardi interviste collettive, in cui l'esperto interroga gruppi di individui.
In quest'ultimo gruppo si trovano i focus group, situazione nella quale un moderatore pone domande e i partecipanti forniscono individualmente risposte.Il Focus Group
Il focus group è una tecnica di ricerca che nasce negli Stati Uniti ad opera di due sociologi degli anni `40 del Novecento, K. Levin e R. Merton, al fine di focalizzare un argomento e far emergere le relazioni tra i partecipanti.
- Dall'inglese Focus = punto centrale / messa a fuoco, il focus group è un gruppo di persone guidate da uno o più moderatori a discutere fra di loro per mettere a fuoco un preciso argomento di ricerca.
- Si tratta di una conversazione focalizzata su uno ed un solo tema di cui i partecipanti parlano per circa un'ora e mezza/due ore. Durante la sessione, il moderatore incoraggia il flusso libero di idee in base a delle domande prestabilite, poi raccoglie i dati relativi alle percezioni soggettive che saranno il punto di partenza degli interventi futuri di chi ha avviato la ricerca.
Che cosa è il focus group?
è un metodo usato nelle ricerche sociali in cui un piccolo gruppo di persone - dai 6 ai 12 partecipanti - si confronta su un argomento sotto la supervisione di uno o più moderatori
è una tecnica non standardizzata di rilevazione dell'informazione,basata su una discussione, che è solo apparentemente informale, tra un gruppo di persone, di dimensioni non troppo estese, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità.
Spesso si ricorre ai focus groups solo perché sono considerati una tecnica economica e facile da organizzare, con la fortuna di essere attualmente anche accreditata da parte della comunità scientifica.Caratteristiche del focus group
- Durata: il focus group non deve durare meno di 90 minuti e non oltre i 120 minuti.
- Conduzione: il focus group viene normalmente effettuato da due persone: un facilitatore che conduce la discussione e un osservatore che esamina le dinamiche di relazione del gruppo.
- Partecipanti: i partecipanti al focus group devono essere almeno 6/7 e non più di 12/13 persone, poiché un numero inferiore potrebbe inficiare le dinamiche di gruppo, mentre un numero superiore tende spesso a censurare l'intervento delle opinioni contrarie o deboli, non permettendo a tutti i partecipanti di esprimere al meglio le proprie idee.
I partecipanti
- Chi partecipa alla discussione viene reclutato in base a determinati parametri (sesso, età, provenienza geografica ecc.) per formare un gruppo eterogeneo che rappresenti le diverse categorie del target, cioè il pubblico di riferimento.
- Il moderatore (o i moderatori nel caso in cui fossero due) dà il via alla discussione sull'argomento in modo da permettere ai partecipanti di scambiare opinioni liberamente. Generalmente segue una scaletta di D omande per guidare il dibattito e garantire che i partecipanti restino in tema.
Tipi di Focus group
- Tradizionale: con 6-12 membri e un moderatore
- Mini: con 4 o 5 persone
- Focus group a distanza o online: funziona come un focus group tradizionale ma si svolge a distanza utilizzando piattaforme di videoconferenza, quindi pc e internet. In questo caso la partecipazione è limitata di solito a 6-8 persone che condividono risposte sui loro monitor o le espongono a voce guidate dal moderatore
- A due vie: la sessione si organizza intorno a 2 gruppi uno dei quali discute l'argomento mentre l'altro commenta le conclusioni cui è giunto il primo gruppo
- Con un moderatore partecipante: uno o più partecipanti fanno temporaneamente le veci del moderatore
- Con moderatori duellanti: due moderatori assumono posizioni opposte sullo stesso argomento
Fasi di attuazione del focus group
- 1. RISCALDAMENTO è la fase più delicata in cui si determina l'esito del focus group, poiché spesso conduttore e osservatore sono percepiti con diffidenza, quali intrusi indagatori; pertanto, è bene mitigare il clima con un approccio amichevole e "soft". Si inizia poi a strutturare la comunicazione sul contenuto, stimolando i partecipanti con un giro di tavolo o mediante la tecnica del metaplan, invitandoli a riflettere su un tema generico che deve essere sempre più specificato e indagato nella direzione utile rispetto ai fini preposti, seguendo i ragionamenti e le parole dei partecipanti stessi e facendone un'analisi semantica e del contenuto per farne emergere le criticità.
- 2. RELAZIONE in questa fase si indaga il clima del gruppo, è perciò opportuno fare domande su tematiche di interesse comune e condiviso (tipo la mission dell'ente, i valori, la cultura aziendale laddove si conduce un focus group interno all'Amministrazione). E' possibile utilizzare le tecniche proiettive per stimolare le libere associazioni e favorire l'esposizione di tutti i partecipanti (ad esempio: se io dico ... , voi dite ....? - Un buon motivo per lavorare qui è ...? - Se avessi la bacchetta magica, della mia amministrazione cambierei ....? )
- 3. CONSOLIDAMENTO in questo momento, di norma, emergono le problematiche più sentite: è perciò importante, oltre a lasciare che il gruppo metta in evidenza le proprie criticità, tentare di calmare i partecipanti affinchè non si verifichino conflitti e per evitare che il focus group diventi uno "sfogatoio" di problemi più di affermazione personale che di necessità professionale.
- 4. DISTACCO la quarta fase è quella dell'allontanamento: per evitare di deludere le aspettative dei partecipanti, che, a questo punto, se la tecnica di ricerca è stata condotta ed utilizzata nel modo appropriato, sono in piena sintonia con il conduttore, in cui ripongono fiducia, è bene attuare un distacco graduale, lasciando che il gruppo si sfaldi da sé, in modo naturale.
Lo studio di caso
La formalizzazione della strategia di ricerca dello studio di caso (case study) si deve a Robert Stake. Essa ha come obiettivo lo studio di unità di analisi ristrette, quali possono essere singoli soggetti, piccoli gruppi, classi, team di lavoro o di studio, comunità, ambienti educativi, denominate appunto casi. I casi sono unità autonome dotate di una struttura propria, delimitate in termini di spazi e di attori (es. una classe), con caratteristiche di unitarietà e specificità che ne rendono sensato il loro studio come unità autonome. Lo studio avviene in un arco temporale ben definito che può anche essere molto lungo, dato che spesso gli studi di caso sono studi longitudinali, ossia studi che prevedono una rilevazione ripetuta dei dati sugli stessi referenti, più che la rilevazione su più referenti in un arco temporale ristretto (studi trasversali), come nell'inchiesta.Applicazione dello studio di caso
Applicazioni tipiche degli studi di caso sono: a) descrivere e spiegare le connessioni causali complesse che intercorrono tra i fattori considerati e che definiscono la specificità intrinseca della tipologia di casi studiata (ad esempio i ragazzi che abbandonano la scuola superiore); b) scoprire il modo in cui operano questi fattori inquadrandoli all'interno di contesti e situazioni reali, all'opposto di quanto fanno altri tipi di ricerche, tra i quali quelle sperimentali, che tendono ad isolare i fattori dal contesto; c) descrivere gli effetti (visibili e meno visibili), in contesti reali, di specifici interventi educativi e studiare le situazioni in cui uno specifico intervento educativo provoca o non provoca gli effetti desiderati.
Ipotesi e ipotesi alternative
- Nello studio di caso l'intero processo di ricerca, dalla raccolta dei dati all'analisi degli stessi, è spesso guidato da ipotesi e in alcuni casi da una teoria più generale che le lega, espressa sotto forma di sistema di asserti. Accanto alle ipotesi che guidano lo studio vengono già definite in anticipo ipotesi alternative, le quali vengono prese in considerazione se l'evidenza empirica confuta le prime. Il quadro di ipotesi di partenza non è tuttavia rigido, ma può cambiare ed adattarsi all'evidenza empirica raccolta. Le ipotesi possono essere confermate o confutate e in base a questo possono essere cambiate o eliminate, e altre ne possono essere aggiunte, prendendole nel set di ipotesi alternative o ideandone di nuove sulla base di quanto emerso dall'indagine sul campo. Assunto basilare è che anche l'evidenza empirica raccolta su un solo caso può dare luogo a questo processo di revisione della teoria e delle ipotesi.