Ordinamento penitenziario italiano: norme, esecuzione pene e misure alternative
Documento sull'ordinamento penitenziario italiano. Il Pdf esplora la nozione, le fonti normative e gli aspetti pratici della vita carceraria, come l'accoglienza, l'igiene e l'assistenza sanitaria, per studenti universitari di Diritto.
See more39 Pages
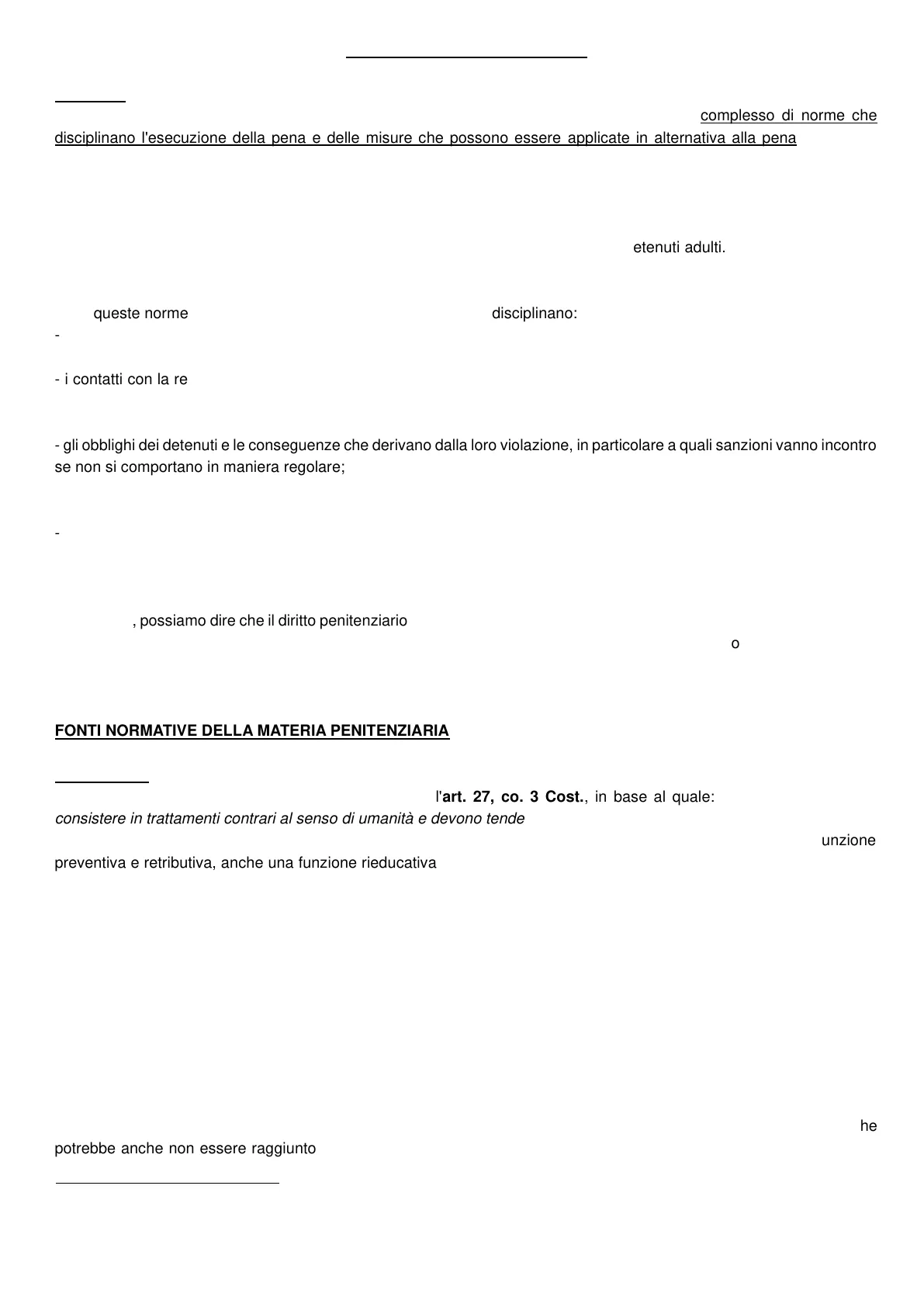
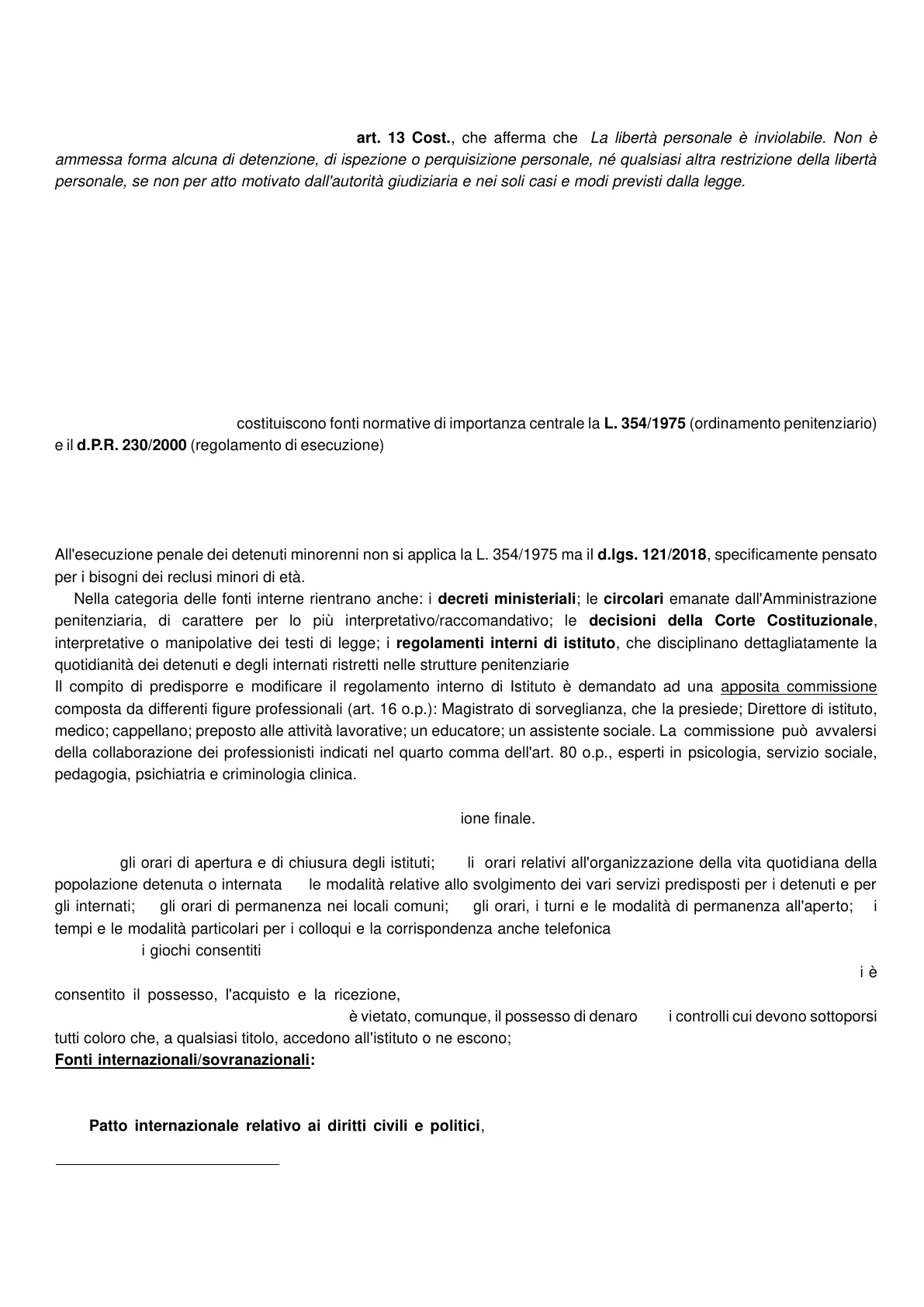
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Nozione di Ordinamento Penitenziario
Con l'espressione "ordinamento penitenziario" (o "diritto penitenziario") si fa riferimento al complesso di norme che disciplinano l'esecuzione della pena e delle misure che possono essere applicate in alternativa alla pena (così dette "misure alternative"). La maggior parte di queste norme è contenuta nella L. n. 354/1975 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale", c.d. "ordinamento penitenziario", comunemente abbreviato in "o.p." o "ord. pen.") e nel Regolamento di esecuzione adottato con d.P.R. n. 230/2000 (c.d. "regolamento di esecuzione", di solito abbreviato in "r.e." o "reg. esec."). Tali norme si applicano ai detenuti adulti. Ai detenuti minorenni si applica una disciplina diversa e più attenta ai loro bisogni: il d.lgs. (= decreto legislativo) n. 121/2018. Si tratta di un vero e proprio "ordinamento penitenziario minorile". Tutte queste norme, come vedremo più nel dettaglio in seguito, disciplinano:
- lo svolgimento della vita carceraria -> come sono articolate le giornate in istituto, quali attività (es. lavorative, formative, di svago) si possono fare, quali professionisti se ne occupano;
- i contatti con la realtà esterna -> quante telefonate possono fare i detenuti e a chi, quanti colloqui possono fare e con chi, se possono leggere libri/riviste e guardare la televisione, e più in generale quali e quanti contatti possono avere con il mondo esterno;
- gli obblighi dei detenuti e le conseguenze che derivano dalla loro violazione, in particolare a quali sanzioni vanno incontro se non si comportano in maniera regolare;
- i diritti dei detenuti e gli strumenti di tutela attivabili -> la normativa, sia nazionale che sovranazionale, prevede numerosi diritti a favore dei detenuti e precisi strumenti di tutela che essi possono utilizzare quando i loro diritti vengono violati;
- i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione -> se i detenuti mantengono una regolare condotta e mostrano di partecipare in maniera costruttiva e consapevole al trattamento rieducativo cui vengono sottoposti, possono ottenere svariati benefici (es. permessi premio) o, addirittura, espiare la loro pena fuori dal carcere sotto forma di misura alternativa.
In definitiva, possiamo dire che il diritto penitenziario è una materia molto vasta, strettamente collegata con il diritto penale - esso disciplina infatti tutto ciò che sta tra l'applicazione della pena e la liberazione del condannato, ponendo la propria attenzione non solo a ciò che "sta dentro" al carcere, ma anche a ciò che "sta fuori" ed è con esso collegato. Entriamo nel dettaglio.
Fonti Normative della Materia Penitenziaria
Il diritto penitenziario è regolato sia da fonti interne al nostro ordinamento che da fonti internazionali.
Fonti Interne del Diritto Penitenziario
a) Rappresenta fonte interna di massima importanza l'art. 27, co. 3 Cost., in base al quale: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Si tratta di una norma che sancisce un principio di estremo valore, riconoscendo alla pena, oltre ad una funzione preventiva e retributiva, anche una funzione rieducativa: a) funzione retributiva -> la pena serve a compensare il danno provocato mediante una afflizione, una punizione proporzionata ad esso; b) funzione general-preventiva (anche detta "di prevenzione generale") -> la pena serve a indurre tutte le persone a rispettare la legge, perchè l'applicazione della pena al condannato rappresenta un deterrente per tutti gli altri; c) funzione special-preventiva (anche detta "di prevenzione speciale") -> la pena serve ad evitare che il reo torni a violare la legge penale. Quest'ultima funzione può realizzarsi in due modi diversi: mediante la neutralizzazione del reo (tipico esempio è l'esecuzione della pena in carcere) e mediante la risocializzazione/rieducazione del condannato1. L'art. 27, co. 3 Cost. impone a tutti gli operatori penitenziari di tendere alla risocializzazione dei condannati, cioè di far loro comprendere i valori offesi e quelli fondamentali su cui si basa la vita sociale, di prepararli ad un ritorno in società dove potranno evitare la reiterazione di condotte criminose. Lo scopo della rieducazione, cioè, è quello di far evolvere la personalità dei detenuti verso modelli socialmente validi, di indurre i detenuti a revisionare le motivazioni che li hanno condotti verso scelte criminali. NB: la Costituzione utilizza il verbo "tendere" -> significa che quello della risocializzazione è un obiettivo cui si tende, che potrebbe anche non essere raggiunto: molto dipende dalla adesione del detenuto al trattamento rieducativo che viene 1Come vedremo, l'attuazione della funzione rieducativa è affidata alle attività trattamentali organizzate negli istituti di pena, ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. Marta F. Tarallopensato per lui, dalla sua disponibilità a collaborare e ad aderire alle attività rieducative organizzate dall'istituto penitenziario. Inoltre, il termine "rieducazione" non deve essere inteso come "pentimento interiore" -> viviamo in uno Stato democratico di diritto in cui quello che si può fare è "semplicemente" insegnare il rispetto dei valori fondamentali della vita sociale.
b) Altra fonte interna molto importante è l'art. 13 Cost., che afferma che "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Da questa norma traspare forte l'esigenza di porre al centro del sistema punitivo la persona e la sua libertà, che può subire restrizioni solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge (riserva di legge assoluta) e solo quando vi è un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Ad ogni modo, l'articolo 13 co. 4 Cost. richiede il rispetto della personalità e dignità della persona sottoposta a restrizioni, con il divieto assoluto di compiere atti arbitrari di violenza o di coercizione.
c) Come sopra accennato, costituiscono fonti normative di importanza centrale la L. 354/1975 (ordinamento penitenziario) e il d.P.R. 230/2000 (regolamento di esecuzione). Mentre la prima è una legge statale contenente disposizioni (cioè regole) di carattere generale, il secondo è un regolamento contenente disposizioni più specifiche (esempio: l'art 18 o.p. stabilisce in maniera piuttosto generica che il detenuto può effettuare colloqui con i familiari: quali familiari? quando può effettuarli? A queste domande risponde l'art 37 reg. esec .: sei colloqui al mese per un'ora ciascuno con parenti o affini fino al quarto grado). All'esecuzione penale dei detenuti minorenni non si applica la L. 354/1975 ma il d.lgs. 121/2018, specificamente pensato per i bisogni dei reclusi minori di età.
d) Nella categoria delle fonti interne rientrano anche: i decreti ministeriali; le circolari emanate dall'Amministrazione penitenziaria, di carattere per lo più interpretativo/raccomandativo; le decisioni della Corte Costituzionale, interpretative o manipolative dei testi di legge; i regolamenti interni di istituto, che disciplinano dettagliatamente la quotidianità dei detenuti e degli internati ristretti nelle strutture penitenziarie. Il compito di predisporre e modificare il regolamento interno di Istituto è demandato ad una apposita commissione composta da differenti figure professionali (art. 16 o.p.): Magistrato di sorveglianza, che la presiede; Direttore di istituto, medico; cappellano; preposto alle attività lavorative; un educatore; un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione dei professionisti indicati nel quarto comma dell'art. 80 o.p., esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Redatto il regolamento, esso viene trasmesso al Provveditore regionale competente. Quest'ultimo, se non ha nulla da contestare, lo invia al capo del D.A.P., cui spetta l'approvazione finale. Molteplici sono le materie disciplinate dal regolamento interno di istituto. Un'elencazione è contenuta nell'art. 36 reg. esec .: a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalità; h) i giochi consentiti; i) i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi; I) l'orario dei pasti; m) i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive; è vietato, comunque, il possesso di denaro2; n)i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono; ecc.
Fonti Internazionali e Sovranazionali
Fonti internazionali/sovranazionali: Queste fonti si caratterizzano per essere firmate da più Stati, che si vincolano a rispettarle, e sono accomunate dalla volontà di proteggere i diritti fondamentali delle persone, la loro libertà e la loro dignità. Le principali sono: a) il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1966 (art. 7: 2Gli oggetti che il detenuto non può tenere con sé sono ritirati dalla direzione, che li mette in un deposito per poi restituirli all'atto della dimissione. Se si tratta di oggetti ingombranti che non possono essere tenuti in magazzino, sono consegnati ai familiari durante i colloqui o spediti agli stessi a spese del detenuto. Marta F. Tarallo