Geochimica dell'atmosfera: fugacità di ossigeno e composizione atmosferica
Slide da Uni-Milano Bicocca sulla Geochimica dell'atmosfera (seconda parte). La Pdf è una presentazione di Chimica per l'Università, che esplora la fugacità di ossigeno e la composizione atmosferica post-differenziazione, con formule e grafici.
See more47 Pages
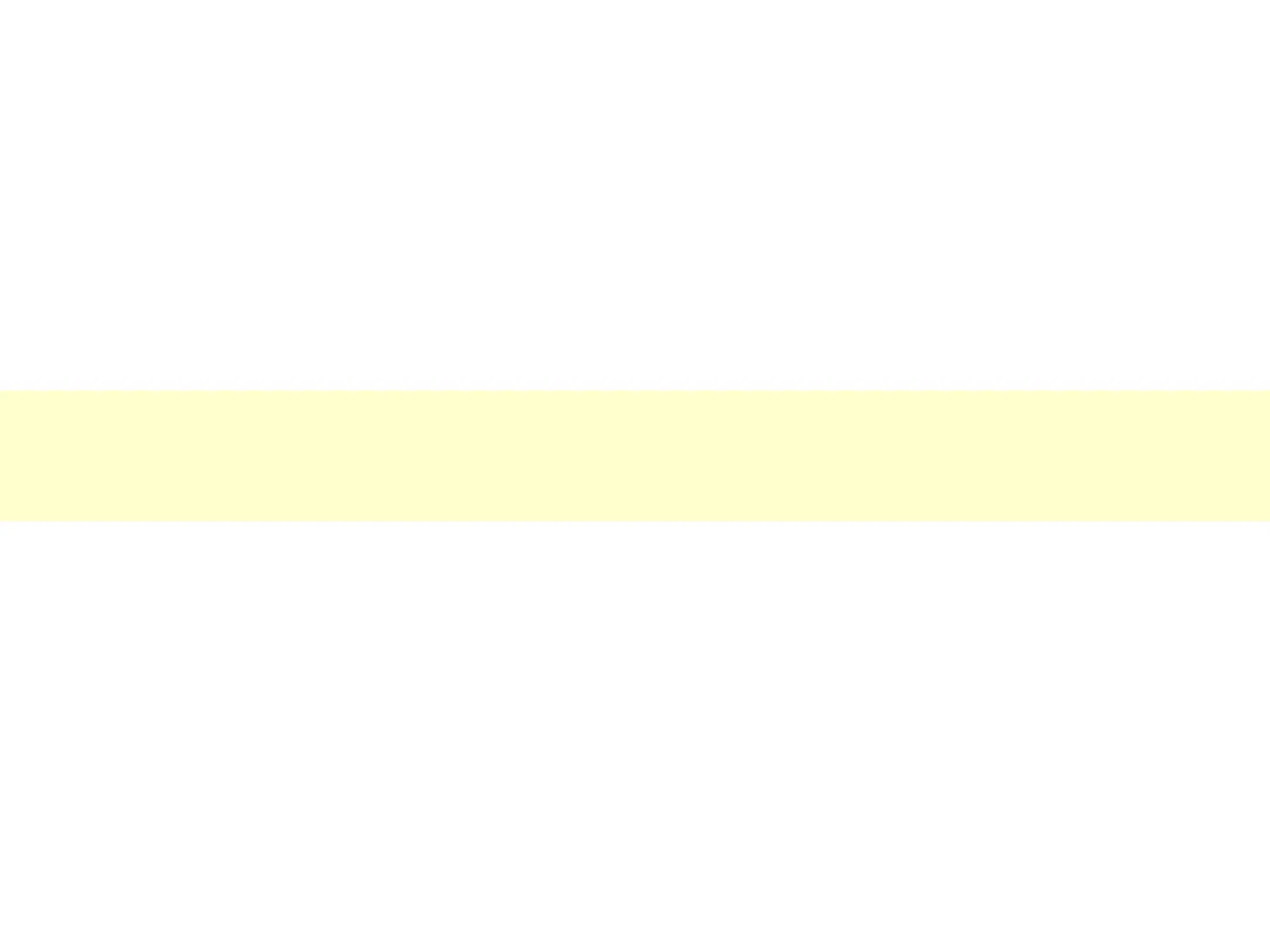
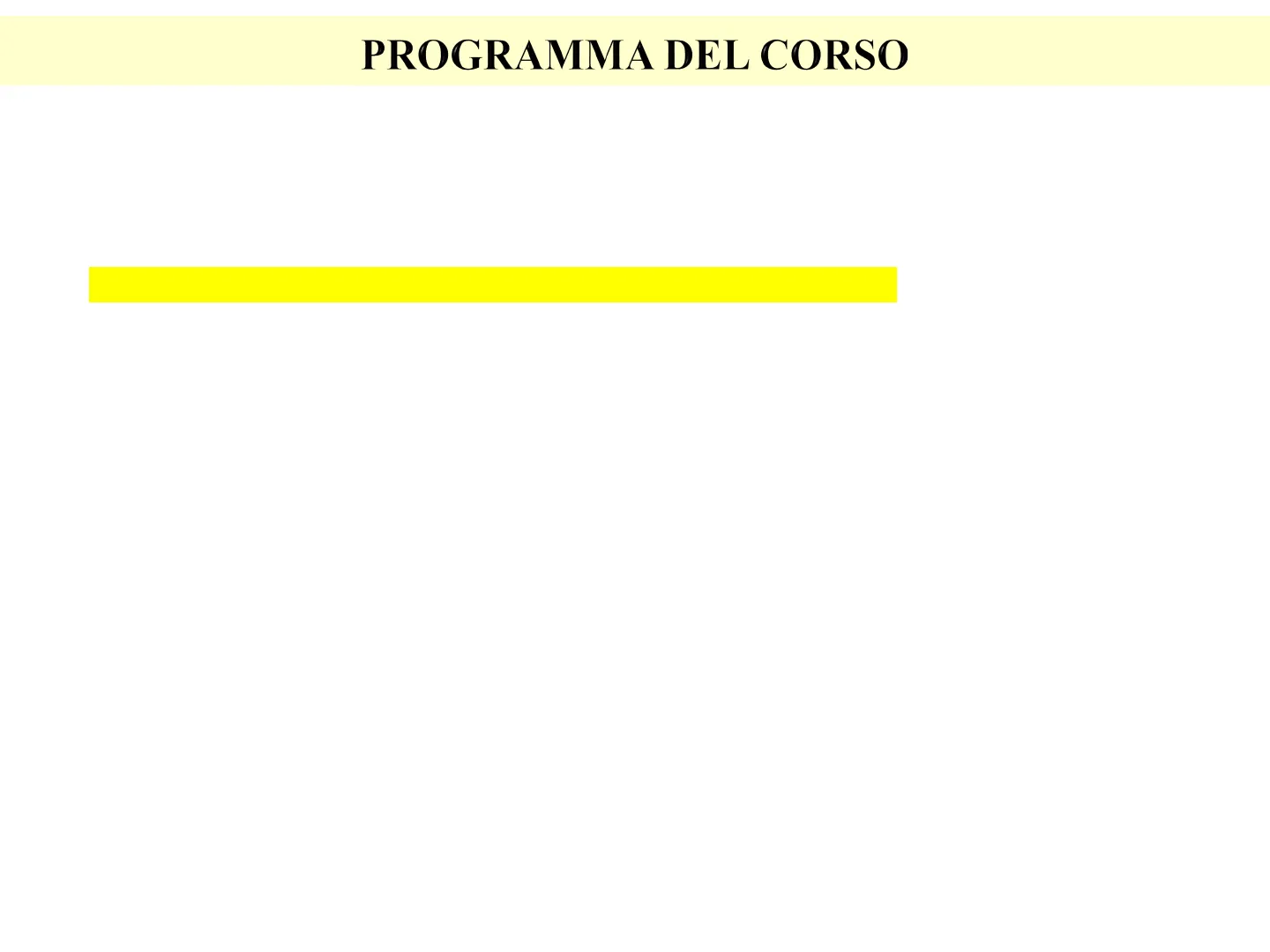
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
LEZIONE N.5
Geochimica dell'atmosfera (seconda parte)
Corso di GEOCHIMICA (8 CFU) Scienze e Tecnologie Geologiche (Uni-Milano Bicocca, DISAT) AA 2024-2025 - II semestre Prof. Andrea L. Rizzo: andrealuca.rizzo@unimib.it
PROGRAMMA DEL CORSO
- Nozioni di base di Chimica e Geochimica. Sfere geochimiche.
- Cenni di cosmochimica e nucleosintesi.
- Evoluzione del sistema solare e della Terra.
- Affinità geochimica degli elementi. Geochimica dell'atmosfera.
- Geochimica della Litosfera.
- Geochimica dei volatili magmatici. Solubilità dei volatili. Degassamento magmatico.
- Geochimica dell'Idrosfera.
- Weathering meccanico e chimico. Cicli geochimici degli elementi.
- Geochimica degli isotopi stabili.
- Il decadimento radioattivo. Meccanismi ed applicazioni alla geocronologia.
- Geochimica degli isotopi radiogenici.
- Geochimica dei gas nobili.
- Principali metodologie di campionamento e tecniche analitiche.
- Cenni a metodi di visualizzazione ed elaborazione dei dati geochimici.
ATMOSFERA PRIMORDIALE
STADIO 1 - 4.56-4.52 Ga
Mentre l'atmosfera primaria andava persa, si formava l'atmosfera primordiale secondaria: i gas erano in contatto con un fuso (o delle rocce) nei quali coesistevano ferro metallico e silicati (di ferro e magnesio). L'atmosfera secondaria era altamente riducente.
H2O K Fe CO2 Ni Fes Mg Al S O Si N2 Na SO2 HCl N Mg2SiO4 Ni S Fe C Fe2SiO4 He Ne
Eon Era
2500 Neoarchean 2800 Mesoarchean 3200 Age (Ma) Archean Paleoarchean @ 3600 Eoarchean 4030 Hadean 4560
STADIO 2 - post 4.52 Ga
ATMOSFERA POST-DIFFERENZIAZIONE
La terra si è separata in nucleo e mantello. Pertanto, i gas non si equilibrano più con il Ferro metallico, la composizione dell'atmosfera cambia e le sue condizioni diventano più ossidanti.
H2 2 O
ATMOSFERA PRIMORDIALE
E' lecito immaginare che la composizione elementare dell'atmosfera primordiale fosse uguale a quella dei gas rilasciati dai magmi. I gas vulcanici sono una combinazione di quattro elementi principali: Costituenti maggiori: -IDROGENO (H) -CARBONIO (C) -OSSIGENO (O) -ZOLFO (S) Costituenti minori: -AZOTO (N) -ALOGENI (Cl, F, Br) -GAS NOBILI (He, Ne, Ar, Kr, Xe) -METALLI IN TRACCE (Na, V, Cr, Bi, Cu, Zn, Au, etc .... ) Gli elementi si combinano a formare i seguenti composti: H: H2O, H2, CH4,NH3. C: CO2, CO, CH4. S: principalmente come SO2 e H2S O: H2O, O2, CO2, CO, SO2 ALOGENI: principalmente come acidi (HCl, HF e HBr) N: N2, NH3
CONCETTO DI FUGACITÀ
In tutte le reazioni considerate compaiono le fugacità delle varie specie gassose
0.5 K, = f H2 f f H2O O2
Frazioni Molari
Calcoliamo il rapporto tra la pressione parziale di un gas e la pressione totale
Pi = ntot Ptot ntoti n = X. Frazione Molare n tot 6 Le fugacità sono delle pressioni parziali "termodinamiche", che attraverso il coefficiente di attività y tengono conto degli scostamenti del comportamento dei gas dalla idealità.
f =yP i In un gas reale, infatti, parte delle molecole sono impegnate in interazioni inter-molecolari, e le porzioni libere di reagire sono rappresentate dalla fugacità. In un gas ideale y =1 ed f =P; Le fugacità sono legate alla pressione totale ed alle frazioni molari dei singoli gas secondo:
f = YP; = YX. P. TOT Legge di dalton
COME SI PUÒ CAPIRE QUALI SPECIE PREVALGONO?
Il rapporto di abbondanza fra due specie molecolari (e.g., H2 vs. H2O) è fissato: - dalla temperatura - dalle condizioni redox, espresse dalla fugacità di ossigeno
H,O <> H, +0.50 2 K, = f. £ 0.5 H2 02 f H2O f f LogK (n = Log H2 H2O + Logf 0.5 02 Log f H2 = LogK - 0.5Logf O2 f. H2O La costante di equilibrio è fissata una volta che la T è stabilita:
LogK = − 0 r AGº RT La fugacità di Ossigeno è pertanto il parametro che determina se prevalgono le specie ossidate o quelle ridotte
COME SI PUÒ CAPIRE QUALI SPECIE PREVALGONO?
Cosa determina quali specie molecolari prevalgono? Il rapporto di abbondanza fra due varie specie molecolari (e.g., H2 VS. H2O) è fissata: - dalla temperatura - dalle condizioni redox, espresse dalla fugacità di ossigeno
H 1 H2 + 02 = H20 log H2 H20 12707 T 7 +2548- 1 + 2.548 - - log f O2 2 C 1 CO2=C0+ =02 log CO2 co 14775 T - 4.544 + = log fO2 1 2 S H2S+ =02 = SO2 + H20 log H2S T - 3.986 + - log f O2 - log fH2O 3 2 10 Log Gas/Gas ratio 5 CO2/CO 0 - -5 H2/H2O SO2/H2S -10 @ FMQ, 1 bar -15 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 T ℃ SO2 27377
COME SI PUÒ CAPIRE QUALI SPECIE PREVALGONO?
Cosa determina quali specie molecolari prevalgono? Il rapporto di abbondanza fra due varie specie molecolari (e.g., H2 VS. H2O) è fissata: - dalla temperatura - dalle condizioni redox, espresse dalla fugacità di ossigeno
H 1 H2 + 02 = H20 log H2 H20 12707 T 7 +2.548- 1 + 2.548 - = log f 02 2 C CO2=C0+-02 log- CO2 co 14775 T - 4.544 + =log fO2 1 2 S w H2S+ =02 = SO2 + H20 2 log T - 3.986 + - log f 02 - log fH2O 3 2 10 @ 1200 °℃, 1 bar SO2/H2S Log Gas/Gas ratio 8 CO2/CO OTNONTO 6 4 -2 6 H2/H2O -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 AFMQ 1 2 SO2 27377
Consideriamo adesso le 8 specie molecolari principali. Cosa determina le loro abbondanze? Avendo 10 variabili (8 specie+PTOT+T), abbiamo bisogno di 10 equazioni indipendenti che le correlino fra loro, e che messe a sistema permettano di trovare una soluzione al problema 4 reazioni di equilibrio, ciascuna con la sua K 1)H,O <> H2 +0.50, 2)CO, <> CO+0.50, 3)SO2 + H, <> H,S+0, 4)CH +0, <> CO2+2H, 2 4 bilanci di massa per ciascun elemento 5) CTот OT=XCO2+XCHATXCO 6) OTOT =2XCO2+Xco+2X02+XH20 H20+2Xs02 7) HTOT =2XH2+4XCH4+2XH20+2XI H2S 8) STOT =XSO2+XH2S 2 vincoli esterni sul sistema 9) PTOT = 1 atm, T = 1200℃ 10) La Fugacità di ossigeno è tamponata
f 0.5 K = 1(T) f H2O 0.5 K = 2(T) f CO2 f H2S f O2 K 3(T) = f f SO2 H2 f CO2 H2 K = f 2 4(T) f f CH4 02 f. = YP = yX. P. TOT H2O, H2, CH4, CO2, CO, SO2, H2S, O2 f H2 O2 CO O2
LA FUGACITÀ DI OSSIGENO
Tutte le reazioni di equilibrio sono reazioni redox, il cui spostamento - verso destra o sinistra - è governato dalla fo2. Cosa controlla la fugacità di Ossigeno? Questa è fissata dalla presenza - nel fuso o nelle rocce magmatiche - di elementi chimici con stati di ossidazione diversi, che agiscono da tampone per la fugacità di ossigeno. Nel primo stadio, terra indifferenziata, la contemporanea presenza del ferro in 2 stati di ossidazione differenti (Fe metallico e Fe (II) nell'olivina) esercitava una azione di controllo della fugacità di ossigeno secondo la reazione:
I (Iron) Q (quartz) F (Fayalite) 2Fe + O2 +SiO2 = Fe2SiO4 log K(T) = log aFe,SiO 4 aFe . aSiO,fO. 2 L'attività a è una concentrazione termodinamica che tiene conto della non idealità delle soluzioni solide e liquide a ;= y.Xi In una fase pura X; = 1, ed in condizioni ideali y=1, e quindi a=1
H2 Mg2SiO4 Ni S Fe NH3 Fe2SiO4 He Ne 4.56-4.52 Ga
LA FUGACITA DI OSSIGENO - Atmosfera primordiale
Ne deriva che:
aFe,SiO 4 log K(T) = log aFe . aSiO,fO, 2 LogK(T) = AGº RT − r = - LogfO 2 4.56-4.52 Ga H2 Mg2SiO4 Ni S Fe NH3 Fe2SiO4 He Ne Fissata la Temperatura, ed in presenza di Fe metallico e Fayalite, la fO2 è fissata, ovvero tamponata dalla presenza del ferro in due stati di ossidazione differenti:
QFI -13 log fO2 1000 1200 1400 T 2Fe + O2 +SiO2 = Fe2SiO4 Questo tampone della fO2 prende il nome di QFI (quartz-fayalite-iron)
Risolvendo il sistema nell'Atmosfera primordiale
Composizione dell'atmosfera primordiale: H2O, H2, CH4, CO2, CO, SO2, H2S, O2 4 reazioni di equilibrio, ciascuna con la sua K 1)H,O <> H2 +0.50, 2)CO, <> CO+0.50, 3)SO, + H2<>H,S+0 2 4)CH +0,<>CO2+2H, 4 bilanci di massa per ciascun elemento 5) CTOT =XCO2+XCHATXCO 6) OTOT =2XCO2+XCO+X02+XH20 H20+2X502 7) HTOT =2XH2+4XCH4+2XH20+2XL H2S 8) STOT -XS02+XH2S 2 vincoli esterni sul sistema 9) PTOT = 1 atm, T = 1200℃ 10) Fugacità di ossigeno = 10-13
f. f H2- O2 K = 1(T) f H2O 0.5 K 2(T) f CO2 f H2S f O2 K = 3(T) f f SO2 H2 f f 2 K = CO2 H2 4(T) f f CH4 02 f. = YP = yX. P. TOT 0.5 CO O2 =
COME SI PUÒ CAPIRE QUALI SPECIE PREVALGONO?
Cosa determina quali specie molecolari prevalgono? Il rapporto di abbondanza fra due varie specie molecolari (e.g., H2 VS. H2O) è fissata: - dalla temperatura - dalle condizioni redox, espresse dalla fugacità di ossigeno
H 1 H2 + 02 = H20 12707 + 2.548 1 log fO2 2 C CO2=C0+-02 log - CO2 co 14775 T 1 - 4.544 + =log fO2 2 S w H2S+ =02 = SO2 + H20 2 SO2 27377 T - 3.986 + - log f 02 - log fH2O 3 2 10 @ 1200 °℃, 1 bar SO2/H2S Log Gas/Gas ratio DOT NON Y 8 6 4 -2 6 CO2/CO H2/H2O -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 AFMQ 1 2 log H2 H20 log H2S T 9) PTOT = 1 atm, T = 1200℃ 10) Fugacità di ossigeno = 10-13
Risolvendo il sistema nell'Atmosfera primordiale
Composizione dell'atmosfera primordiale: H2O, H2, CH4, CO2, CO, SO2, H2S, O2
QFI H2 2 0.64 H2O 0.3 CO 0.05 CO2 0.0097 H2S 0.0014 2 SO2 10-7 CH4 4 10-7 O2 2 10-13 L'atmosfera primordiale era estremamente ridotta. Dominavano H2, CO, H2S, NH3
H2 Mg2SiO4 Ni NH3 S Fe Fe2SiO4 CO H2S NH3 + 1.502 -> N2 + 3H20 4.56-4.52 Ga Perso per impatto: La LUNA
LA FUGACITA DI OSSIGENO - Atmosfera post-differenziazione
La Terra si è separata in mantello e nucleo. Il Feº non è più in contatto con l'atmosfera, ed il buffer QFI non è più attivo. Entra però in funzione il buffer QFM, che regola la fO2 dei basalti attuali:
F (Fayalite) M (Magnetite) Q (quartz) 3Fe2SiO4+ O2 = 2Fe3O4+3SiO2 Questa reazione (buffer quartz-fayalite-magnetite, QFM) tampona la fO2 poiché il ferro è ancora presente in due diversi stati di ossidazione (2) e (2.5). La magnetite si può infatti scrivere come:
H2O O K Fe CO2 Ni Fes Mg Al Si O S N2 Na Ne SO2 HCl post-4.52 Ga Fe3O4-> FemO + Fe2(03 In maniera analoga a quanto fatto per il buffer QFI, si può scrivere la costante di equilibrio:
log K(T) = log a'SiO, . a2Fe, O a3Fe, SiO4 .fO 4
LA FUGACITA DI OSSIGENO - Atmosfera post-differenziazione
3Fe SiO4+ O2 = 2Fe304+3SiO2
log K(T) = log a'SiO, . a2Fe, O 4 a'Fe, SiO. . fO, LogK(T) = − AGº RT r =- LogfO, 2
+ QFM -8 log fO2 QFI -13 -17 1000 1200 1400 T
H2O O K Fe CO2 Ni Fes Mg Al Si O S N2 Na Ne SO2 HCl post-4.52 Ga Alla stessa temperatura (1200°℃), la fO2 aumenta di 4 ordini di grandezza (rispetto a QFI) quando tamponata da QFM. Di conseguenza l'atmosfera diventa più ossidante.