Appunti di Biologia: Insufficienza Cardiaca e Ipertensione
Documento di Biologia sull'insufficienza cardiaca e l'ipertensione. Il Pdf, utile per l'Università, copre epidemiologia, fattori di rischio e stadiazione, includendo anomalie strutturali del cuore e cardiomiopatie, con spiegazioni sui farmaci.
See more52 Pages
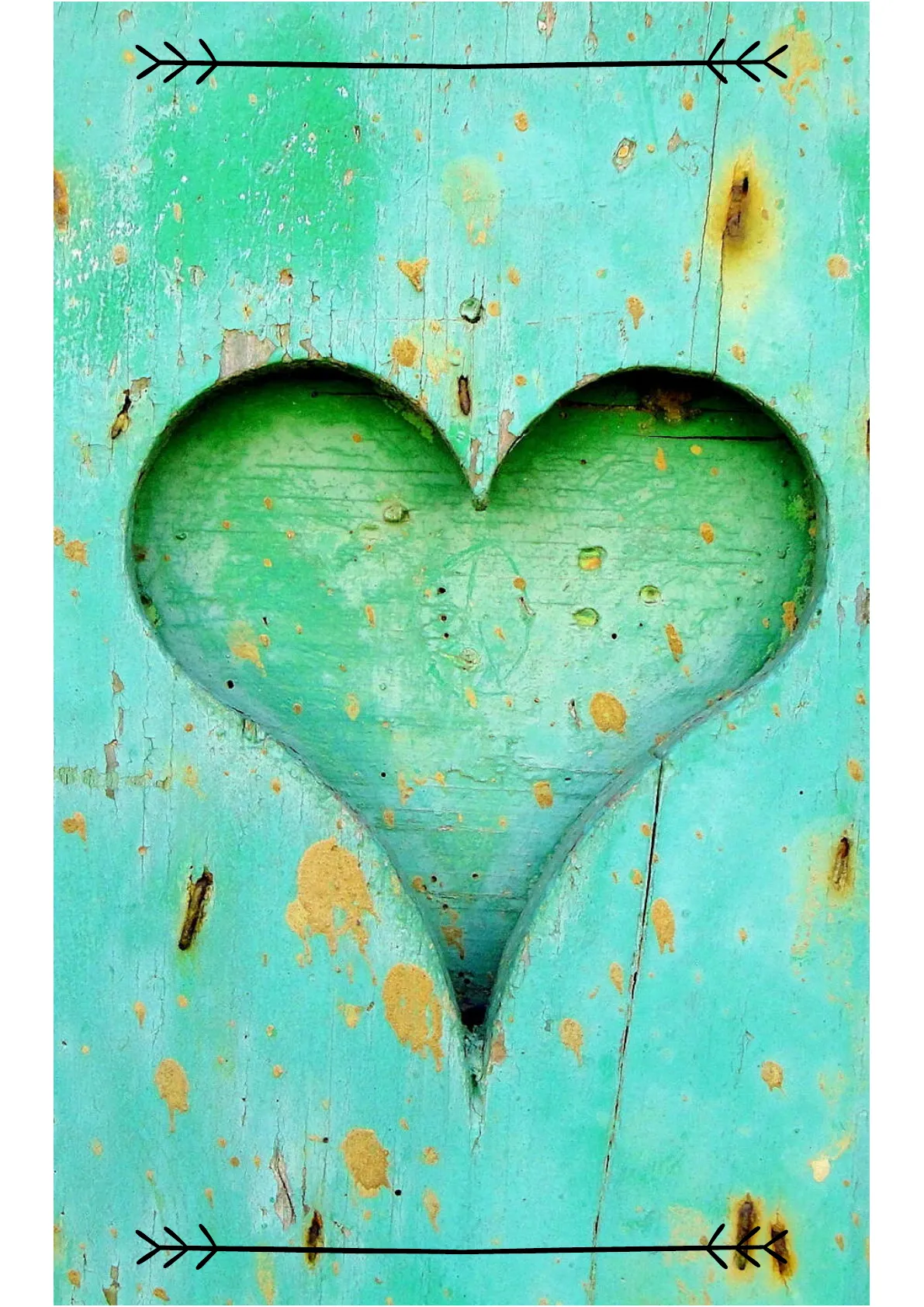

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Plico a cura di
Alessia Riccio Michele Notarangelo.
Cardio 1
Lezioni anno 2020 integrate con il vecchio plico
A cura di: Alessia Riccio Michele Notarangelo
Antiaritmici
02/03/2020
Classificazione Vaughan - Williams
Classe I: bloccano i canali Na+, in particolare Nav1.5
- a: chinidina, bloccante ad alta affinità di alcuni canali del potassio; procainamide, ajmalina, disopiramide;
- b: fenitoina, lidocaina, mexiletina > blocco rapido;
- c: flecainide, encainide, pilsicainide, propafenone;
La differenza tra questi farmaci è il tempo di blocco del canale: per la classe b è un tempo brevissimo, per la classe c è lento (>10 sec) e per la classe a è intermedio. Classe II: beta bloccanti:
- cardio-selettivi
- non cardio-selettivi
Classe III: agiscono nei confronti dei canali del potassio, a questa classe appartiene l'amiodarone, detto anche cordarone, utilizzato per la fibrillazione atriale, ma presenta numerosi effetti avversi, quindi il dosaggio deve essere al di sotto di 400 mg/die. Farmaco simile è il dronedarone, che presenta più effetti avversi quindi l'amiodarone è il farmaco principe di questa classe. Inoltre, di questa classe fa parte anche il sotalolo, ibutilide (ev) e dofetilide (os). Classe IV: calcio antagonisti, bloccano selettivamente i canali L del calcio. Sono il verapamil e il diltiazem, farmaci utili nel rallentare la conduzione tra nodo del seno e nodo atrio ventricolare. Il magnesio, l'adenosina, la digossina, che sono antiaritmici, non compaiono in questa classificazione. Per ovviare a ciò negli anni '90 è stato introdotto il Sicilian Gambit, in cui i farmaci sono suddivisi in base alle patologie per cui vengono usati, ma questa classificazione non viene utilizzata spesso.
Fisiologia cardiaca
L'impulso nasce dal nodo seno atriale, in cui origina la corrente If (funny) in cui si trova il canale HCN4, importante per la SSS (Sick Synus Syndrome). Oltre alla corrente funny c'è anche quella IkAch, regolata dai recettori M2 (Gi) dell'acetilcolina. Il nervo vago infatti rallenta la frequenza cardiaca, per questo molti anziani non possono assumere i digitalici, perché questi rallentano di molto la frequenza cardiaca. Il recettore muscarinico non è l'unico che modula questa corrente. L'impulso parte dal nodo del seno e la conduzione è anisotropica, le caratteristiche del potenziale d'azione cardiaco lungo la conduzione cambiano a seconda dell'orientamento delle fibre. Dal nodo seno atriale si arriva al nodo atrio ventricolare, filtro in cui la velocità di conduzione diventa da 0,02 a 0,04 m/s. dal nodo atrio ventricolare si passa al fascio di His fino alle cellule del Purkinje, in cui la conduzione diventa di 2-4 m/s. Distinguiamo:
- Disturbi dell'automatismo;
- Trigger activity: il disturbo della generazione dell'impulso non è spontaneo ma dipende da qualcosa, ad esempio il giocatore di calcio che muore in partita per aritmia fatale;
- Disturbi della propagazione dell'impulso: rientri, sono cortocircuiti che si creano, come la fibrillazione atriale.
SCD
La morte cardiaca improvvisa indica che il soggetto muore poche ore entro l'evento cardiaco vascolare. In America i casi sono 250.000/300.000/anno. Colpisce principalmente i soggetti >45 anni a causa di scompenso cardiaco, mentre nei soggetti più giovani è dovuta principalmente alle cardiomiopatie e alle canalomiopatie cardiache, responsabili del 30% dei casi di morte improvvisa in giovane età.
Canalopatie cardiache
- LOTS (sindromi del QT lungo): sono circa 17 sindromi più le patologie che fenocopiano le condizioni genetiche. Il QT che si allunga fa parte del profilo di sicurezza dei farmaci.
- SQTS (sindromi del QT corto): sono meno numerose e frequenti.
- Sindrome di Brugada: responsabile del 20% delle SCD non associate a difetti strutturali, si riscontrano 13/14 mutazioni genetiche alla base, è una sindrome strana e quasi sconosciuta negli USA, mentre in Italia ha una prevalenza che può arrivare anche a 5 su 10.000, in Asia 12 su 10.000 e in USA 12 su 100.000.
- Tachicardia polimorfica ventricolare catecolaminergica (CPVT).
Potenziale d'azione cardiaco
1 2 0 3 Fase 0: depolarizzazione cardiaca, si aprono i canali del sodio voltaggio dipendenti, il sodio entra e la cellula si depolarizza. La corrente del sodio è la Nav1.5 e il canale del sodio associato è il SCN5A. La subunità principale del canale è quella alfa, ma esistono anche delle sub. Beta. Se ci sono mutazioni con acquisto di funzione, si hanno sindrome del QT lungo, al contrario, se il canale del sodio è meno attivo, si ha la sindrome di Brugada. Se il canale è mutato, si può avere anche un'altra sindrome di alterazione della struttura del cuore, la sindrome di Lev-Lenegre. Fase 1: ripolarizzazione, dovuta ai canali del potassio voltaggio- dipendenti, dominata da due correnti: corrente Ito e corrente Ikur (canale del potassio ultrarapido). La prima ha un ruolo fondamentale nella sindrome di Brugada, è molto rappresentata nell'epicardio ma meno nel subendocardio, quindi alterazioni dei geni sono tra le cause genetiche della sindrome di Brugada. Fase 2: fase di plateau, la cellula non si ripolarizza più anche se i canali del potassio sono aperti, perché si attivano i canali del calcio di tipo L con la corrente Cav1.2 (alfa1C). Fase 3: ripolarizzazione, i canali del calcio si sono inattivati, le correnti attive sono la Ikr e la Iks. La Ikr è mediata dai canali hERG, canale simile al canale della Drosophila Melanogaster. Fase 4: prepara il nuovo potenziale d'azione. Entrano in gioco in questa fase i canali Kir. Ek = -= In- ZF RT [K]ex [K]in
Correnti in fase 4
Le correnti in fase 4 sono:
- corrente IK1 (Kir2.1);
- IKAch: attivato dai recettori M2 muscarinici. Allo stesso modo si comportano anche i recettori A1 (Gi) dell'adenosina (ev), che riduce la frq e la velocità di conduzione tra atrio e ventricolo. Anche i recettori SST2 della somatostatina hanno la stessa azione: la somatostatina è un peptide prodotto dall'ipotalamo che serve a ridurre la produzione di GH da parte dell'ipofisi, viene prodotto anche dall'apparato gastro- intestinale e ha un'azione anche sui recettori SST2 causando riduzione della frq cardiaca e della conduzione atrioventricolare. Inoltre, anche i recettori S1P1R della sfingosina hanno la stessa azione, il recettore si trova nel cuore e viene attivato dal fingolimod (GYLENIA), usato anche nella sclerosi multipla per os, con effetto avverso bradicardia, che ne fa sospendere l'assunzione. Se si è certi che la bradicardia è transitoria la terapia può essere portata avanti perché il recettore si desensibilizza;
- IKATP: canali presenti nel cuore e anche nelle cellule beta del pancreas, questi sono diversi > Kir6.1 (KCNJ8) e SUR2A (ABCC9) nel cuore e SUR1 nel pancreas. L'ATP può bloccare questi canali. In ischemia c'è diminuzione ATP, questi canali si attivano e c'è iperpolarizzazione della membrana: è protettivo nei confronti della fibrillazione ventricolare.
LOTS
È aumentato il QT corretto:
- > 500 ms > terapia aggressiva con defibrillatore impiantabile, non bastano i beta bloccanti;
- 440-480 ms -> si utilizzano i beta bloccanti ma bisogna monitorare il paziente;
- < 340 ms > QT corto > rara, ma aggressiva e pericolosa in cui il defibrillatore impiantabile è d'obbligo;
QT corretto
cQT = VR-RI QT (formula di Bazett) Bisogna normalizzare il QT per i soggetti bradicardici. Se si considera il potenziale d'azione, nella fase 2 e 3 ci si trova nel periodo refrattario, dovuto all'inattivazione dei canali per il calcio e per il sodio. Se questo tempo è allungato, i canali recuperano la capacità di depolarizzazione e qualsiasi stimolo che attivi i canali del calcio può dare origine ad un nuovo potenziale che avviene in fase 3 e prende il nome di EAD (early after depolarization). Il periodo refrattario si divide in assoluto, relativo ed effettivo:
- Assoluto: nessuno stimolo può generare potenziale d'azione;
- Effettivo: stimolo determina potenziale d'azione che però non viene propagato;
- Relativo: alcuni stimoli importanti possono generare un potenziale d'azione anticipato. Periodo relativo è a cavallo tra fase 3 e 4.
In questa situazione si può avere una VT con manifestazioni che prendono il nome di torsioni di punta, manifestazioni polimorfe del QRS in cui varia beat by beat (battito dopo battito) e oscilla intorno alla linea mediana. L'esito delle torsioni di punta è la fibrillazione ventricolare, che può portare a morte. Se i potenziali nascono più tardivamente si possono avere depolarizzazioni tardive - DAD, tipiche delle aritmie da intossicazioni da digitalici, che si hanno all'inizio della fase 4.
Farmaci che allungano il QT
L'effetto di questi farmaci è dose dipendente.
- Antidepressivi: citalopram (SSRI), il dosaggio standard è di 40 mg/die; a dosaggio di 20 mg/die il QT aumenta di circa 7,5 ms; a 60 mg/die si hanno più di 17 ms di allungamento del QTc. Tra i più pericolosi abbiamo i TCA, farmaci leaders del mercato in termini di efficacia. Con questi farmaci ci sono stati casi di morte improvvisa nei bambini che venivano curati per enuresi notturna.
- Antipsicotici: effetto avverso di classe di tutti i farmaci nel trattamento della schizofrenia. Quelli che allungano di più il QT sono i farmaci di 1° generazione, come la Levomepromazina (Nozinan), la Tioridazina (Melleril), l'Aloperidolo. Tra quelli di 2° generazione abbiamo il Risperidone e lo Ziprazidone.
- Anche il Metadone, oppioide, allunga il QT.
- Sunitinib
- Farmaci antiemetici: Domperidone, Ondansetrone (Zoopran), usato nel vomito da chemioterapici
- Farmaci antiaritmici: Chinidina, bloccante del canale del sodio, ma blocca anche i canali R con più affinità, per questo viene usata nelle sindromi da QT corto. Altri farmaci sono Amiodarone, Dronedarone, Sotalolo, etc.
Altri fattori che allungano il QT
- Bradicardia
- Ipotiroidismo
- Ipocalemia
- Ipomagnesemia
Sindromi genetiche
> Le sindromi che allungano il QT riguardano sempre mutazioni con perdita di funzione dei canali del potassio o mutazioni con aumento di funzione dei canali del sodio e del calcio
- LOTS1: sindrome che dipende da mutazioni con perdita di funzione del canale del potassio responsabile della corrente Iks (in fase 3). Il gene che codifica per il canale è il gene KCNQ1, che codifica per il canale Kv7.1 bQTV1. Riguarda il 40-50% dei casi di allungamento del QT, è di tipo autosomica dominante, può essere dovuta al fatto che il canale non si attiva in maniera corretta oppure non viene espresso in membrana in maniera corretta. È una patologia sempre da sforzo, l'adrenalina rilasciata attiva i recettori beta1 del cuore, accoppiati a proteina Gs, si forma cAMP che attiva la PKA che da una parte attiva i canali L del calcio, dall'altra attiva il canale del potassio responsabile della corrente Iks. Quindi in una situazione fisiologica non si ha l'allungamento del QT perché la PKA attiva la Iks, ma se il gene KCNQ1 è mutato, non si ha più l'attivazione del canale del potassio. A questo punto i recettori beta1 non attivano la Iks ma attivano solo i canali del calcio di tipo L. In terapia si usano in prima linea i beta- bloccanti, proprio perché viene fuori sotto sforzo. Viene utilizzato in terapia il Nadololo. Se la situazione è critica, allora si impianta il defibrillatore.
- LOTS2: mutazione LOF del canale hERG responsabile della corrente Ikr, codificato dal gene KCNH2, canale Kv11.1 outward r. Rappresenta il 30-35% dei casi, lo stimolo di solito è di natura emozionale oppure stimoli acustici molto forti, a differenza di quella di tipo 1 dove lo stimolo era lo sforzo. Per la terapia i beta-bloccanti sono meno utili rispetto a quella di tipo 1, anche in questo caso la cura più efficace è il defibrillatore impiantabile.