Le tecnologie educative: interazione cognitiva e competenza digitale
Documento dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro su Le Tecnologie Educative. Il Pdf esplora l'interazione cognitiva per l'apprendimento, i modelli di competenza digitale e il pensiero computazionale, con focus su informatica e pedagogia per la scuola primaria e dell'infanzia.
See more60 Pages
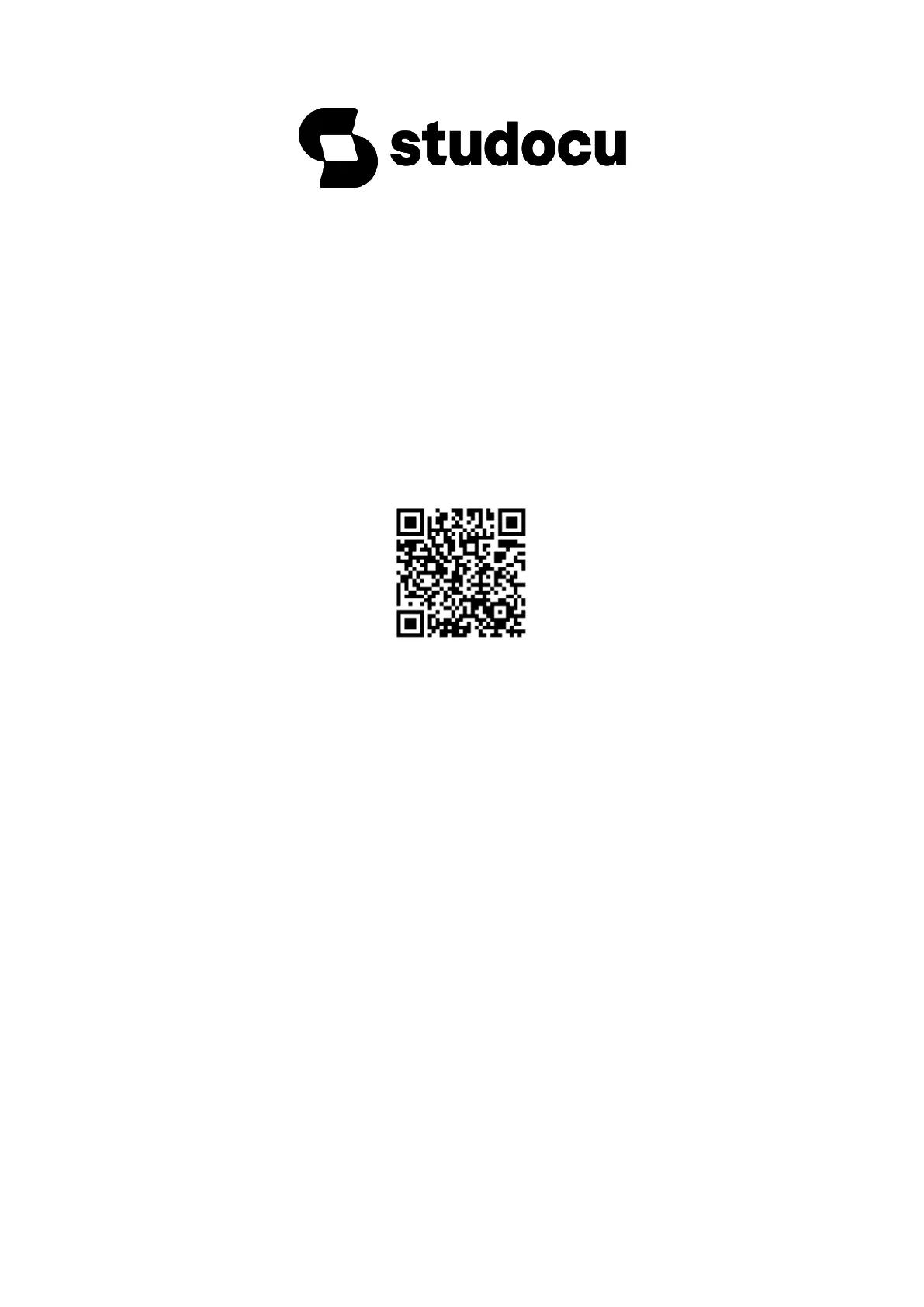
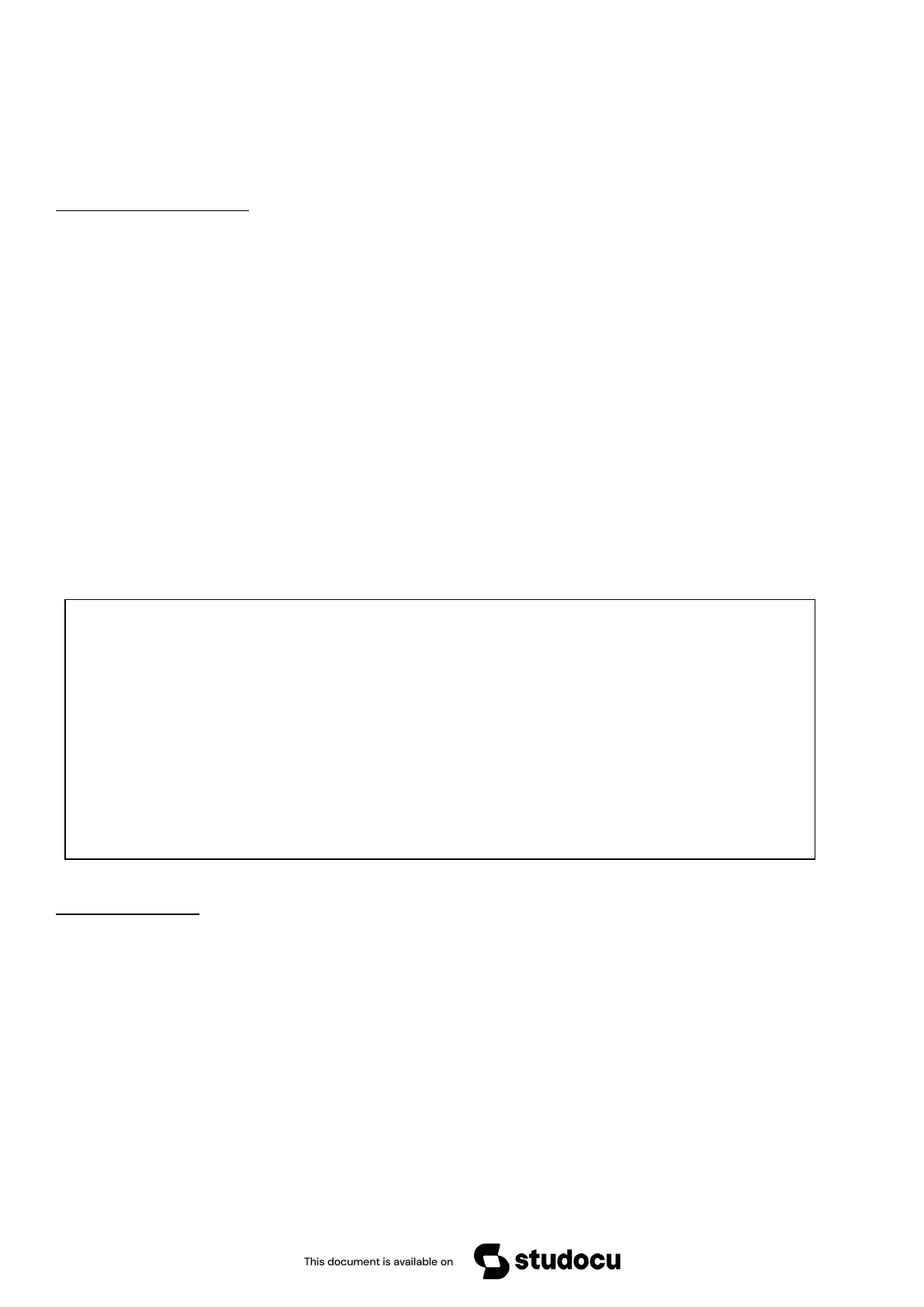
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Le Tecnologie Educative
Laboratorio di Tecnologie Didattiche Per Le Difficoltà di Apprendimento Nella Scuola
Primaria e Nella Scuola Dell'infanzia (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Scansiona per aprire su Studocu
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Elena Galvagno (elenagalvagno203@gmail.com)Le tecnologie educative
Mente e media: interazione cognitiva per apprendere
Simbiosi uomo-tecnologia
La storia dell'uomo può essere rappresentata come un processo di evoluzione protesica; per sopperire alle sue carenze
l'uomo ha allestito strumenti atti a potenziare la sua capacità di controllare l'ambiente circostante. Ha creato così
amplificatori culturali, come li chiama Bruner, sul piano motorio(leve, coltelli, ruote, auto, aerei), sensoriale e
comunicativo (segnali di fumo, suoni, telefoni, radar), cognitivo e culturale (linguaggi, schemi, teorie, modelli
scientifici).
Dall'inizio del nuovo millennio questa straordinaria proliferazione protesica ha coinvolto sempre più la dimensione
comunicativa e conoscitiva.
Basta osservare le persone per strada o in treno per notare quanto frequentemente la loro esistenza sia trasferita in
una dimensione virtuale: essa si svolge ormai in alternanza tra un real world e un e-world immanente a quello fisico,
con continue trasposizioni dall'uno all'altro.
L'"essere connessi" dà origine a una condizione antropologica radicalmente nuova, imprevedibile negli esiti.
Educatori, insegnanti e gli stessi genitori sono investiti di un carico di responsabilità inedito, quello di comprendere la
rilevanza di questo cambiamento e orientarne le dinamiche, indirizzandole verso possibili arricchimenti della
personalità, salvaguardando autonomia di giudizio e senso della realtà, ed evitando o riducendo i possibili esiti
negativi, che pur si profilano all'orizzonte.
Metafore
Indossare gli occhiali
- se li teniamo senza renderci conto di portarli, vuol dire che il dispositivo è diventato tutt'uno con
il nostro corpo, si è generata una simbiosi; - se percepiamo di portarli, vuol
dire che questa simbiosi non funziona più bene, che magari la
lente è sporca e l'occhiale è rotto.
Guidare un'automobile:
- il principiante prima di cominciare a guidare si concentra mentalmente sui comandi di guida,
sino al momento in cui questi movimenti diventano automatici (Interiorizzazione)
Ciò fa capire l'interfacciamento uomo-tecnologia è oggetto di educazione.
Media e interfacce
Possiamo usare il termine medium per identificare i nuovi dispositivi tecnologici digitali, facendo tuttavia presente che
il termine non è più identificabile con "mezzo di comunicazione", definizione tipica dei dizionari tradizionali; in senso
lato un medium va considerato una qualunque interfaccia coadiuvata da un supporto tecnologico che consenta
produzione, manipolazione e negoziazione di simboli, significati, identità e spazi virtuali.
Il concetto di interfaccia è centrale per la comprensione dei nuovi dispositivi e delle dinamiche che vi hanno luogo.
Un'interfaccia è una superficie di contatto, il luogo in cui due sistemi o due ordini di realtà si incontrano e comunicano'.
Nell'interfacciamento uomo-dispositivo si possono attuare dinamiche emozionali, identitarie, interpersonali e
cognitive, con esiti e significati di varia natura sul piano psicologico ed educativo.
Ci soffermiamo qui sulla dimensione cognitiva che più direttamente riguarda gli apprendimenti in età e ambiente
scolastico e le motivazioni che possono presiedere alla scelta di inserire le tecnologie nella scuola.
This document is available on
studocu
Scaricato da Elena Galvagno (elenagalvagno203@gmail.com)
- Tecnologia cognitiva = si occupa dei rapporti che si vengono a instaurare tra esseri umani e dispositivi
tecnologici; - Ergonomia = disciplina tesa a migliorare le condizioni d'uso dei soggetti che impiegano le tecnologie e l'insieme
delle prestazioni del sistema integrato; - Ergonomia cognitiva = si occupa di progettare le interfacce tecnologiche e della loro usabilità;
- Psicotecnologia = studi gli effetti dei media sulla mente;
- Ecologia cognitiva = studia le integrazioni tra collettivi umani e costruzione di conoscenza;
- Ergonomia didattica = studia le dinamiche e le possibilità che si generano nel rapporto mente-medium a scopo
di apprendimento.
Effetti delle tecnologie cognitive sulla mente
Chi si occupa di educazione si chiede come la scuola possa favorire personalità autonome, creative, responsabili. I
fautori dell'introduzione delle tecnologie nella scuola tendono in genere a pensare che queste finalità siano in piena
congruenza con il loro uso, anzi, che questo stesso faciliti il loro conseguimento. Dati recenti spingono però a dubitare
di questa naturale congenialità.
In un'ottica più individuale gli effetti possono verificarsi sotto forme di interiorizzazione(introiezione nella mente di
comportamenti che si attuano con la strumentazione esterna), o di semplice condizionamento o radicamento di
pratiche abitudinarie che le tecnologie tendono a favorire.
In generale, quando mente e tecnologia si integrano, si origina un sistema che globalmente considerato è più efficiente
rispetto alle prestazioni che può conseguire il soggetto da solo; nella mente si produce una estroflessione, cioè la
mente trasferisce il carico sul supporto tecnologico e contestualmente disabilità le corrispondenti funzioni cognitive
interne (come osservava Platone, praticando la scrittura si disabilita la memoria).
Metafora della scrittura di Platone
Platone riporta, nel Fedro, il mito egiziano del dio Theuth, che recandosi dal re Thamus presenta la scrittura come uno
strumento capace di fare gli uomini più sapienti e più capaci di ricordare. Il re afferma che la diffusione della scrittura
otterrà l'effetto contrario rispetto a quello auspicato, cioè l'indebolimento della memoria. Platone muove alla scrittura
critiche per certi aspetti simili a quelle che vengono oggi avanzate all'utilizzo delle calcolatrici nella scuola primaria,
quanto ostacola 'interiorizzazione delle procedure di calcolo (estroflessione).
Nel tempo lungo Platone vedeva con preoccupazione la scrittura come un fattore di indebolimento della memoria.
Aveva in parte ragione ma non poteva prevedere che la rilettura del testo scritto avrebbe aperto nuovi spazi alla
mente, favorendo la nascita di nuove discipline come la grammatica, la filosofia, la retorica ecc. fondamentale per lo
sviluppo del pensiero scientifico.
Le osservazioni di Platone rappresentano le prime considerazioni di ergonomia cognitiva e mettono in luce il
bilanciamento che si crea tra mente-medium evidenziando sia un potenziamento sia un depotenziamento delle facoltà
umane.
In effetti oggi sappiamo che il cervello ha maggiori margini di plasticità rispetto a quanto si riteneva in passato e che gli
effetti di azioni ripetute sulla mente si possono apprezzare anche in tempi brevi.
Prensky ha sostenuto che i nativi digitali, cioè i giovani nati immersi nel mondo digitale, svilupperebbero tratti cognitivi
caratterizzati da maggiore velocità, flessibilità e pensiero multitasking; essi sarebbero in breve in grado di un migliore
adattamento al mondo moderno che richiederebbe tali caratteristiche. In seguito, una crescente quantità di indagini
empiriche ha smentito questa ottimistica concezione riconoscendone l'ingenuità e lo stesso autore è tornato
sull'argomento, rivedendo la sua posizione e ammettendo che per mezzo delle tecnologie si possono sviluppare anche
comportamenti di segno negativo.
Scaricato da Elena Galvagno (elenagalvagno203@gmail.com)
L'aumento del consumo dei nuovi media digitali riduce sensibilmente e progressivamente la durata dell'attenzione e un
eccesso di stimolazioni ricevuto nei primissimi anni sembra accompagnarsi a una diminuzione delle capacità relazionali
delle nuove generazioni. I nuovi media sollevano infine preoccupazioni in ambito psicologico a causa dello
spostamento massiccio delle attività dei giovani dalla realtà fisica al mondo della virtualità (social network, chatting,
intrattenimenti immersivi 3D), con tendenziali comportamenti di dipendenza non dissimili dall'uso di droga (addiction);
nei preadolescenti e adolescenti le ansie più comuni sono ormai quelle legate alla paura di perdere il contatto; la
dipendenza dalla rete si esprime non solo nel bisogno di stare collegati, ma anche attraverso le frustrazioni e i timori
legati al rapporto con gli altri, di essere mal giudicati, di non essere più considerati dalla comunità, il non capire perché
non si è più al centro dell'attenzione del gruppo virtuale.
Interazione e interattività
Forme di transazione più o meno intense vincolano uomini tra loro, uomini e artefatti, artefatti tra loro. In certi casi
esse assumono il carattere dell'interazione, in altri dell'interattività. L'interazione è la forma più generale e rimane il
termine specifico relativo agli scambi tra esseri umani. Per interattività si intende invece una forma di interazione di cui
alcuni dispositivi automatici che reagiscono a determinati stimoli (umani o meccanici) possono disporre. Distinguiamo
due modalità fondamentali della comunicazione umana, diretta e mediata.
La comunicazione diretta (o faccia a faccia, F2F). Presenta la caratteristica fondamentale di essere vincolata nello
spazio e nel tempo: bisogna essere nello stesso posto nello stesso istante, è dunque immanente e irripetibile.
L'interazione coinvolta in tale comunicazione è normalmente complessa: ne fanno parte anche elementi aggiuntivi
rispetto al contenuto linguistico parlato, aspetti paraverbali o extraverbali, come gesti, espressioni, posture, movimenti,
intonazioni, impronte, odori, tutti fattori che concorrono alla condivisione dei significati e al conseguimento di
eventuali accordi e decisioni.
La comunicazione mediata. Riguarda le interazioni interpersonali che sono in qualche modo filtrate da un medium,
come scrittura, telefono, televisione, rete telematica. La caratterizza il fatto di essere svincolata dall'obbligo della
compresenza spaziale (non occorre essere nello stesso posto) e, in qualche caso, anche di quella temporale.
Interattività uomo-macchina
L'avvento delle tecnologie digitali ha aperto la strada a nuove modalità conversazionali che coinvolgono il rapporto tra
uomo e macchina. In questo contesto si incontra il termine interattività, che deve la sua particolare fortuna all'avvento
del computer, il quale, a differenza degli altri media, suole appunto essere definito interattivo: l'interattività si
concretizza nel feedback (informazione di ritorno) che un computer può fornire alle azioni di un soggetto o di un altro
computer, generando una condizione nuova.
L'interattività non è però un concetto univoco, è piuttosto da considerare un continuum sul quale possiamo
convenzionalmente fissare alcune soglie con significative differenze sul piano educativo. A questo riguardo è utile un
riferimento che viene da Norman, il quale distingue due poli principali della cognizione, esperienziale e riflessiva, a
seconda di quanto essa sia più o meno vincolata all'azione; nella cognizione esperienziale, cioè a interattività più
intensa, si è presi nella situazione, immersi nel contesto, è la percezione istantanea che agisce e decide. Nella
cognizione riflessiva, invece, ci si distacca dal coinvolgimento diretto attraverso forme di speculazione decantata: la
mente ha tempo e spazio per riflettere ed elaborare intorno alle diverse possibilità. Se ne può dedurre, dunque, un
rapporto tendenzialmente inverso tra interattività e riflessività; alta interattività può significare azzeramento quasi degli
spazi per la riflessività. Le situazioni di massima interattività si hanno in casi come quelli del pilota da corsa o
dell'utilizzatore di un videogioco del genere "spara e fuggi"; qui le reazioni sono per lo più automatiche e rimane
pochissimo spazio per la riflessione.
Ma che cosa succede quando un soggetto scrive al computer o usa ambienti di lavoro aperti per mezzo delle comuni
funzioni di editing, quali programmi di scrittura, grafica, authoring musicale? In questi casi il computer non fornisce un
feedback immediato - come può accadere in un videogioco di ritmo veloce -, bensì "coadiuva" le scelte dell'autore,
restituendo testo, immagine, suono come in gran parte auspicato dall'autore stesso. Tra uomo e computer si instaura
This document is available on
studocu
Scaricato da Elena Galvagno (elenagalvagno203@gmail.com)