Ecclesiologia: Chiesa locale e universale, Concilio Vaticano II, Issr
Documento da Issr su Ecclesiologia. Il Pdf esplora il concetto di Chiesa locale e universale, analizzando il cambiamento di prospettiva introdotto dal Concilio Vaticano II. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Religione, discute le conseguenze di una visione universalista e la riscoperta della radice eucaristica della Chiesa.
See more8 Pages
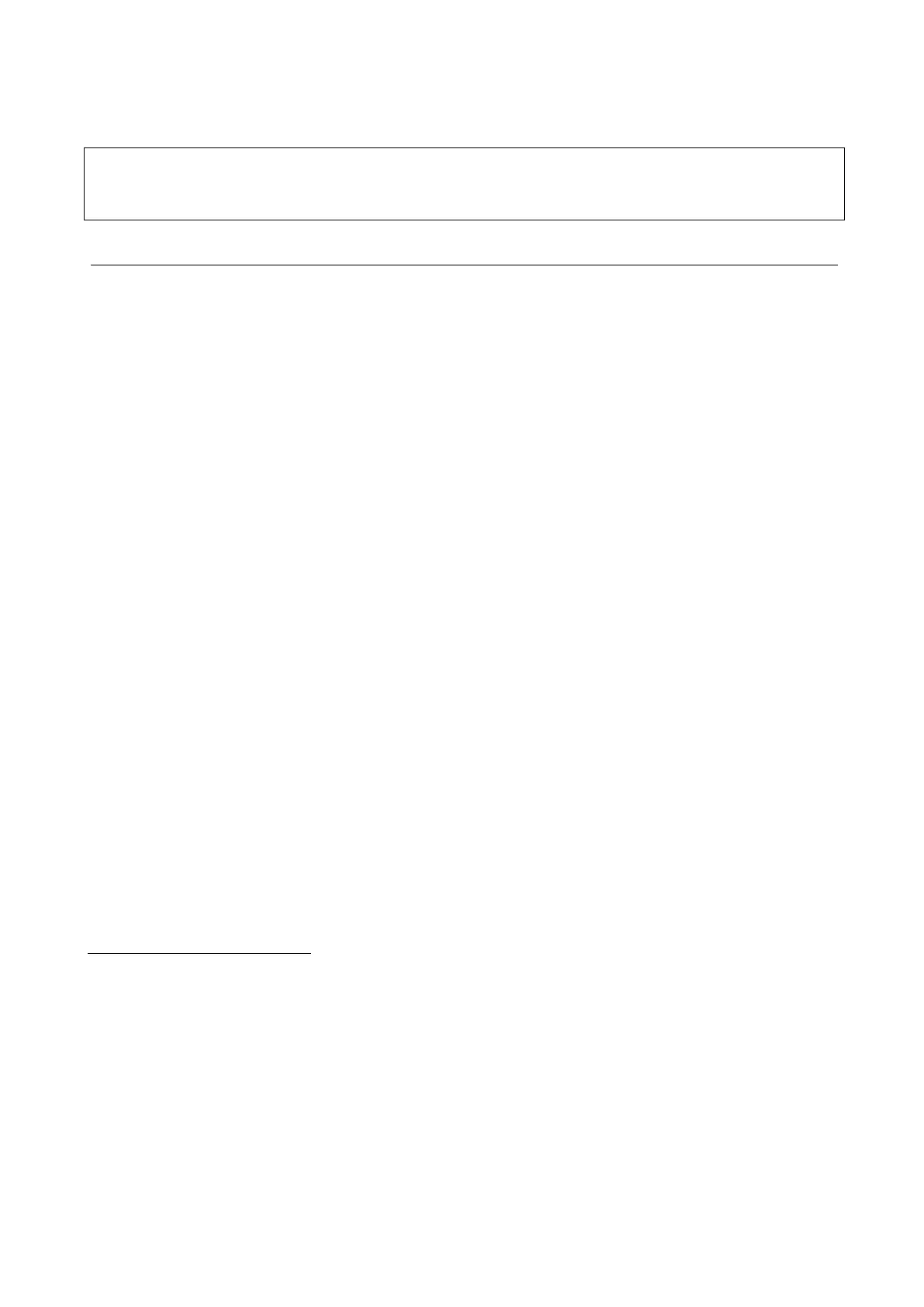
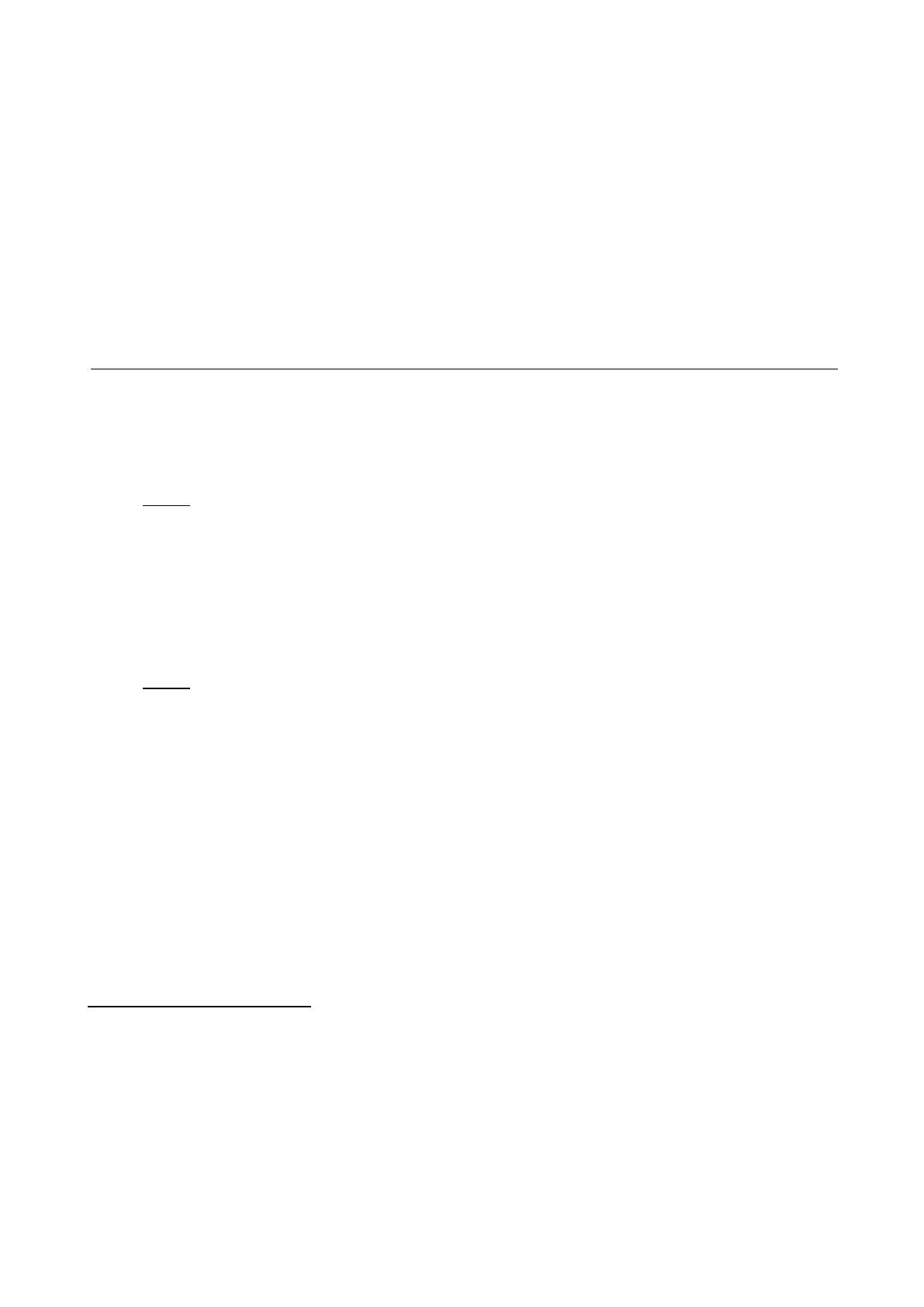
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
ECCLESIOLOGIA ISSR 2023-2024
Chiesa locale e Chiesa universale
- E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio, 441-485
- S. PIÉ-NINOT, Ecclesiologia, 351-390
- G. ROUTHIER, Il Concilio Vaticano II, 87-100
UN CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA
Il Concilio vorrebbe che noi fossimo convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri (SC 41).
Se questa visione ci appare insolita è perché probabilmente in noi è ancora presente la visione tipica del II millennio, l'ecclesiologia societaria e universalista, che tende a considerare la Chiesa quasi come un'unica società/regno in cui il Papa si serve di amministratori/funzionari locali (vescovi) per governare le singole province (diocesi)1.
Conseguenze della visione societaria
Tra le conseguenze di questa visione:
- Perdita di valore della Chiesa locale, ben evidente nel I millennio (cfr. varietà liturgica)
- Esaltazione unilaterale del ministero papale, con conseguente ...
- Perdita di valore della collegialità episcopale e ...
- Incomprensione del carattere sacramentale dell'episcopato2.
Autocomprensione della Chiesa nel Vaticano II
Il Vaticano II imposta una diversa autocomprensione della Chiesa, con una "scoperta" progressiva della questione:
- dalla radice sacramentale/eucaristica (SC)3,
- alle questioni ecclesiologiche (LG),
- alle ricadute sulla soggettualità delle singole chiese, soprattutto in terra di missione (AG).
In questi tre aspetti emergono "a valle" quelli che erano stati, "a monte", altrettanti affluenti di una teologia della chiesa locale:
- La riscoperta della radice eucaristica della Chiesa, grazie al movimento liturgico e all'attenzione ecumenica verso alcuni autori ortodossi (N. Afanassiev).
- La riaffermazione delle dottrine della sacramentalità dell'episcopato e della collegialità
episcopale:
- Il movimento liturgico insisteva a presentare i testi antichi da cui appariva con chiarezza che l'episcopato è la pienezza del sacramento dell'ordine, non un potere giuridico/ecclesiastico aggiunto al presbiterato (-> LG 21 dove, con una certa ambiguità si afferma che il vescovo riceve i tria munera - santificare, 1 Questa, tra l'altro, era stata l'interpretazione (scorretta) del Vaticano I da parte delle autorità laiche, allarmate dal fatto che «la giurisdizione episcopale è assorbita dalla giurisdizione papale», «i vescovi non sono ormai che gli strumenti del papa», «il sovrano che, in virtù della sua infallibilità, è assolutissimo, più di qualunque altro monarca assoluto del mondo» (così il cancelliere tedesco Bismarck in una circolare ai governi europei, cit. in E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio, 311). Nel 2005 scriveva M. Faggioli: «L'ecclesiologia del Vaticano II coincide in buona parte con l'ecclesiologia dell'episcopato in rapporto al primato papale, [ ... ] maturazione teologica di cui oggi, a 40 anni dalla conclusione del concilio, si fatica ancora a percepire il rilievo» (cit. in G. ZIVIANI, Una Chiesa di popolo, 197). 2 Cfr. S. PIÉ-NINOT, Ecclesiologia, 396: si vede la differenza tra presbitero e vescovo solo nella potestas iurisdictionis di quest'ultimo (potere sul Corpo mistico), non nella potestas ordinis di cui anche il primo gode (potere sul Corpo eucaristico). 3 Secondo G. ZIVIANI, Una Chiesa di popolo, 144, il fatto che SC sia stata rapidamente approvata per prima (con tutto ciò che ne consegue) dipende anche dal fatto che: 1) i padri conciliari, ancora "inesperti", hanno molto assecondato il lavoro della commissione de Sacra liturgia; 2) hanno sottovaluto l'importanza reale della liturgia riguardo alla riforma della Chiesa. 1ECCLESIOLOGIA ISSR 2023-2024 insegnare, governare - con l'ordinazione, ma non può esercitare gli ultimi due se non nella «comunione gerarchica» col capo e le membra del collegio).
- Soprattutto biblisti e patrologi produssero studi sulla collegialità come nota caratteristica del gruppo dei Dodici e dei vescovi loro successori. Fu un punto assai più dibattuto del precedente, per il timore che attentasse al primato pontificio (-> LG 22 e N.e.p.).
- I primi accenni di una teologia missionaria capace di valorizzare (come già il cristianesimo delle origini) le ricchezze culturali dei popoli.
Soprattutto grazie a questi tre ambiti di riflessione, già prima del Concilio, alcuni teologi (Y. Congar e K. Rahner) avevano abbozzato una teologia della Chiesa locale.
LA CHIESA LOCALE (o PARTICOLARE) AL VATICANO II
Vocabolario oscillante al Concilio: usate come sinonimi le espressioni "Chiesa locale" e "Chiesa particolare". La prima, però, valorizza il luogo come luogo teologico, la seconda invece rischia di reintrodurre l'ecclesiologia universalista (la diocesi come parte/frammento dell'intero/Chiesa universale)4.
LG 23: Il Romano Pontefice e i Vescovi
Quale successore di Pietro, il romano pontefice è il perpetuo e visibile principio e il fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli. I singoli vescovi, invece, sono il visibile principio e il fondamento dell'unità delle loro chiese particolari, le quali sono formate a immagine della chiesa universale: in esse e a partire da esse esiste l'una e unica chiesa cattolica.
Il rapporto tra chiesa universale e chiese locali non è di somma/sottrazione (il tutto e le sue parti) ma di reciproca immanenza.
LG 26: La presenza di Cristo nelle assemblee locali
La Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, che, aderendo ai loro pastori, sono anch'esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono in un dato luogo il popolo nuovo chiamato da Dio, in Spirito Santo e piena sicurezza (cfr. 1Ts 1,5). In esse la predicazione del Vangelo di Cristo raduna i fedeli, e vi si celebra il mistero della cena del Signore, «affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore si rinsaldi l'intera fraternità del corpo». Ogni volta che si riunisce la comunità dell'altare sotto il sacro ministero del vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e «unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza». In queste comunità, anche se spesso piccole e povere o viventi nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti «la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo altro non fa che trasferirci in ciò che assumiamo»5.
Le chiese locali sono porzioni della chiesa universale: non parti di un tutto, ma il tutto presente nella parte, tutta la Chiesa presente e attiva in quel luogo6.
4 Purtroppo il CIC del 1983 ha scelto come unica espressione proprio "chiesa particolare", anche per poter considerare sotto questo nome le realtà ecclesiali in qualche modo assimilabili alla diocesi (prelature e abbazie territoriali, vicariati apostolici, ecc.) ... così facendo però, per rispetto alle eccezioni (le realtà non territoriali), ingloba sotto una categoria ambigua la realtà più normale! 5 Un testo simile si trova in CD 11, dove si afferma che nella «chiesa particolare [ ... ] è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una santa cattolica e apostolica». 6 «Una chiesa locale sorge quindi non per una frammentazione minuta del cosmo dell'intera chiesa, ma per concentrazione della chiesa, nel suo proprio tradursi in avvenimento»: K. Rahner, cit. in S. PIÉ-NINOT, Ecclesiologia, 354; poco oltre l'Autore ricorda che definire la diocesi come «porzione del popolo di Dio» significa richiamare ciò che afferma LG II, anche perché «non si confonda nella pratica, e con eccessiva facilità, la chiesa locale con il vescovo o si "episcopalizzi" in modo indebito tutta la vita diocesana». 2ECCLESIOLOGIA ISSR 2023-2024
Elementi di "presenza e attività" della Chiesa locale
Quattro sono gli elementi di questa piena "presenza e attività" (CD 11):
- La Parola di Dio accolta, proclamata e vissuta; il medesimo Vangelo è annunciato a tutti
i popoli, ma in ciascuno incontra un "terreno" diverso:
Il seme, cioè la parola di Dio, germogliando nel buon terreno irrigato dalla rugiada divina, assorbe la linfa vitale, la trasforma e l'assimila per produrre finalmente un frutto abbondante. Indubbiamente, come si verifica nell'economia dell'incarnazione, le giovani Chiese, radicate in Cristo e costruite sopra il fondamento degli apostoli, in un meraviglioso scambio assumono tutte le ricchezze delle nazioni, che a Cristo sono state assegnate in eredità. Esse dalle consuetudini e dalle tradizioni, dalla sapienza e dalla cultura, dalle arti e dalle scienze dei loro popoli mutuano tutti gli elementi che valgono a render gloria al Creatore, a mettere in luce la grazia del Salvatore e a ben organizzare la vita cristiana (AG 22)7.
- L'Eucaristia - cfr. LG 26 - fa la Chiesa, secondo l'intuizione profonda di s. Agostino, ripresa e rilanciata nel '900: «Ascolta l'Apostolo che dice ai fedeli: Voi siete il corpo di Cristo e sue membra (1Cor 12,27). Se voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. [ ... ] Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete» (Discorso 272). Questo fondamento forte della Chiesa locale non legittima una sua autarchia: cfr. l'antico uso del fermentum scambiato tra i vescovi come segno/strumento della communio tra le Chiese.
- Il Vescovo ha - cfr. LG 21-22 - il duplice compito di presiedere all'edificazione della chiesa locale (in virtù della pienezza dell'Ordine) e di mantenerla nella comunione con la Chiesa universale (in virtù del suo inserimento nel collegio episcopale8).
- L'opera dello Spirito Santo rimane piuttosto imprecisata, nei testi del Concilio, per
quanto riguarda la Chiesa locale. Una parziale eccezione è LG 13, che si esprime in
termini simili a quelli che saranno poi in AG 22 (cfr. sopra):
[ ... ] Infine Dio mandò lo Spirito del suo Figlio, Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio che riunisce e unifica, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (cfr. At 2,42).
In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così «chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra». Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. [ ... ] Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità del suo Spirito.
In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e per uno sforzo comune verso la pienezza nell'unità. Ne consegue che il popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma nel suo stesso interno si compone di funzioni diverse. [ ... ] Così pure esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione 7 Il passaggio si riferisce direttamente alle "giovani chiese", ma ben si adatta a tutte le chiese; in generale, anzi, tutto il decreto AG si può rileggere come una «visione anticipatrice del futuro» (C. THEOBALD, Urgenze pastorali, 354) per le chiese "di antica tradizione" ormai esculturate nell'Occidente postmoderno e impegnate nella non semplice conversione missionaria invocata da papa Francesco. 8 Collegio episcopale che, stando alle prese di posizione di Giovanni Paolo II (sulla scia di CDF, Communionis notio), è «elemento essenziale della Chiesa universale» e «realtà previa» all'ufficio di capitalità dei singoli vescovi nelle loro chiese locali; questa distinzione giustifica (a differenza di quanto previsto dal can. 6 del Concilio di Calcedonia - cfr. COD, 90 - e fino al XII secolo ) l'esistenza di vescovi titolari, "senza diocesi": cfr. E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio, 516-517, nota 57. 3