Fasi del metodo ipotetico-deduttivo e strategie di ricerca in psicologia
Documento dall'Università sulle Fasi del Metodo Ipotetico Deduttivo. Il Pdf, utile per lo studio della Psicologia a livello universitario, approfondisce le variabili, le loro definizioni operative e i metodi di misurazione, inclusi i concetti di validità e affidabilità.
See more20 Pages

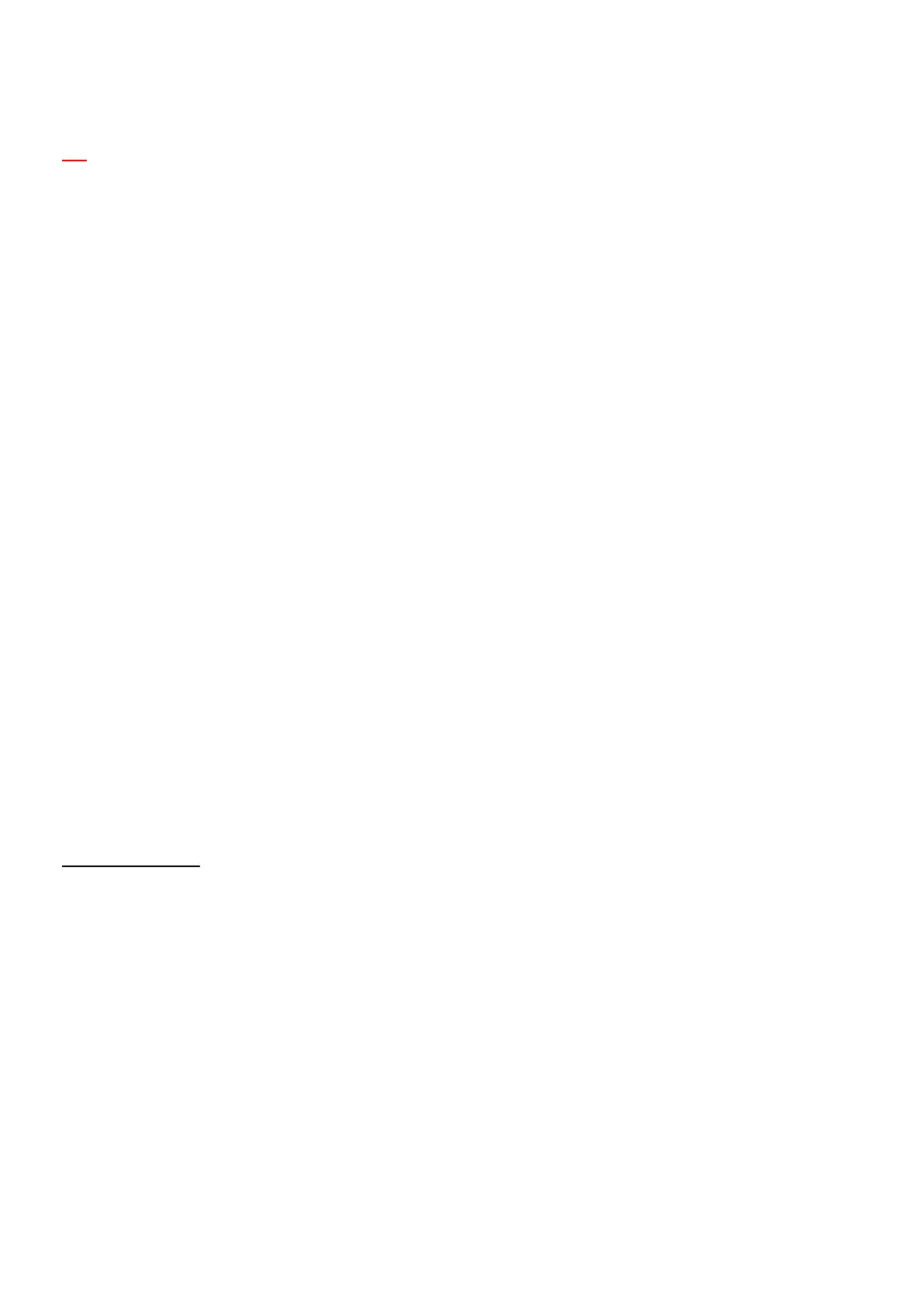
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Fasi del Metodo Ipotetico Deduttivo
Libro da pag. 31 a 33
FASI METODO IPOTETICO DEDUTTIVO:
- Osservazione del fenomeno
- definire il problema -> domanda di ricerca
- Ipotesi
- Raccolta di prove (per es. con esperimento)
- Pubblicare risultati
- Teoria
Nel processo di ricerca, le teorie hanno una doppia funzione:
- spiegano una determinata classe di fenomeni
- aiutano anche a identificare problemi da risolvere.
Le teorie scientifiche sono insiemi internamente coerenti (cioè, non contraddittori) di ipotesi esplicative confutabili, ma non ancora confutate (perchè altrimenti sarebbe falsa), espresse in un qualche linguaggio (Es. Attraverso leggi). Sono basate su costrutti teorici (es. la mente), cioè concetti inosservabili ma non per questo non studiabile.
Teorie e Leggi
Le teorie possono anche essere un insieme di leggi perchè:
- Le leggi spiegano regolarità osservabili.
- Le leggi psicologiche sono tutte probabilistiche, o non deterministiche (il comportamento umano è complesso, tanto da considerarlo un sistema dinamico complesso, così è impossibile avere previsioni su lungo tempo estremamente certe).
- Le leggi mettono in relazione due o più eventi, cercano di capire la loro relazione.
- La legge stabilisce i dettagli della relazione causale, e fa previsioni - obiettivamente confutabili.
Le teorie sono modelli concettuali che si propongono di spiegare dati sperimentali. Permettono di organizzare osservazioni sperimentali diverse all'interno di un contesto strutturato e coerente. Più osservazioni empiriche abbiamo, più completa e in grado di fare previsioni sarà la nostra teoria. Però relativamente ad un dato fenomeno è possibile avere tante teorie differenti, così nella scienza, quando due teorie sono contrapposte, la migliore è quella con maggior potere esplicativo e lo fa nel modo più semplice possibile.
Confronto tra Teorie
Quando due teorie fanno previsioni diverse su un particolare fenomeno, un esperimento può essere in grado di stabilire quale delle due previsioni sia corretta-> prova empirica, per questo è importante che la teoria possa essere falsificata. Se due teorie, pur prevedendo diversi costrutti e leggi, fanno le stesse previsioni su una classe di fenomeni, sono scientificamente indistinguibili -> si usa, in questo caso, il criterio epistemico detto rasoio di Ockham, cioè si usa quella che spiega la stessa cosa ma in maniera più semplice ed elegante.
Variabili e Misurazione in Psicologia
Abbiamo detto che l'utilizzo del metodo scientifico richiede di individuare delle proprietà degli eventi o dei comportamenti che si vogliono studiare che siano misurabili e che possono variare. Abbiamo detto che queste caratteristiche sono dette variabili. Soprattutto in psicologia, com'è possibile misurare delle variabili che sono apparentemente non misurabili (come la felicità o il benessere). Queste variabili sono dette variabili inosservabili, perché essendo associate a concetti teorici non è possibile misurarle direttamente (è simile alla posizione comportamentista, solo il comportamento è misurabile e quindi osservabile; attualmente però è possibile analizzare queste variabili in un esperimento). E' possibile analizzare scientificamente i risultati di un esperimento che coinvolga anche queste variabili se e solo se queste possono essere definite operativamente: se una variabile osservabile è definibile in base a delle operazioni specifiche che occorre fare per misurarne il valore possiamo operare una definizione operazionale di quella variabile e quindi possiamo procedere allo studio della variabile operazionale che è diventata così misurabile.Una definizione operazionale di una variabile inosservabile consiste nella specificazione di una delle possibili variabili osservabili secondarie considerata un indizio della variabile di interesse. Per questo bisogna stare ben attenti a non confondere la variabile secondaria con quella teorica.
Esempio di Definizione Operazionale
Es. supponiamo di voler studiare l'ottimismo e quanto esso influenzi lo stato di salute. La nostra ipotesi è che persone ottimiste possano guarire più velocemente da una malattia (cerco di mettere in relazione ottimismo, non misurabile, con lo stato di salute, misurabile). Ipotizzo una relazione tra questi due elementi: se mi fermo qui difficilmente riuscirò a verificare l'ipotesi perchè non riesco a misurare la variabile dell'ottimismo e non riesco a capirne l'impatto. Per questo è necessaria la definizione operazionale di entrambe le variabili: Posso operazionare l'ottimismo trovando una variabile secondaria misurabile, come il questionario LOT. Allora il punteggio al questionario, è un indice indiretto dell'ottimismo, lo suggerisce. La stessa cosa deve essere fatta con lo stato di salute, quindi posso decidere di misurarlo attraverso il tempo di recupero dopo un'intervento. Tra le due variabili secondarie definite, andrò ad osservare se esiste la relazione ipotizzata tra le variabili non osservabili.
Problemi delle Definizioni Operazionali
Ci sono dei problemi che ci troviamo davanti nel fare queste operazioni. Le definizioni operazionali di variabili inosservabili non sono mai univoche o perfette. Gli esperimenti, in realtà, ci permettono di trarre conclusioni riguardo ai rapporti tra le particolari variabili secondarie utilizzate ma non ci permettono al 100% di estrapolare "automaticamente" conclusioni sulle relazioni tra concetti teorici, ce li suggeriscono ma dobbiamo essere cauti. Solo la molteplicità e la convergenza delle evidenze potrà consentire di sviluppare un certo grado di fiducia verso una relazione teorica: se differenti ricercatori, operazionalizzando le stesse variabili teoriche in diversi modi, ottengono risultati riportabili alle medesime relazioni teoriche, crescerà il grado di fiducia verso la plausibilità della spiegazione teorica proposta per il fenomeno preso in considerazione.
Tipi di Variabili
Esistono due tipi di variabili:
- Le variabili quantitative o continue variano lungo un continuum (Tempo di reazione in millisecondi, peso in chilogrammi, altezza in centimetri).
- Le variabili qualitative o discrete o categoriche, possono assumere un solo valore entro una gamma finita (Veloce o lento, pesante o leggero, alto o basso, corretto o sbagliato, rosso o bianco o verde).
Misurazione e Scale
MISURAZIONE. Misurare significa assegnare un numero o un'etichetta alle caratteristiche degli oggetti, in base a determinate regole. La misurazione deve essere il risultato del confronto di un dato osservato con una posizione identificabile su una scala.
Classificazione delle Scale di Misurazione
Stevens (1951) propose una classificazione di quattro tipi di scale di misurazione (sono quelle utilizzate in psicologia) dalla più semplice alla più complessa:
- Nominale;
- Ordinale;
- A intervalli;
- A rapporti.
Livelli di misurazione variano in base alla natura delle variabili. Le variabili discrete possono essere misurate con: 1) Scala Nominale: assumono valori diversi ma non esiste relazione asimmetrica; 2) Scala Ordinale: assumono valori diversi ma con relazione asimmetrica d'ordine. Le variabili continue possono essere misurate su: 1) Scala a intervalli: esiste un'unità di misura, che stabilisce il valore della variabile, ma l'origine della scala è variabile; 2) Scala a rapporti: l'origine della scala è fissa e ha un'importanza fondamentale per le variabili, in quanto stabilisce in maniera univoca quelle che sono le procedure di elaborazione statistica che si possono applicare a esse.
Variabili Nominal
VARIABILI NOMINALI Assumono valori diversi ma non esiste relazione asimmetrica. Esse informano solo sull'uguaglianza o diversità di due eventi (es. Sesso, Professione, Colore dei capelli, Mezzi di trasporto per arrivare al lavoro, Scolarità, Materie scolastiche), posso misurarle assumendo valori differenti ma non si possono mettere tra di loro in qualche relazione (no superiorità maschio o femmina). Scala nominale= consente di operare classificazioni sulla base della presenza o assenza della qualità considerata, senza fornire graduazioni. Questo tipo di scala può servire solo per individuare chi possiede una certa qualità e chi no. Le uniche relazioni che possiamo stabilire fra le misure di una variabile su scala nominale sono le relazioni "uguale" e "diverso".
Variabili Ordinali
VARIABILI ORDINALI Scala ordinale= consente di stabilire delle graduatorie, e cioè delle relazioni di maggiore e minore rispetto a una determinata qualità osservata. Oltre a differenziare tra due eventi, informa sull'ordine della differenza. Possono assumere valori diversi ma con relazione asimmetrica d'ordine. Per esempio questo accade nel chiedere il grado di preferenza nei confronti di diverse opzioni in un compito decisionale (es. da 1 a 3 compreresti questo prodotto). Un'altro esempio è rappresentato dalla valutazione dello studente con voto: Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo; posso ordinare e dire che uno è superiore o inferiore all'altro, ma non so di quanto.
Variabili a Intervalli
VARIABILI A INTERVALLI Scale a intervalli = consente, come quella ordinale, di formare delle graduatorie, ma si caratterizza per il fatto che l'intervallo tra due posizioni successive resta costante lungo tutta l'estensione della scala. Nella ricerca psicologica, un esempio che si avvicina alla scala a intervalli potrebbe essere il quoziente di intelligenza. Esiste un'unità di misura ma l'origine della scala è variabile, cioè ammette valori negativi. In questo caso posso quantificare la differenza che intercorre tra un livello e l'altro. Es. Temperatura: se un qualche intervento farà crescere la temperatura da 2℃ a 4℃ potremo dire che la temperatura è cresciuta di due gradi, ma non che è "raddoppiata", so dire con precisione di quanto è cresciuta però non posso dire che è raddoppiata perché l'origine è variabile.
Variabili a Rapporti
VARIABILI A RAPPORTI Scala a rapporti = possiede le proprietà di una scala a intervalli e consente di identificare anche una posizione corrispondente alla mancanza di una determinata proprietà, cioè lo zero assoluto. Esiste un'unità di misura e l'origine della scala è fissa, esiste uno zero assoluto. Es. Peso, Lunghezza, Tempo di reazione (Per esempio, se un tempo di risposta cresce da 200 ms a 400 ms, potremmo certo dire che è aumentato di 200 ms, ma anche che è raddoppiato).
Criteri di Misurazione
Affinché la misurazione di una variabile sia utile, deve soddisfare criteri di validità, affidabilità e sensibilità.
- Una misura è valida se è diagnostica verso il costrutto che si intende misurare. (Intelligenza misurata come QI è diagnostico rispetto al costrutto teorico, se scegliessi il colore della pelle non lo sarebbe.)
- Una misura è affidabile o attendibile se genera risultati coerenti in condizioni simili. Se pensiamo una persona su una bilancia e questa indica 70 kg e due minuti dopo,