Disturbi dello spettro autistico e teoria della mente in psicologia
Slide dall'Università Magna Graecia di Catanzaro su disturbi dello spettro dell'autismo e teoria della mente. Il Pdf, utile per lo studio universitario in Psicologia, esplora l'origine dell'autismo, il concetto di teoria della mente e le difficoltà nella comprensione delle emozioni altrui.
Ver más36 páginas

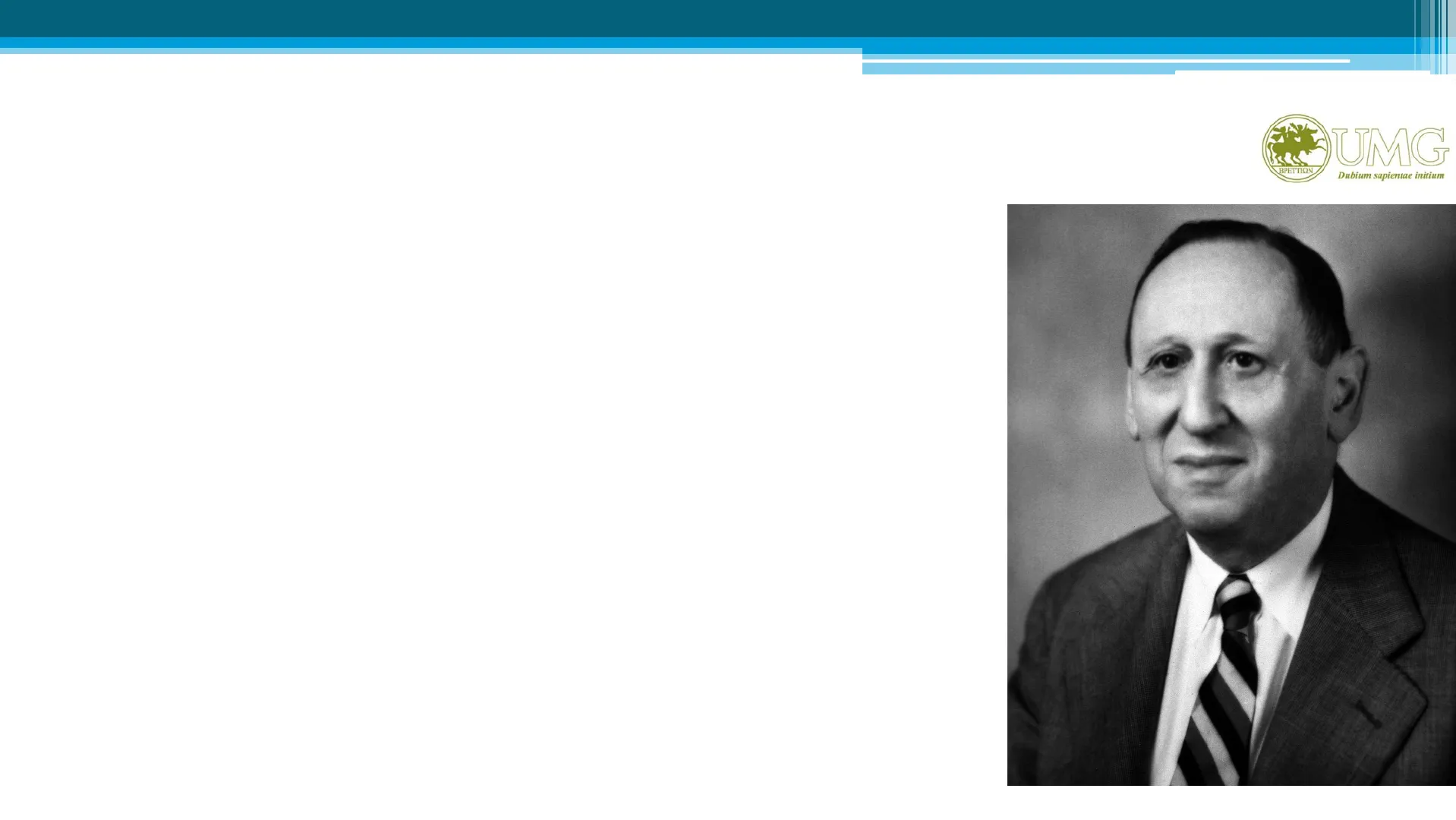
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Disturbi dello spettro dell'autismo e teoria della mente
Corso TFA
"Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva e
dei disturbi generalizzati dello sviluppo"
BPETTIQN
UMG
Dubium sapientae initium
Prof.ssa Valeria Verrastro
Psicologa-Psicoterapeuta
Professore Associato in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Università «Magna Graecia» di CatanzaroUMG
Dubium sapientae initium
BPETTION
L'autismo: introduzione e storia
Il termine disturbo autistico è stato introdotto la
prima volta dallo psichiatra viennese Leo Kanner
nel 1943.
A seguito della sua descrizione di 11 bambini
colpiti da questo disturbo la nozione di autismo
entrò a far parte della cultura scientifica, delle
classificazioni mediche ufficiali e della cultura
popolare.
Tuttavia esistono casi storici documentati che
lasciano pensare che il disturbo dello spettro
autistico sia sempre esistito.UMG
Dubium sapientae initium
BPETTION
L'autismo: sindrome comportamentale
L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un
disordine dello sviluppo biologicamente determinato.
Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative
all'interazione sociale reciproca, all'abilità di comunicare idee e
sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri
L'autismo pertanto si configura come disabilità "permanente"
che accompagna il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le
caratteristiche del deficit sociale assumono un'espressività
variabile nel tempoSi parla però di
DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO
Esiste infatti un'ampia gamma di
disabilità/diversità che si
presentano con una grande
variabilità.
La gravità varia a tal punto che a
seconda dell'intensità delle
caratteristiche di funzionamento
diventa appropriato parlare di
disabilità o di diversità a secondo
dei casi.
BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Autism Spectrum Disorder: caratteristiche
Executive
Function
Information
Processing
Sensory
Processing
Verbal &
Nonverbal
Communication
Autism
Spectrum
Disorder
Repetitive
Behaviors
Social
Awareness
Motor
Skills
Perseverative
ThinkingCaratteristiche
BPETTIQN
UMG
Dubium sapientae initium
Il disturbo dello spettro dell'autismo (Autism
Spectrum Disorder, ASD) è un disturbo del
neurosviluppo caratterizzato da una grave
compromissione dell'interazione sociale e
della comunicazione e dalla presenza di
pattern di comportamento ripetitivi e ristretti.BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Vi è molta variabilità individuale nelle traiettorie di sviluppo
dei bambini con ASD.
Vi sono marcate differenze nell'insorgenza delle compromissioni
comunicative e sociali.
Alcuni bambini presentano un'evidente regressione o assenza di
comunicazione sociale o di abilità linguistiche, mentre altri
mostrano modalità di esordio più graduali, che possono essere
rappresentate da una mancata acquisizione delle abilità sociali
appropriate per l'età o da un graduale ritiro dall'interazione
sociale.BPETTIQN
UMG
Dubium sapientae initium
Altre caratteristiche possono essere:
- Approccio sociale atipico
- Mancato o limitato interesse per i pari e per il gioco con altri bambini
- Iniziativa nell'interazione sociale rara, ridotta o assente
- Uso atipico di contatto oculare
- Ristretta gamma di espressioni facciali e comunicazione verbale limitata
- Difficoltà nella comprensione o nell'uso della comunicazione non verbale· Movimento o utilizzo degli oggetti o dei giocattoli stereotipati o
ripetitivi
BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
- Esigenza di immutabilità delle routine e manifestazioni di disagio di
fronte a cambiamenti - Interessi fortemente circoscritti, specifici o inusuali che esprimono in
fissazioni estreme o atipiche per un oggetto o un tema - Responsività atipica agli stimoli sensoriali (ipo o iper)
- Difficoltà di coinvolgersi nei giochi di finzione o immaginazioneBPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Epidemiologia dell'autismo
La prevalenza del disturbo autistico negli ultimi anni è cresciuta
rapidamente: si è passati da 1 bambino su 150 nel 2000 a 1 su 59
nel 2014.
L'ipotesi avanzata per spiegare un tasso così crescente coinvolge 2
fattori principali: il cambiamento dei criteri diagnostici descritti nel
DSM-5 e lo sviluppo e il perfezionamento degli strumenti di
valutazione
L'autismo si trova più spesso nei maschi che nelle femmine, con un
rapporto 4:1, e non presenta prevalenze geografiche e/o etniche.Eziologia
BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Eziologia dell'autismo: cause e fattori
Le cause dell'autismo sono tutt'oggi sconosciute.
Le ricerche indicano che i geni giocano un ruolo importante nello
sviluppo dell'autismo, ma non c'è un unico gene da imputare.
La componente genetica è apparsa chiara dai numerosi studi
condotti di gemelli che indicano una concordanza compresa tra il
60% e il 92% per gli omozigoti e riguarda invece lo 0-10% per
gli eterozigoti.BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Tuttavia, dato che la genetica non spiega completamente il
rischio di disturbo dello spettro autistico o l'accrescimento
della percentuale dei casi, gli scienziati sono alla ricerca di
cause ambientali, presenza di tossine, elementi chimici, in
grado di stimolare lo sviluppo del disturbo anche nel corso
della gravidanza o nei primi mesi di vita del bambino.
Anos
AMIN
GIN
ING
SION
URCE
TEAC
T
EXPI
EXAMINE
F
PRO
PROJE
OLAN
SCIENCE
PROBE
S
GYL
PROBE O
K
NT
EXAMINAT
OLOG
HING
OM
ENCE
OK Z
TEAC
N
SCANS
EXAMIN
SEDIMENT WIC
MIT
IATION
DOM
RESEARCH
ERIMENTATION
SCAN
MISS
LOCATION
EXPER
T
OF
LEA
OOK
EN
LEARN
TEAC
P METHODOLO
EXPERIMEI
STOC
METHOD
TH
EXA
CHECKIl ruolo dell'ambiente va, infatti, considerato sia nella sua capacità
di incidere "direttamente" sul genotipo, condizionando il
complesso
meccanismo
di
interazione
genica, sia
BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
"indirettamente", portando alla luce un assetto neurobiologico
geneticamente
inadeguato
all'elaborazione
e
alla
metabolizzazione degli stimoli che arrivano normalmente al
sistema nervoso centrale.
Recentemente è stata inoltre posta attenzione sull'ipotesi di una
correlazione temporale stretta tra le vaccinazioni e la comparsa
di alcuni comportamenti autistici. Allo stato attuale non ci sono
dati che indichino che un qualsiasi vaccino aumenti il rischio
di sviluppare autismo o qualsiasi altro disturbo del
comportamentoBPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Basi neurobiologiche dell'autismo
Studi morfologici e brain imaging
Gli studi morfologici del sistema nervoso
centrale attraverso le tecniche di brain
imaging non invasive (TAC e RMN)
hanno rilevato spesso anomalie in
diverse strutture cerebrali, quali il
cervelletto, il lobo frontale e il sistema
limbico con particolare interesse
all'amigdala e all'ippocampo.
Componenti Principali del Sistema Limbico
Talamo
Fornice
Setto
Pellucido
Corpo
Calloso
Stria
Terminalis
Bulbo Olfattivo
Ipotalamo
Amigdala
Ippocampo
Corteccia'
EntorinaleUMG
Dubium sapientae initium
BPETTION
Attualmente è possibile anche utilizzare strumenti di
neuroimaging funzionale (RM funzionale, PET, SPECT)
durante lo svolgimento di compiti linguistici o di problem
solving sociale, che hanno permesso di identificare nei soggetti
normali le strutture encefaliche coinvolte nella realizzazione di
obiettivi mentali specifici.
Grazie a questo è stato possibile effettuare diverse ricerche
permettendo di rilevare che determinate aree cerebrali
presentano una minore attività in individui autisticiUMG
Dubium sapientae initium
BPETTION
Disfunzioni dei neuroni a specchio
Vari studi recenti, inoltre, hanno indicato
disfunzioni relative ai neuroni a specchio in
soggetti con disturbi dello spettro autistico.
Questi neuroni permettono di spiegare
fisiologicamente la nostra capacità di metterci in
relazione con gli altri, infatti si attivano
selettivamente sia quando si compie un'azione
(con la mano o con la bocca) sia quando la si
osserva mentre è compiuta da altri.
Si attivano anche di fronte all'espressione delle
emozioni altrui, fornendo la base biologica
dell'empatia.UMG
Dubium sapientae initium
BPETTION
Nel complesso gli studi effettuati per descrivere le basi
neurobiologiche ed eziologiche dell'autismo hanno consentito
di comprendere meglio dove e come sono situate le disfunzioni
di questo disturbo che a seconda del suo posizionamento lungo
lo spettro possono differire per gravità e funzionamento.Criteri diagnostici
Secondo il DSM-5, il disturbo dello spettro autistico deve
soddisfare i criteri A, B, C e D
BPETTION
UMG
Dubium sapientae initium
Criteri diagnostici del DSM-5 per l'autismo
Criterio A: Deficit nella comunicazione sociale
A. Deficit persistenti
nella comunicazione
sociale e nella
interazione sociale
in differenti contesti, che
non siano una semplice
conseguenza di un
ritardo generale dello
sviluppo.
- Deficit nella reciprocità socio-emozionale: varia da approcci sociali atipici e fallimenti nella
normale conversazione bidirezionale, a una riduzione della condivisione di interessi, emozioni e
affetti, fino alla totale mancanza di iniziativa nell'interazione sociale reciproca. - Deficit nella comunicazione non verbale, comportamenti fondamentali per l'interazione sociale:
varia da una comunicazione con scarsa integrazione degli aspetti verbali e non-verbali, ad
anomalie nel contatto oculare e nel linguaggio corporeo, deficit nella comprensione e nell'uso
della comunicazione non verbale, fino alla totale assenza di gesti ed espressioni facciali. - Deficit nello sviluppare e nel mantenere relazioni sociali appropriate al livello di sviluppo (oltre
a quelle con i caregiver), che varia dalla difficoltà di modulare il comportamento nei diversi
contesti sociali, alla difficoltà nel gioco immaginativo condiviso e nello sviluppare amicizie, fino
alla (apparente) assenza di interesse verso le altre persone.
Criterio B: Pattern ristretto e ripetitivo
B. Un pattern ristretto
e ripetitivo di
comportamenti,
interessi o attività, che
si manifesta in almeno
due dei seguenti criteri
- Eloquio, movimenti motori o uso degli oggetti stereotipato o ripetitivo, come stereotipie
motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti o frasi idiosincratiche. - Eccessiva aderenza a routine, pattern ritualizzati di comportamenti verbali o non verbali, oppure
eccessiva resistenza al cambiamento, come insistenza sugli stessi percorsi o sugli stessi cibi,
domande ripetitive o estremo disagio per piccoli cambiamenti. - Interessi altamente ristretti e fissi, atipici per intensità o per focalizzazione, come forte
attaccamento o preoccupazione per oggetti insoliti, interessi estremamente circoscritti o
perseverativi. - Iper o iposensibilità a input sensoriali o interessi atipici per aspetti sensoriali dell'ambiente,
come apparente indifferenza al dolore o al freddo, riposte evitanti a specifici suoni o aspetti
tattili, eccessiva attività nell'odorare o nel toccare oggetti, fascinazione per luci o per oggetti che
ruotano.
C. I sintomi devono essere presenti nell'infanzia, ma possono manifestarsi pienamente solo quando le richieste sociali
eccedono le capacità limitate.
D. I sintomi nel loro insieme limitano e compromettono il funzionamento quotidiano.