Riassunto completo di Psicologia Clinica I: disturbo mentale e neuroscienze
Documento di Psicologia Clinica I sul disturbo mentale e il rapporto tra mente e cervello. Il Pdf esplora le teorie del dualismo e del monismo, l'eliminativismo e il funzionalismo, e gli approcci delle neuroscienze alle psicopatologie, utile per studenti universitari di Psicologia.
Ver más50 páginas
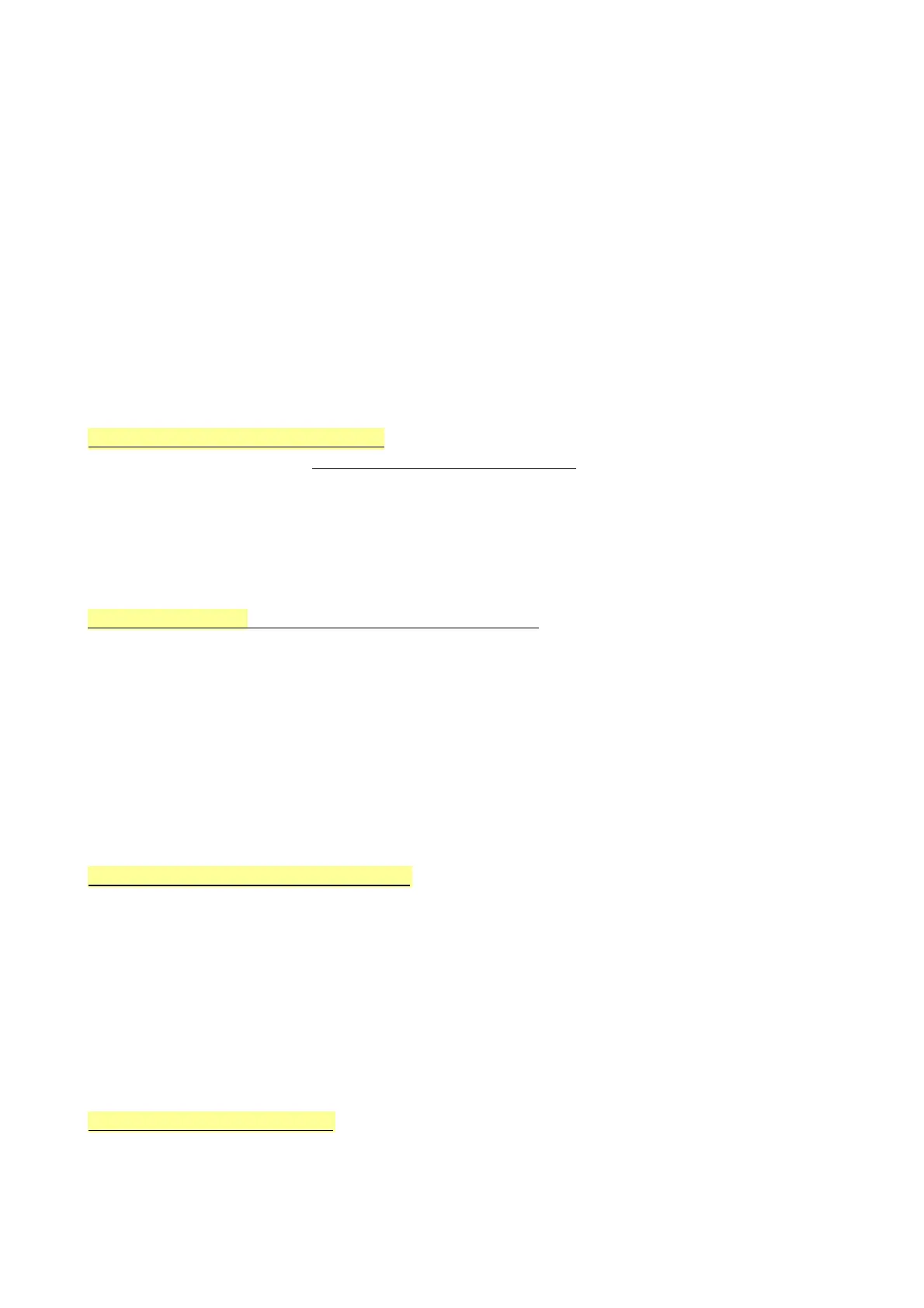
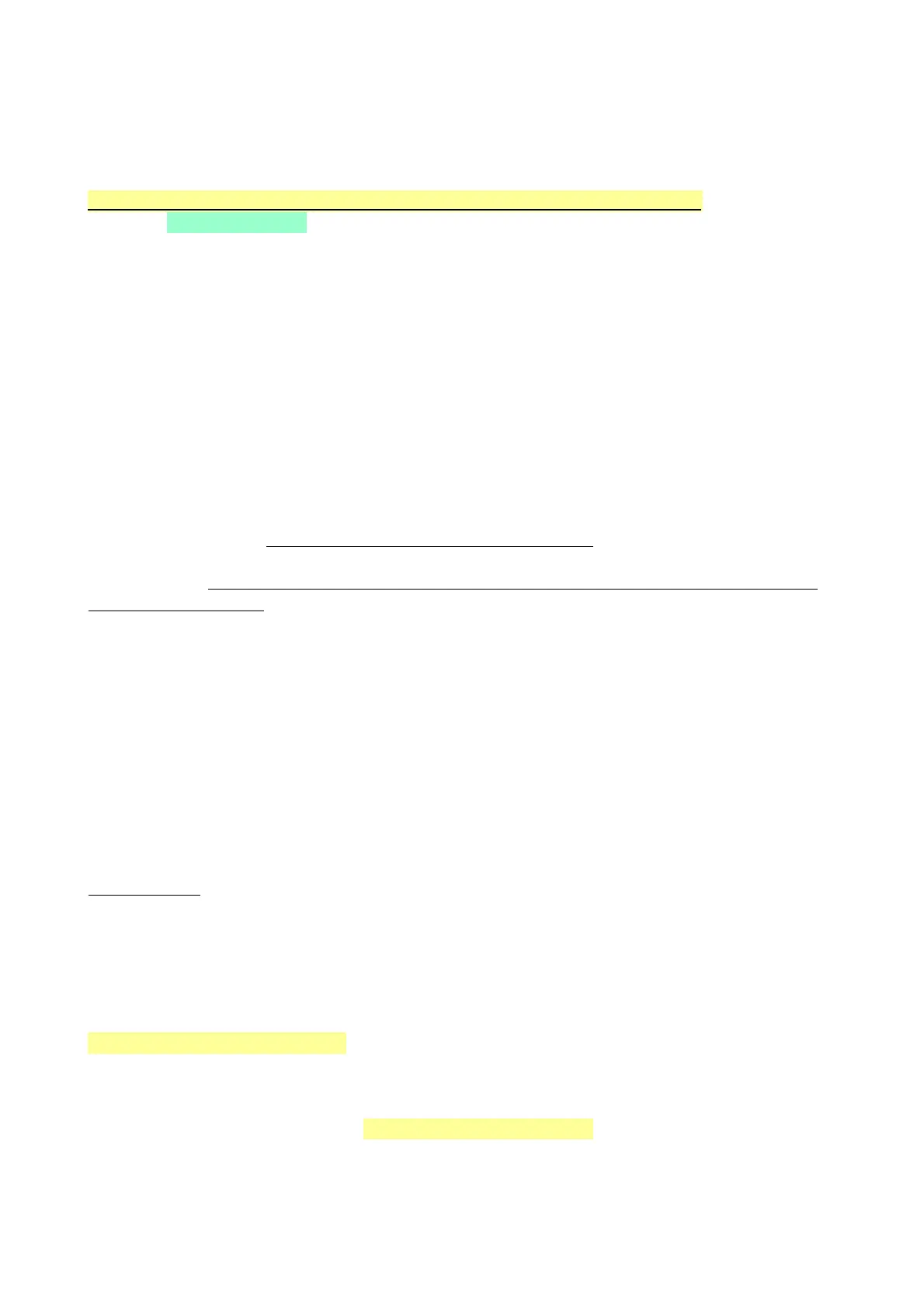
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Modulo I - Parte generale
Definizione di disturbo mentale
Un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da un'alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della regolazione emotiva o del comportamento, che riflette una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi legati al funzionamento mentale (DSM-5, 2013).
Caratteristiche del Disturbo Mentale (DSM-5 e ICD-10)
Un disturbo mentale è una condizione propria dell'individuo, che causa sofferenza psicologica (distress) o una forte disfunzionalità. Non è: Una reazione normale a un evento esterno (es. lutto, perdita lavorativa, fine di una relazione). Primariamente il risultato di una devianza sociale o di un conflitto con la società.
Distress personale
La sofferenza emotiva può essere: Parte integrante del disturbo (es. ansia e panico nell'agorafobia). Una conseguenza della patologia (es. un bambino con ADHD può essere emarginato). Tuttavia: Non tutti i disturbi mentali causano sofferenza emotiva (es. disturbo antisociale di personalità). Non tutte le sofferenze emotive sono disturbi mentali (es. dolore per un lutto o una perdita importante). Nei disturbi patologici, la sofferenza appare paradossale: è intensa, duratura e priva di adattamento, impedendo al soggetto di trovare una via per accettarla o superarla.
Disabilità e compromissione funzionale
Il disturbo può interferire con aspetti importanti della vita (es. relazioni, studio, lavoro). Esempio: Nel DOC, il tempo impiegato per i rituali può compromettere la produttività e le relazioni sociali. Tuttavia, non tutte le disabilità derivano da disturbi mentali (es. la sordità può compromettere la vita sociale, ma non è un disturbo mentale). Non tutti i disturbi mentali causano una disabilità evidente: Esempio: Una persona con agorafobia che vive in un piccolo paese, senza necessità di usare mezzi pubblici, potrebbe non sperimentare limitazioni pratiche nella sua quotidianità.
Violazione delle norme sociali
Alcuni disturbi comportano comportamenti percepiti come bizzarri o incomprensibili, rendendo difficile la relazione con gli altri (es. deliri schizofrenici). Tuttavia, questa 1 di 50RIASSUNTO COMPLETO PSICOLOGIA CLINICA I (ACETO as 2024/2025) di MAM GUIDI valutazione dipende dalla cultura di riferimento: ciò che è considerato patologico in una società può essere accettato in un'altra.
Disfunzione psicologica o biologica e la Teoria del Buon Funzionamento
Secondo Wakefield (1992), un disturbo mentale è causato da un meccanismo evolutivo mal funzionante. Esempio: L'ansia ha una funzione adattiva (protezione dai pericoli), ma diventa patologica quando si attiva in situazioni sicure (es. fobia del sangue). Jerome Wakefield è uno psicologo e filosofo che ha proposto la teoria della disfunzione dannosa (harmful dysfunction) per definire i disturbi mentali. Secondo lui, un disturbo mentale si verifica quando:
- Un meccanismo biologico o psicologico non funziona correttamente (disfunzione).
- Questa disfunzione causa sofferenza o compromissione significativa (danno).
Punto di forza della teoria di Wakefield
Definizione oggettiva della patologia: anziché basarsi solo su criteri soggettivi (es. sofferenza psicologica), Wakefield collega i disturbi mentali a un malfunzionamento biologico o evolutivo, fornendo una base scientifica più solida. Supera la soggettività culturale: evita che disturbi mentali siano definiti solo in base alle norme sociali, riconoscendo che alcune condizioni sono patologiche indipendentemente dal contesto culturale.
Aspetto critico della teoria di Wakefield
Difficoltà nel determinare il "buon funzionamento": non sempre è chiaro quale sia la funzione evolutiva di certi meccanismi psicologici (es. la depressione ha avuto un ruolo adattivo?). Ambiguità nella distinzione tra disfunzione e variabilità normale: non sempre è evidente se una caratteristica sia un disturbo o una semplice differenza individuale (es. ansia elevata ma adattiva Vs. ansia patologica). La teoria di Wakefield ha il merito di cercare una definizione più scientifica dei disturbi mentali, ma incontra limiti nella difficoltà di individuare chiaramente le funzioni evolutive di molti processi psicologici.
Conclusione sulla definizione di disturbo mentale
Un disturbo mentale si definisce attraverso più criteri, combinando distress, disabilità, violazione delle norme sociali e disfunzioni psicologiche/biologiche. La sua classificazione dipende da manuali diagnostici come il DSM-5 e l'ICD-10, che stabiliscono criteri standardizzati
Irrazionalità e Psicopatologia
Si è a lungo ritenuto che l'irrazionalità fosse un criterio distintivo tra normalità e psicopatologia, ma la ricerca psicologica ha dimostrato che la questione è più complessa.
Irrazionalità e Bias Cognitivi
Il paziente ipocondriaco è spesso citato come esempio di irrazionalità perché compie un 2 di 50RIASSUNTO COMPLETO PSICOLOGIA CLINICA I (ACETO as 2024/2025) di MAM GUIDI bias confirmatorio: Accetta solo le informazioni che confermano la sua convinzione di essere malato. Rifiuta le ipotesi alternative, anche se più plausibili. Tuttavia, tutti gli esseri umani sono soggetti a bias confirmatori e il pensiero quotidiano si discosta spesso dalla logica formale
La Logica nei Disturbi Psicopatologici
Contrariamente alle aspettative, studi dimostrano che pazienti con ipocondria, agorafobia e DOC compiono meno errori logici rispetto ai soggetti non clinici. Questo accade perché:
- I pazienti diventano esperti nel loro dominio sintomatico.
- Analizzano in modo molto preciso le situazioni legate ai loro disturbi, applicando un ragionamento logico rigoroso (es. sillogismi coerenti con il loro stato emotivo). Anche nei soggetti non clinici, le emozioni (es. vergogna) influenzano il ragionamento, portando a meno errori logici quando i sillogismi sono coerenti con l'emozione provata.
Differenza tra Logica Formale e Logica Pratica
La razionalità formale si riferisce alla logica pura e astratta (corretta applicazione delle regole di inferenza). La razionalità pratica è la capacità di prendere decisioni funzionali nella vita quotidiana. I pazienti psicopatologici non sono irrazionali nel senso logico, ma spesso lo sono in senso pratico, poiché:
- Persistono in pensieri e comportamenti disfunzionali, nonostante abbiano le informazioni per modificarli.
- Rimangono bloccati in schemi cognitivi che aggravano la loro sofferenza.
Conclusione sull'irrazionalità
L'irrazionalità logica non è un criterio distintivo della psicopatologia, poiché anche i soggetti non clinici ragionano in modo non sempre logico. Tuttavia, i pazienti con disturbi mentali possono essere irrazionali dal punto di vista pratico, continuando a seguire schemi di pensiero e comportamento dannosi, nonostante abbiano le capacità di cambiarli.
Bias Confirmatorio nei Soggetti Normali
Il bias confirmatorio è la tendenza a cercare, interpretare e ricordare le informazioni in modo da confermare le proprie convinzioni, ignorando o minimizzando dati che le contraddicono. Questo non è un fenomeno esclusivo dei pazienti con disturbi mentali, ma riguarda tutti gli esseri umani nella vita quotidiana.
Esempi pratici di bias confirmatorio nei soggetti normali
Notizie e Politica
Una persona che ha già un'idea politica consolidata tende a leggere solo articoli o guardare programmi che confermano la sua opinione, evitando fonti contrarie. 3 di 50RIASSUNTO COMPLETO PSICOLOGIA CLINICA I (ACETO as 2024/2025) di MAM GUIDI Se trova una notizia che supporta la sua posizione, la considera affidabile; se invece contraddice la sua visione, tende a scartarla come "falsa" o manipolata.
Superstizioni e credenze irrazionali
Una persona crede che i gatti neri portino sfortuna. Se un giorno, dopo aver visto un gatto nero, ha un piccolo incidente, si ricorda di quell'evento come conferma della superstizione. Se invece passa davanti a 10 gatti neri senza che accada nulla, non considera questi episodi come prove contrarie alla sua credenza.
Relazioni e amicizie
Una persona sospetta che il suo partner la tradisca. Nota piccoli dettagli (un messaggio ricevuto, un ritardo imprevisto) e li interpreta come prove del tradimento. Se invece il partner fornisce spiegazioni logiche, la persona potrebbe ignorarle o vederle come tentativi di insabbiamento.
Effetto placebo e medicina alternativa
Qualcuno prende un integratore naturale credendo che migliori la memoria. Se dopo qualche giorno si sente più attento, attribuisce il merito all'integratore, ignorando altri fattori (buon riposo, meno stress). Se invece non nota miglioramenti, tende a giustificare il fallimento ("forse non l'ho preso abbastanza a lungo").
Investimenti e finanza
Un investitore crede che un'azienda abbia un futuro promettente e cerca solo informazioni che confermano la sua idea, ignorando segnali di difficoltà finanziaria. Questo comportamento può portarlo a decisioni sbagliate, come mantenere un'azione in perdita troppo a lungo.
Scuola e apprendimento
Uno studente crede di essere "negato per la matematica". Quando prende un brutto voto, lo usa come prova della sua incapacità. Se invece ottiene un buon voto, tende a vederlo come un caso fortuito o un compito particolarmente facile.
Conclusione sul bias confirmatorio
Il bias confirmatorio è un meccanismo cognitivo comune e spesso automatico, utile per semplificare la realtà e prendere decisioni rapide. Tuttavia, può portare a errori di giudizio e a una visione distorta della realtà, contribuendo alla rigidità delle convinzioni personali
Realismo e Psicopatologia
Si è diffusa l'idea che la psicopatologia sia caratterizzata da una scarsa aderenza ai fatti, ossia da una rappresentazione falsa e distorta della realtà.
Il caso della depressione
Si pensa che i pazienti depressi esagerino il proprio stato di difficoltà. Tuttavia, la ricerca dimostra che i depressi medio-gravi sono spesso più realistici dei non depressi. 4 di 50RIASSUNTO COMPLETO PSICOLOGIA CLINICA I (ACETO as 2024/2025) di MAM GUIDI I soggetti sani tendono ad avere illusioni ottimistiche, vedendo la vita in modo più positivo e minimizzando i rischi. Conclusione: la psicopatologia non è sempre associata a un distacco dalla realtà, anzi, in alcuni casi una maggiore lucidità può favorire il malessere.
Razionalità formale e irrazionalità pratica
La razionalità formale (rispetto della logica) e il realismo (adesione ai fatti) non garantiscono la sanità mentale. Esempio: Depressione -> La perdita delle illusioni ottimistiche può aumentare la sofferenza. DOC -> Il ragionamento logicamente corretto può rafforzare convinzioni patologiche (es. "se non mi lavo le mani, potrei infettare qualcuno"), contribuendo all'irrazionalità pratica.
Stigma e Psicopatologia
Lo stigma è un insieme di convinzioni e atteggiamenti negativi nei confronti dei malati mentali.
Caratteristiche dello stigma
- Etichetta che distingue i gruppi -> "Noi sani" Vs. "Loro malati".
- Accezione negativa - Il disturbo mentale è visto come pericoloso o inaccettabile.
- Segna un confine sociale - Crea esclusione e discriminazione.
- Aumenta la sofferenza del paziente -> L'isolamento peggiora il disagio. Negli anni '60, il movimento antipsichiatrico ha combattuto lo stigma, denunciando il fatto che gli ospedali psichiatrici causavano ulteriore danno ai pazienti, promuovendo quindi la loro chiusura
IL PARADIGMA GENETICO
Struttura genetica e unicità dell'individuo
Uno zigote (cellula uovo fecondata) contiene 46 cromosomi, ognuno dei quali ha numerosi geni che trasportano informazioni genetiche attraverso il DNA. La sequenza genica e la modalità di espressione determinano le caratteristiche uniche di ogni individuo.
Ruolo dei geni e delle proteine
I geni regolano molte funzioni producendo ormoni e proteine. Esempi di ormoni proteici: insulina (regola la glicemia), ossitocina (coinvolta nell'attaccamento e nelle emozioni). Eccezioni: gli ormoni sessuali (testosterone, estrogeni) e quelli della corteccia surrenale (cortisolo) sono steroidi, non proteine. Le proteine attivano o disattivano geni, regolando il funzionamento cerebrale e corporeo. Esempio: una proteina che regola la serotonina può influenzare l'umore e la predisposizione alla depressione.
Interazione Geni-Ambiente
I geni non determinano rigidamente chi siamo, perché si attivano o disattivano in risposta 5 di 50