Didattica Generale, Ricerca e Documentazione Educativa
Documento di Università sulla didattica generale. Il Pdf esplora la didattica come disciplina, le sue trasformazioni e il ruolo dell'insegnante, analizzando concetti come l'innovazione didattica e l'importanza della documentazione educativa per la memoria e la trasparenza delle azioni.
Ver más56 páginas
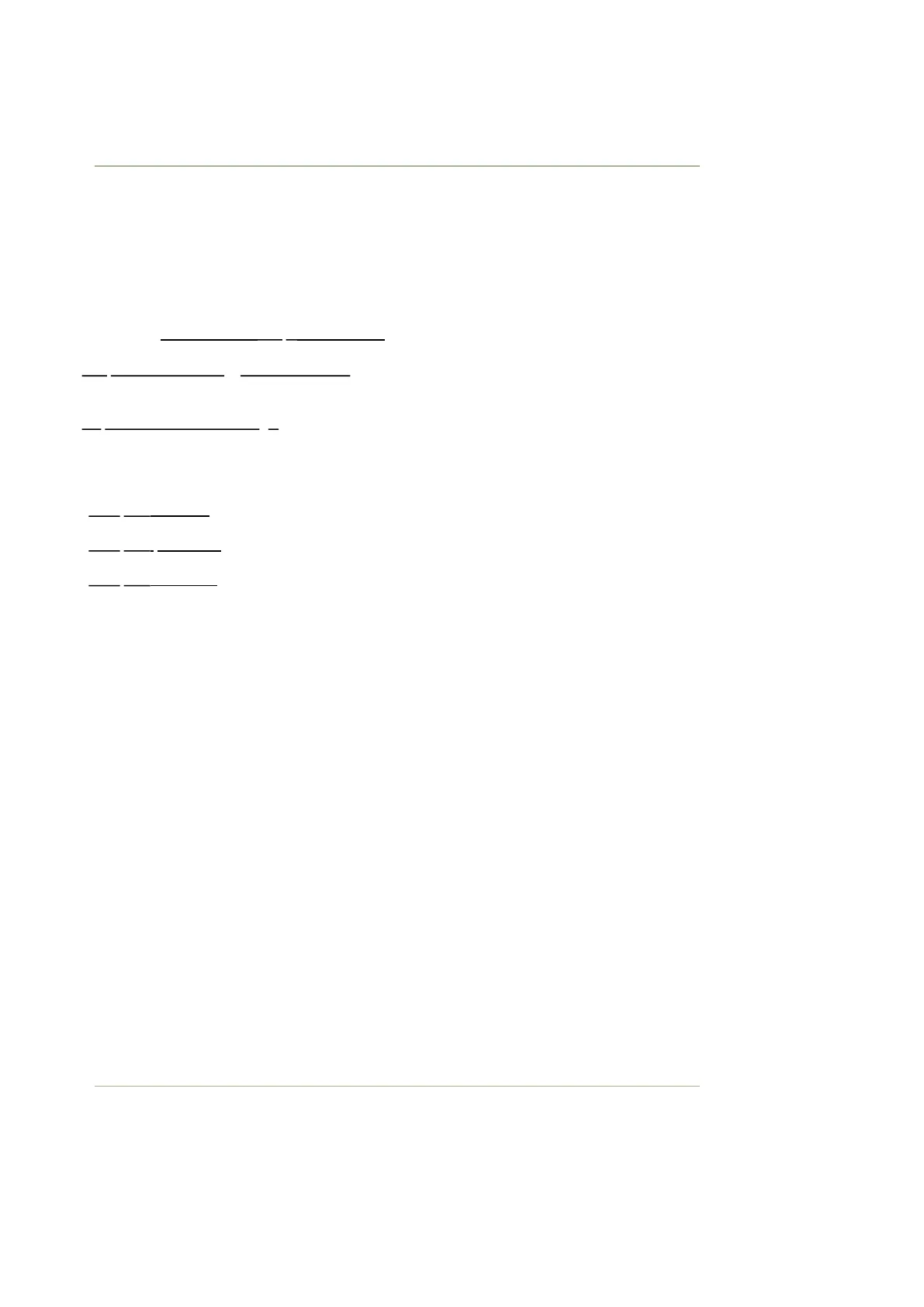
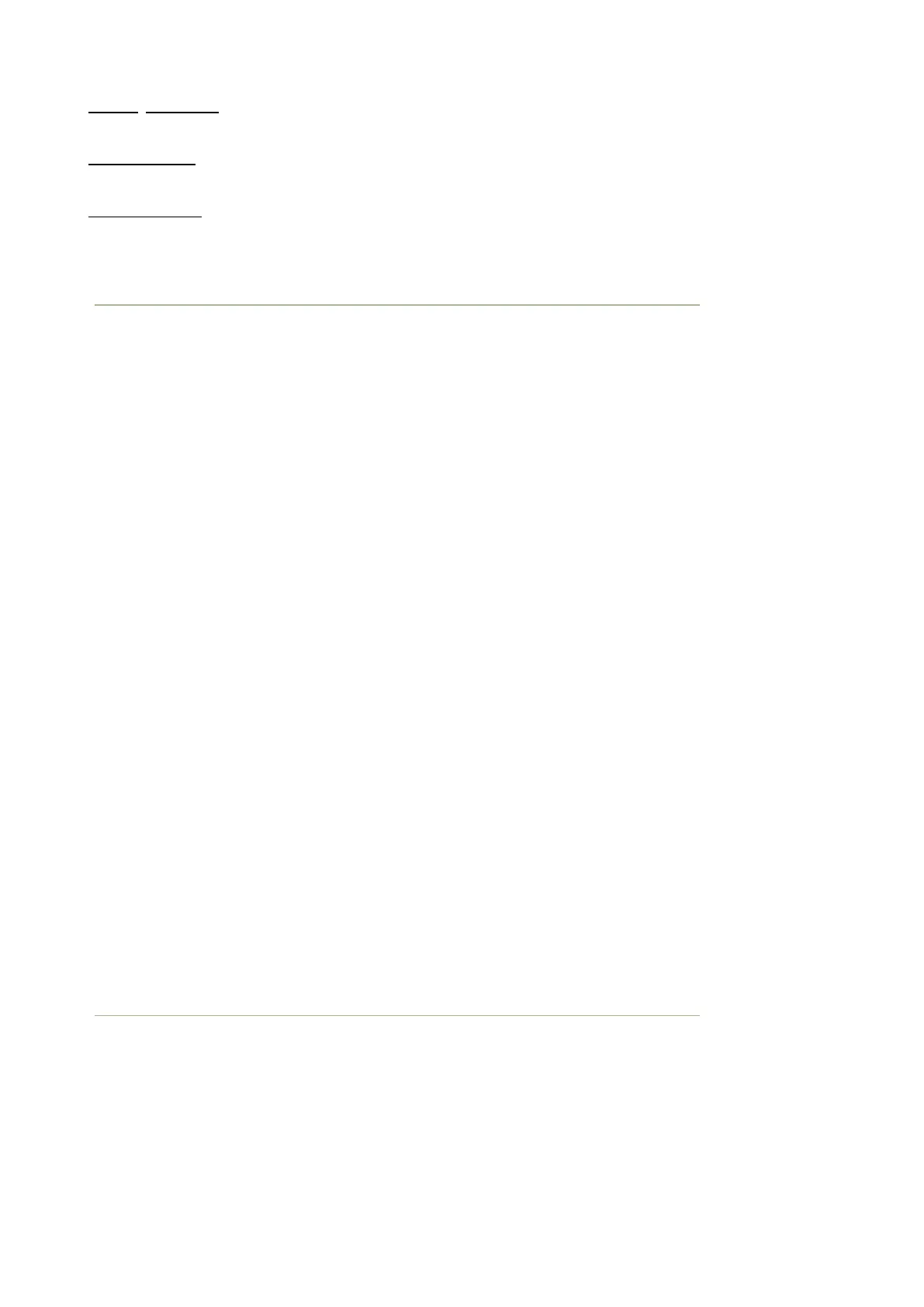
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
DIDATTICA GENERALE
CAPITOLO 1: DIDATTICA
La didattica è una disciplina antica che negli anni ha subito tante trasformazioni relativamente ai significati e alle procedure d'intervento. Nasce con la figura di Comenio intorno al XVII secolo in quanto egli crede che tutto possa essere insegnato a tutti, e a tutte le età. Il ruolo della didattica si modifica rispetto alle diverse correnti di pensiero, si è passati da una forte attenzione alla didattica nel periodo positivista dove si cercavano le risposte in maniera prescrittiva ( seconda metà dell'800) a una negazione di essa con il periodo idealista, l'insegnamento non può essere spiegato in quanto è legato al docente, non esistono norme prescritte (prima metà del 900). Negli ultimi 50 anni molti sono stati i cambiamenti:
- Va segnalata l'estensione nel campo della didattica, inizialmente circoscritta alla scuola e via via ampliata in settori informali (es. Scautismo, ambienti religiosi ... )
- La specificazione dell'oggetto della didattica che ha comportato la necessità di affiancare alla didattica generale tutta una serie di didattiche specifiche nei differenti settori disciplinari, ognuna con il proprio punto di vista d'osservazione e di intervento.
- La proliferazione di metodologie ha stimolato un approccio flessibile, in questa prospettiva la didattica non può fornire un modello universale che vada utilizzato in tutte le situazioni che lo necessitano. Serve varietà.
Da diversi anni l'educazione e la formazione sono oggetto di studio e di intervento di diverse discipline. Il pedagogista italiano Mauro Leang classifica quest'ultime in 3 categorie:
- Discipline rilevative: si occupano di indagare l'evento educativo nelle sue diverse dimensioni, allo scopo di migliorarne la comprensione (es. sociologia studia come si svolge l'educazione)
- Discipline prescrittive: queste discipline riconoscono i valori educativi sul quale la pratica educativa dovrebbe orientarsi (es. la filosofia)
- Discipline orientative: si collocano a metà tra i due gruppi precedenti (es. la didattica generale deve conoscere l'oggetto educativo [studio rilevativo], deve sapere come dovrebbe essere [studio prescrittivo] e si interroga sul come fare.
L'oggetto della didattica è l'azione di insegnamento che deve essere caratterizzata da INTENZIONALITÀ e SISTEMATICITÀ Intenzionalità: quando noi entriamo a scuola, il nostro agire è un'azione guidata sempre da un'intenzione didattica o educativa. Avere intenzionalità vuol dire che facciamo delle cose perché ci potano verso un traguardo formativo. (Non posso agire senza uno scopo finale - si pensi ai traguardi elencati nelle Indicazioni Nazionali) Sistematicità: intendiamo il pensare, il progettare e l'organizzare. Ho un'intenzione e progetto il percorso organizzando il momento educativo. (non posso improvvisare la pratica educativa, rischio di non centrare il tema) Sulla base di queste due parole chiave, si possono distinguere i contesti educativi che possiamo dividere in:
- Formali: caratterizzati da intenzionalità e sistematicità
- Informali: caratterizzati da intenzionalità e non sistematicità
- Non formali: non sono presenti caratteri intenzionali e sistematici
Quindi la didattica supera la dimensione prescrittiva dell'800, oggi si occupa di capire il processo di insegnamento-apprendimento per cercare delle strade per migliorare e rinnovare l'azione di insegnamento. L'insegnante assume un ruolo fondamentale in quanto diventa diretto testimone dell'azione didattica e lo studio deve avvenire partendo da una rielaborazione del vissuto dell'insegnante. In tale prospettiva, il ricercatore cambia e da esperto diviene partner, deve fornire gli strumenti per una corretta lettura dell'evento formativo.
CAPITOLO 2: RICERCA
L'espressione ricerca condensa un'alleanza tra l'insegnante e il ricercatore. L'idea di base si fonda sulla convinzione che ogni situazione è diversa e necessita di risposte differenti. Donald Schon nel 1993 pubblicò un volume chiamato "il professionista riflessivo". Il professionista è l'insegnante che diviene un buon docente solo quando, dopo aver programmato e attuato le proprie attività didattiche, assume un atteggiamento riflessivo durante e dopo l'azione. Il ricercatore deve fare ricerca-formazione (approccio recente), cioè una formazione che avviene in modo collaborativo con gli insegnanti a partire da una ricerca concreta sul quotidiano degli insegnanti. Il ruolo della didattica consiste nell'aiutare l'insegnante a rendere comunicabile il proprio sapere,fornendo strumenti per interpretare l'esperienza. Calidoni presenta tre visioni della didattica:
- Visione grammaticale: come la grammatica propone un modello di uso della lingua, così anche la didattica fornisce modelli finalizzati a guidare l'insegnante. L'approccio è descrittivo- normativo
- Visione sintattica: come la sintassi analizza le regole di composizione delle frasi, così la didattica fornisce strumenti finalizzati a scomporre e categorizzare l'evento per comprenderlo. L'approccio è descrittivo-nometico
- Visione semantica: come la semantica analizza i significati del codice linguistico, così la didattica esplora i significati sottesi dell'esperienza. L'approccio è di tipo narrativo.
CAPITOLO 3: INNOVAZIONE
Il concetto di innovazione è strettamente correlato a quello di ricerca. La circolarità tra l'azione e la ricerca avviene secondo una rielaborazione continua delle esperienze con lo scopo di migliorare. L'innovazione è un cambiamento di azioni che sono funzionali al miglioramento. Il processo di innovazione non vuole stravolgere l'intero sistema ma solo una parte di esso. L'innovazione richiede:
- FLESSIBILITÀ da parte delle scuole e del corpo docenti (c'è sempre molta resistenza al cambiamento per carico di lavoro e tradizione)
- VARIETÀ dei metodi, senza questo cambiamento non c'è innovazione
Il cambiamento pone al centro il soggetto che attua l'azione e la contestualità dell'ambiente in cui si lavora. Si tratta quindi di saper riconoscere le condizioni organizzative affinché una scuola possa innovarsi. Un altro tratto saliente riguarda la globalità, ovvero il coinvolgimento nell'evento innovativo dell'intero sistema (nella sua totalità). Infine, è necessario un dialogo costante e riflessivo, tra gli attori e il contesto, per tenere sempre presente qual è il senso del cambiamento che sta avvenendo. 7 Parole chiave dell'innovazione:
- Contrattualità, i soggetti devono operare all'interno di un mandato chiaro che definisca responsabilità modi e tempi di lavoro
- Gradualità, un'azione di miglioramento può partire solo dai livelli di maturazione già acquisiti
- Condivisione
- Negoziazione, occorre valorizzare la pluralità delle opinioni
- Supporto, un processo innovativo deve sempre essere guidato da azioni concrete
- Praticità, bisogna identificare chiaramente le azioni da sviluppare.
- Rivedibilità, il processo di miglioramento deve subire cambiamenti in corso d'opera, deve svilupparsi in base al contesto che muta
Hopkins afferma che la ricerca si muove in 3 direzioni:
- Ricerca sul miglioramento: la ricerca diviene un dispositivo utile per gestire l'azione didattica. Si pensi al cruscotto di un'auto che è in grado di regolare il funzionamento del sistema
- Ricerca per il miglioramento: la ricerca innesca il processo di rinnovamento e predispone le condizioni base che possono rendere concreto il cambiamento.
- Ricerca come miglioramento: la ricerca riflette sui comportamenti e ne produce di nuovi in un lavoro improntato sull'autorinnovamento.
Quando avviene il processo di innovazione è necessario documentare l'atto e condividere i risultati ottenuti, esplicitando i tratti salienti e i processi attuati.
CAPITOLO 4: DOCUMENTAZIONE
La documentazione consiste nel tramutare un'azione in un documento trasmissibile che può essere analizzato a posteriori. Parlare di documentazione significa affrontare la questione della memoria della nostra esperienza, trasformare il fare nel dire riuscendo a raccontarlo. La scuola ha sempre curato poco la documentazione della propria esperienza didattica o, meglio, lo ha fatto privilegiando un'ottica amministrativa. Infatti, quando si parla di documentazione i primi oggetti che vengono in mente sono il registro, la pagella, il PDP e il PEI. Quali sono le funzioni della documentazione?
- Funzione regolativa: indirizzo l'azione dell'insegnante
- funzione esplicativa: fornisce le chiavi di lettura per la comprensione dell'esperienza
- funzione narrativa: tende a raccontare l'esperienza i suoi significati. In quali fasi bisogna documentare?
- Ex ante: preparatoria all'azione
- Contestuale: durante l'azione
- Ex post: successiva all'azione
L' incrocio tra le funzioni e le fasi temporali consente di individuare 9 combinazioni differenti di documentazione:
- I piani, tentativo di anticipare lo sviluppo di un percorso didattico allo scopo di gestirlo con maggiore consapevolezza
- i criteri di qualità, documentazione che accompagna l'azione e svolge una funzione orientativa
- i prototipi, immagini preimpostate che propongono un modello già attuato in passato su cui sviluppare un nuovo tentativo d'azione
- le teorie precedono l'azione e sono uno strumento di comprensione dell'azione stessa. le teorie sono a loro volta sviluppate a partire dall' esperienza.
- le categorie di analisi accompagnano l'azione e forniscono delle chiavi di lettura
- le tipologie didattiche seguono l'azione e aiutano a riconoscere i tratti salienti dell'azione, classificandola e confrontandola.
- Le simulazioni anticipano l'azione a fini progettuali
- I protocolli osservativi accompagnano l'azione e svolgono una funzione narrativa di descrizione
- i diari di bordo, documentazione che segue l'azione che svolgono una funzione di ricostruzione del vissuto esperienziale.
CAPITOLO 5: AZIONE DI INSEGNAMENTO
L'azione di insegnamento è una relazione educativa finalizzata all'apprendimento in un contesto istituzionale. L'azione didattica richiama due concetti: La PRAXIS è un'azione che si orienta verso un fine etico e acquista valore in sé in quanto rappresenta un insieme di valori a cui si ispira. La morale si incarna attraverso l'azione: es missionario. La POIESIS è un'azione che vuole realizzare un prodotto concreto che acquista valore in base al risultato. Es: artigiano. Mentre l'azione pratica ha un fine in sé stessa, l'azione poietica raggiunge il suo scopo attraverso il prodotto che realizza. Damiano definisce l'azione di insegnamento sia pratica che poietica: la dimensione poietica si riferisce alle qualità tecniche e professionali dell'insegnante. La dimensione pratica richiama la valenza educativa dell'insegnamento. Definiamo ulteriormente l'azione dell'insegnamento: il prodotto dell'insegnamento non può essere l'apprendimento (es il bambino non è predisposto all'apprendimento se è in forte stato di stress) ma la mediazione didattica promossa dal docente. Con mediazione didattica intendiamo una forma di semplificazione della realtà nel quale quest'ultima viene sostituita da simulazioni allo scopo di facilitare l'apprendimento. Questa semplificazione ha criticità e punti di forza, se da un lato rappresenta una condizione facilitata di apprendimento, dall'altro può rappresentare un pericolo nel quale gli alunni tendono a dissociarsi dal contesto reale. Damiano si concentra sul metodo con cui si possono mettere in relazione i soggetti che devono apprendere e gli oggetti di studio. I mediatori didattici:
- attivi: tutte quelle occasioni nel quale facciamo fare un'esperienza diretta. (Es se voglio lavorare sugli alberi porto la classe al bosco urbano)
- analogici: sosteniamo l'apprendimento attraverso delle simulazioni, giochi di ruolo, drammatizzazioni (es. voglio lavorare sull'euro e organizzo una simulazione di pagamenti al mercato)
- iconici: rappresentazioni visive degli oggetti su cui vogliamo lavorare (es le mappe, i disegni)
- simbolici: sono le tabelle, le formule, quegli strumenti che utilizzano il canale verbale che sintetizzano i contenuti. Si sintetizza il contenuto con dei simboli.
I mediatori attivi sono quelli più vicini alla realtà mentre quelli simbolici rappresentano il maggior grado di distanza dal contesto reale. Ciascun mediatore è caratterizzato da punti di forza e debolezza. L'analisi comparata dei pregi e limiti porta a concludere che è necessario fare affidamento sulla pluralità dei linguaggi /mediatori.
CAPITOLO 6: DIMENSIONE METODOLOGICA
L'apprendimento secondo tre teorie:
- Comportamentismo: ritiene che ci sia apprendimento ogni qualvolta che si attua il cambiamento del comportamento. Quando il mio comportamento mi soddisfa allora tendo a mantenerlo tale. Quando però non ritengo che questo comportamento sia efficace allora avvio dei cambiamenti.