Appunti di Diritto Privato: Diritti Reali Minori e di Garanzia
Documento dall'Università di Torino su Appunti di Diritto Privato - Prof. Rossi. Il Pdf esamina i diritti reali minori come usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi, e i diritti reali di garanzia come pegno e ipoteca, per gli studenti universitari di Diritto.
Ver más63 páginas
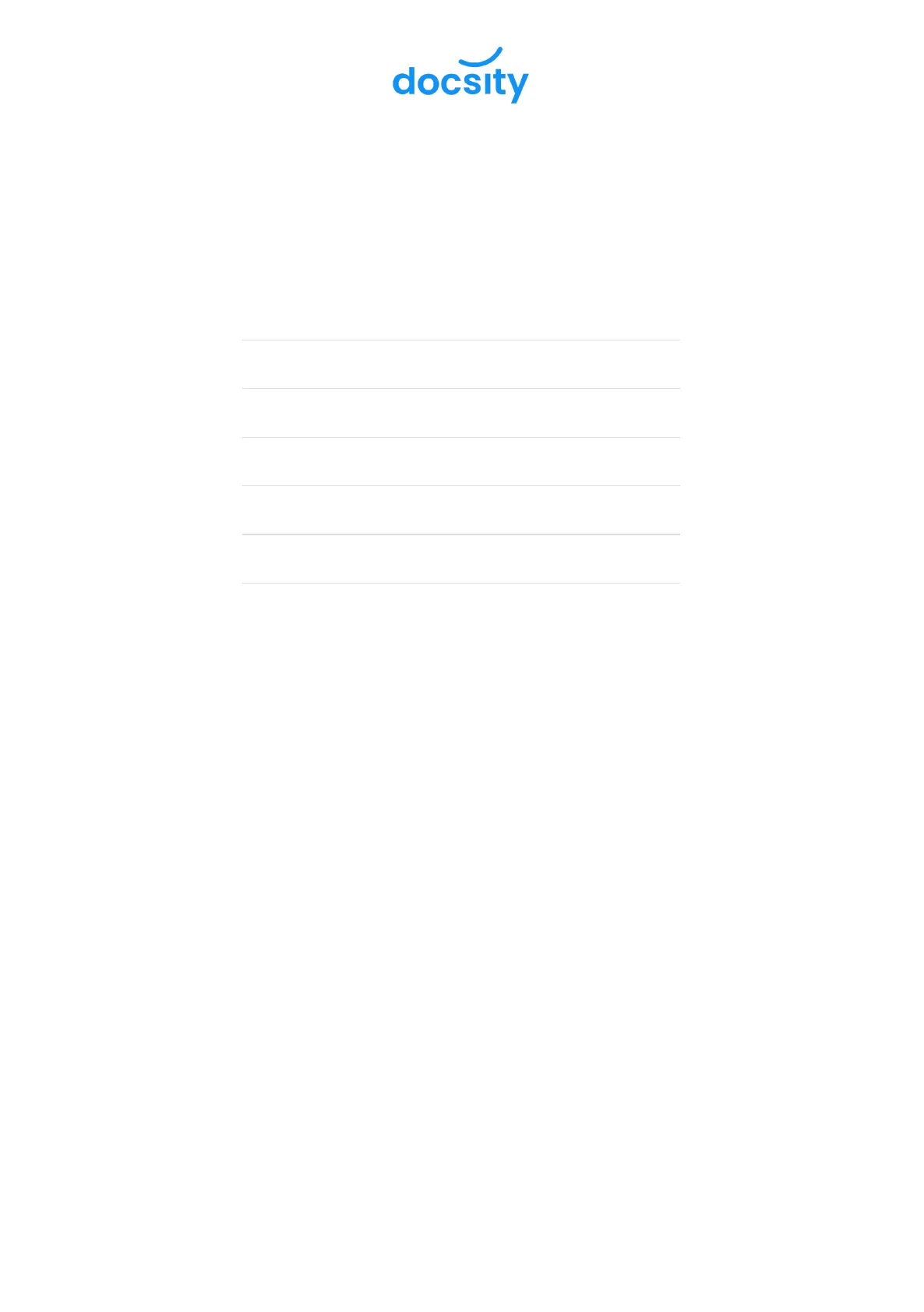
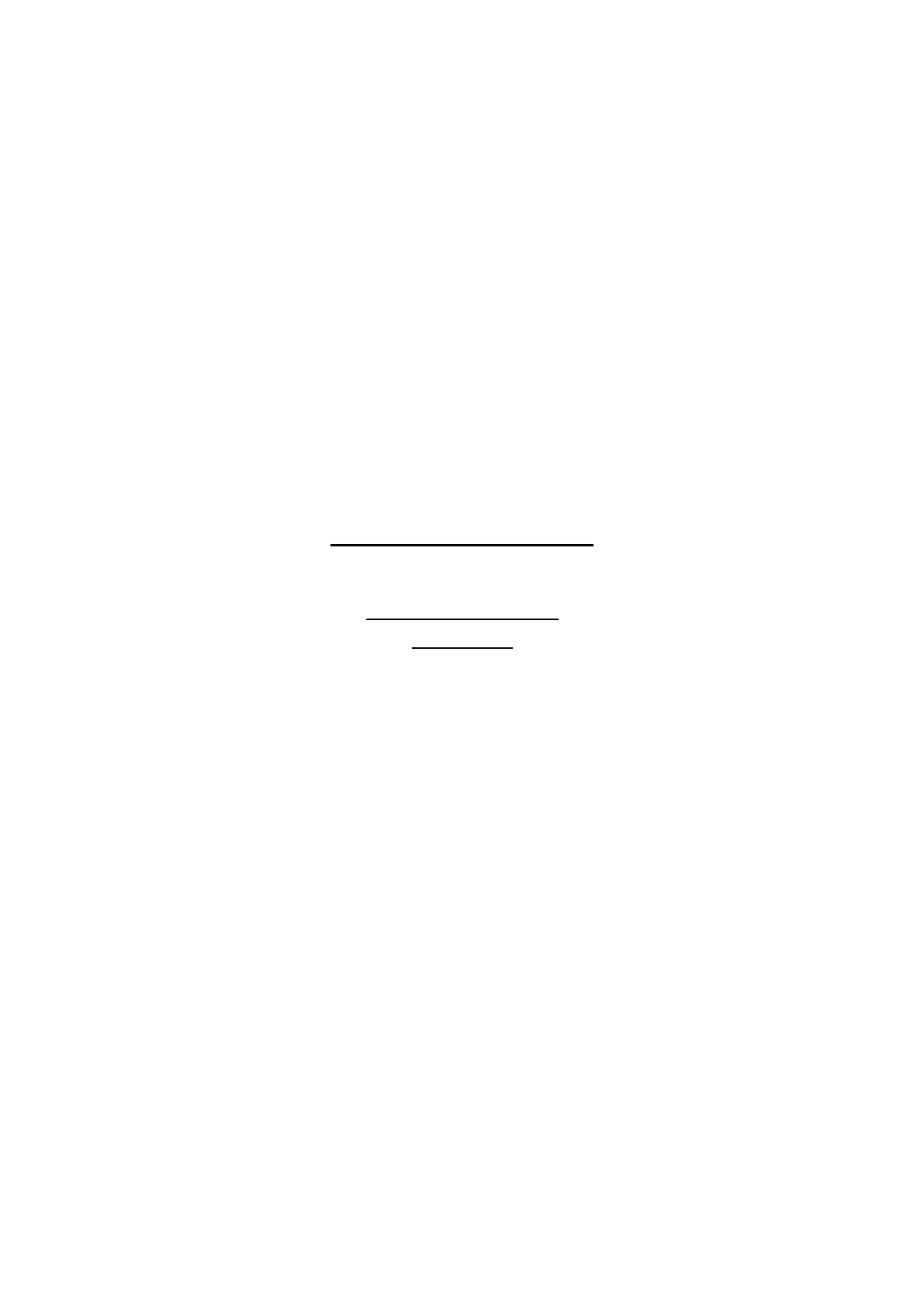
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
DIRITTO PRIVATO
INTRODUZIONE
La funzione del diritto privato
Possiamo definire il diritto come un mezzo di regolazione sociale, che ha la funzione di sistemare gli interessi individuali e collettivi presenti nella società, evitando o risolvendo i conflitti fra i portatori dei diversi interessi. Il diritto privato nasce spontaneamente ed è la matrice di tutti i diritti. Sorge perché esiste la socialità delle persone e può essere scritto (regole giuridiche) oppure può basarsi su consuetudini. Il diritto privato si afferma quando nasce un'organizzazione statuale ed è connaturato all'essere umano: è indispensabile per l'uomo e comprende tutto ciò che riguarda la vita delle persone. Esso è presente sempre, anche laddove non viene riconosciuto. Può essere anche scritto sotto forma di norme giuridiche. Il diritto privato è il diritto delle relazioni tra privati e ha due funzioni fondamentali: . La risoluzione dei conflitti è coincidente con la nascita dello Stato e nasce per garantire la coesistenza e l'ordine all'interno della società in modo naturale. C'è bisogno di regole per poter risolvere le controversie che possono nascere tra i soggetti. Le regole nascono per evitare i conflitti senza arrivare a delle conseguenze gravi. Il diritto è connaturato all'essere umano: esiste per far vivere le persone insieme. Il diritto privato esiste anche quando non è riconosciuto da nessuno e può avere delle regole molte diverse a seconda del posto. Esistono delle regole non scritte, le consuetudini. · La prevenzione dei conflitti è il frutto della riflessione di professori del diritto: essi studiano e creano delle regole volte a prevenire i conflitti. Alla luce dei modi migliori che vengono elaborati per risolvere i conflitti si può imparare e formulare delle regole che serviranno a evitare nuovi conflitti. È quindi, importante ricordare che non esiste società che possa essere priva di regole di diritto privato, proprio perché è questo che permette la convivenza pacifica tra i consociati e evitare che questi si facciano giustizia da soli. Le norme possono sorgere naturalmente, essere stabilite da un giudice o, come nel caso italiano, possono essere dovute a un'evoluzione storica e sono raccolte all'interno del Codice civile. In questo caso le norme sono state stabilite da un legislatore.
Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, compreso lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in posizione paritaria. Il diritto pubblico, invece, si occupa esclusivamente dei rapporti con Stato ed enti pubblici, quando siano in posizione di supremazia. Art 118/IV Cost: ha introdotto il principio di sussidiarietà, il principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenere l'azione. I cittadini, quindi, sulla base dell'articolo non devono solo subire le decisioni dello Stato, ma vengono visti come portatori di interessi, non solo individuali, ma anche generali. Grazie a questo articolo, perciò, se un cittadino può operare a vantaggio di un altro cittadino autonomamente lo Stato si deve ritirare. L'introduzione di tale principio si deve al passaggio da stato liberale a stato sociale, che ha portato a una grande rivoluzione dei rapporti tra diritto pubblico e privato.
Cosa copre il diritto privato?
- Diritti economici: gestione dei beni, contratti, obbligazioni, danni, funzionamento delle attività economiche;
- Diritti di famiglia;
- Successioni.
Le parole del diritto privato
Il diritto è frutto di una riflessione che si è evoluta nel tempo e che è in continuo mutamento. Avendo, quindi, una storia molto antica, ha un linguaggio specialistico molto preciso, il linguaggio giuridico. Esso non è particolare solo perché vive da moltissimo, ma anche perché deve cercare il più possibile di evitare ambiguità e polisemie o ambiguità semantiche, per ridurre al minimo l'insorgere di incomprensioni e condanne sbagliate. Esso prende i termini del linguaggio ordinario e lo trasforma in un linguaggio tecnico e tendenzialmente univoco. Questo avviene in due modi: · si prendono termini del linguaggio ordinario che vengono "risemantizzati": si modifica il loro significato più comune. Per esempio, la "conclusione" di un contratto non significa che esso sta terminando, ma che ho definito tutti i termini. La conclusione del contratto è il momento in cui esso, di fatto, entra in vigore. Altro esempio: la "decadenza" nel diritto privato è l'impossibilità di esercitare un diritto se non vengono rispettati determinati limiti o requisiti; · A volte si ha la creazione di parole ex novo. Per esempio, la "fattispecie", nel diritto, è quel caso concreto che viene astratto nella misura necessaria da poter essere sussunto in una regola di diritto. Di solito, la norma contiene la descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che quella descrizione possa adattarsi a una moltitudine di eventi storici, i quali presentino tutti quegli elementi caratteristici. Tale descrizione è la fattispecie astratta. Il verificarsi concretamente di un evento rientrante nella descrizione contenuta nella norma è la fattispecie concreta, che può essere inquadrata nelle fattispecie astratta della norma. L'operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponde a una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie (concreta). Nel diritto ogni parola, quindi, ha un preciso significato. Non solo: le parole correlate tra loro in modi diversi acquisiscono dei significati specifici. Per questo si devono saper usare le parole conoscendo esattamente il loro significato. Il diritto privato è un sistema di regole, quindi, che parte da un linguaggio specialistico, il quale identifica determinati tipi di nozioni che devono essere molto chiare e coordinate tra di loro. Al di là della chiarezza, occorre che le leggi siano coordinate tra di loro, cioè che non esistono antinomie, perché questo, ovviamente, metterebbe a repentaglio la certezza del diritto. Nella realtà il diritto privato è un sistema molto complesso e le leggi non derivano da un unico testo o da un solo ordinamento: per questo abbiamo tanti sistemi di regole che non necessariamente sono coerenti. In realtà è l'interpretazione che garantisce la coerenza, proprio perché in sistemi tanto complessi è difficile che sia effettivamente garantita. Per questo, al fine di una sicura e solida interpretazione, si deve essere in grado di riconoscere le regole e le loro interdipendenze.
Norma giuridica
Una delle nozioni fondamentali del diritto è la definizione di norma giuridica: essa è un comando giuridico, una regola, le cui caratteristiche base sono: · generalità -> non esistono norme ad personam. C'è la legge che vale per tutti e leggi che interessano delle minoranze o categorie; · astrattezza -> non si fa riferimento a tutti i casi concreti. Si tratta di due aspetti fondamentali della norma, perché le permettono di essere applicata in una molteplicità di casi diversi. Il principio del neminem ledere: chi provoca dei danni a qualcuno deve risarcirlo, per esempio, è un principio generale, alla base dell'articolo della responsabilità del Codice civile. Ciò che caratterizza una norma giuridica, inoltre, è la coattività/coercibilità, e quindi il fatto che sia prevista una sanzione stabilita dalla legge stessa. È proprio la presenza di una sanzione, infatti, che costituisce l'elemento distintivo tra norme sociali e giuridiche. Si tratta, tuttavia, di un principio generale: anche nell'ordinamento italiano, infatti, ci sono norme che non prevedono sanzione. Questo può essere dovuto a una decisione del legislatore o, il più delle volte, può essere dovuto a un errore in fase di stesura della norma giuridica. Nell'ambito del diritto privato, la norma è un comando che può non avere nessuna sanzione. Le norme possono essere imperative (c'è l'obbligo di rispettarle) oppure dispositive (è a scelta dell'individuo).
LE FONTI DEL DIRITTO E L'INTERPRETAZIONE
Il diritto ambisce ad essere un sistema di regole coerenti, ma per farlo necessità dell'interpretazione. Nell'ambito dell'interpretazione delle fonti, dobbiamo tener conto di una pluralità di fonti da cui promanano regole giuridiche da interpretare. Nel regolamento italiano dobbiamo distinguere: · Fonti di diritto interno • Fonti di diritto internazionale · Fonti di diritto dell'Unione Europea, che sono internazionali ma con caratteristiche suis generis. Tutti gli ordinamenti giuridici risultano dall'operare congiunto di fonti di produzione e di fonti sulla produzione del diritto. La costituzione/legge è la fonte di produzione di base perché pone in essere le regole/il diritto. · Fonti di produzione -> contengono e producono regole giuridiche che producono effetti verso l'esterno, regole indirizzate alla collettività; · Fonti sulla produzione -> creano regole giuridiche che vanno rispettate, ma sono atti o fatti che hanno uno scopo preciso: stabilire regole non rivolte alla collettività, ma a coloro che producono il diritto -> articolo 138, rivolto alle camere.
Fonti del diritto interno
Distinguiamo secondo lo schema piramidale: · Costituzione; · Leggi ordinarie ed altri atti con forza di legge; · Regolamenti; · Usi e consuetudini;
La costituzione
La costituzione è entrata in vigore il 1º gennaio 1948 e consta in 139 articoli strutturati in un modo particolare: ➢ 1-12: principi fondamentali -> percepita come radicalmente immutabile; ➢ 3-54: Parte prima: diritti e doveri dei cittadini -> qui si collocano (e in parte tra i principi fondamentali) i diritti fondamentali che hanno a che fare con le libertà, l'uguaglianza ed altri. Vengono trattati anche il tema della proprietà, delle attività economiche e della vita di famiglia, in merito ai quali si fondano i principi cardine che poi fungono da ispirazione al resto delle norme, include quelle del Codice civile. Le principali: · principio di uguaglianza (art. 3); · libertà di associazione (art. 18); ▪ diritto di proprietà (art. 42); libertà di iniziativa economica (art. 41); · famiglia (artt. 29, 30, 31). ➢ 55-139: Parte seconda: ordinamento della repubblica -> aspetti organizzativi; ➢ 18 disposizioni transitorie e finali.
Le fonti primarie
Le fonti primarie sono le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi e le leggi regionali.
Il Codice civile
Il diritto privato può essere contenuto in tante norme di materia differente, ma in Italia la maggior parte delle norme di diritto privato è contenuta nel Codice civile del 1942. Esso è strutturato in 6 libri, che ricalcano i vari ambiti della vita sociale di un cittadino. La prima parte del Codice civile contiene le disposizioni sulla legge in generale (preleggi), che introducono i sei libri. Qui troviamo regole sull'interpretazione, la vigenza e altri. Oggi queste disposizioni vanno lette insieme alle norme costituzionali e per il principio gerarchico prevalgono quelle costituzionali. I sei libri ricalcano la vita che un individuo può avere nell'ambito della società: 1. Delle persone e della famiglia: si apre con la nascita delle persone, che porta alla formazione di una famiglia; 2. Delle successioni: si occupa di cosa succede con la morte delle persone; 3. Della proprietà: riguarda le tematiche relative ai beni che possono oggetto di diritto; 4. Delle obbligazioni: riguarda i temi dei contratti e degli impegni assunti; 5. Del lavoro: riguarda tutti gli aspetti del lavoro. Nel 1942 (secondo codice civile dall'unità) si è fatta la scelta della commercializzazione del diritto privato. Nella maggior parte degli Stati, infatti, il diritto del lavoro non fa parte del Codice civile, ma con questa scelta si è deciso di includere tutti i diritti del lavoro nel codice civile. Le regole del codice del commercio sono state abrogate e inserite nel Codice civile. Tiene conto anche dei diritti sindacali, del diritto societario e del diritto d'impresa. 6. Della tutela dei diritti: riguarda le regole volte a far valere i propri diritti.