I tre modelli teorici evolutivi nell'interpretazione delle problematiche in età evolutiva
Documento di Università sui modelli teorici evolutivi nell'interpretazione delle problematiche in età evolutiva. Il Pdf, di Psicologia, esplora i modelli del tratto, ambientale e transazionale, analizzando disturbi esternalizzanti come l'ADHD e il disturbo dello spettro autistico, con eziologia e manifestazioni cliniche.
Ver más17 páginas
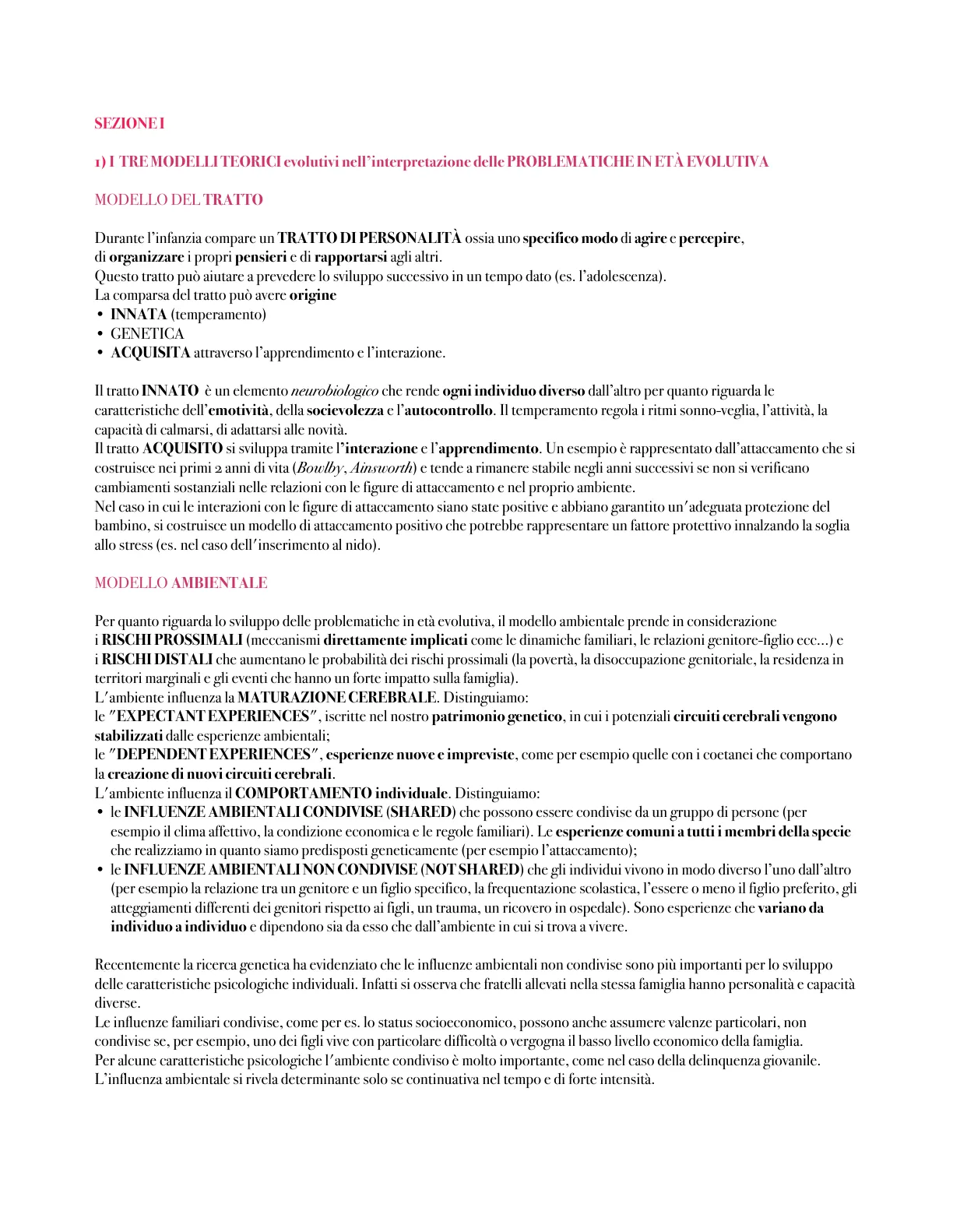
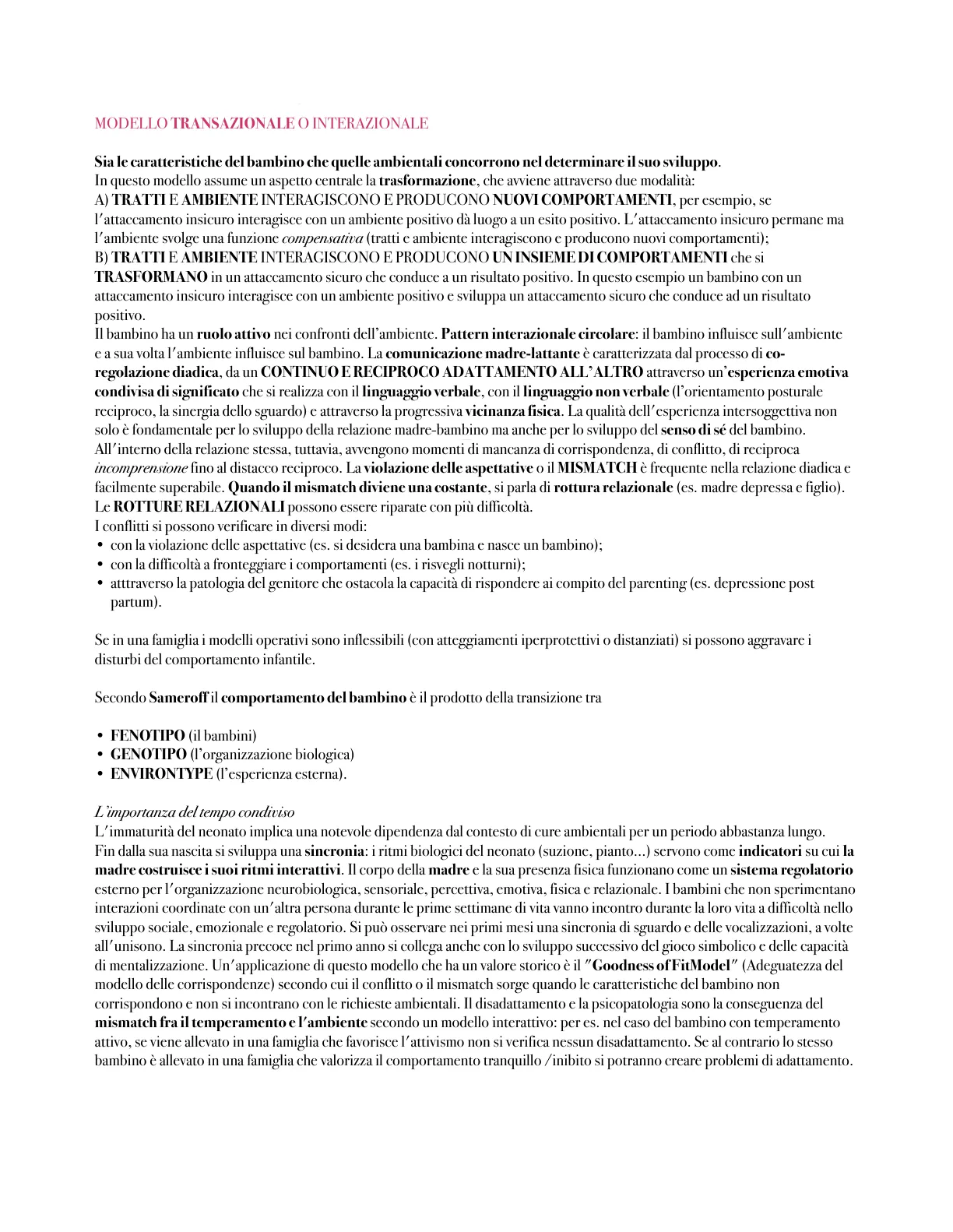
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
I tre modelli teorici evolutivi
MODELLO DEL TRATTO
Durante l'infanzia compare un TRATTO DI PERSONALITÀ ossia uno specifico modo di agire e percepire, di organizzare i propri pensieri e di rapportarsi agli altri. Questo tratto può aiutare a prevedere lo sviluppo successivo in un tempo dato (es. l'adolescenza). La comparsa del tratto può avere origine
- INNATA (temperamento)
- GENETICA
- ACQUISITA attraverso l'apprendimento e l'interazione.
Il tratto INNATO è un elemento neurobiologico che rende ogni individuo diverso dall'altro per quanto riguarda le caratteristiche dell'emotività, della socievolezza e l'autocontrollo. Il temperamento regola i ritmi sonno-veglia, l'attività, la capacità di calmarsi, di adattarsi alle novità. Il tratto ACQUISITO si sviluppa tramite l'interazione e l'apprendimento. Un esempio è rappresentato dall'attaccamento che si costruisce nei primi 2 anni di vita (Bowlby, Ainsworth) e tende a rimanere stabile negli anni successivi se non si verificano cambiamenti sostanziali nelle relazioni con le figure di attaccamento e nel proprio ambiente. Nel caso in cui le interazioni con le figure di attaccamento siano state positive e abbiano garantito un'adeguata protezione del bambino, si costruisce un modello di attaccamento positivo che potrebbe rappresentare un fattore protettivo innalzando la soglia allo stress (es. nel caso dell'inserimento al nido).
MODELLO AMBIENTALE
Per quanto riguarda lo sviluppo delle problematiche in età evolutiva, il modello ambientale prende in considerazione i RISCHI PROSSIMALI (meccanismi direttamente implicati come le dinamiche familiari, le relazioni genitore-figlio ecc ... ) e i RISCHI DISTALI che aumentano le probabilità dei rischi prossimali (la povertà, la disoccupazione genitoriale, la residenza in territori marginali e gli eventi che hanno un forte impatto sulla famiglia). L'ambiente influenza la MATURAZIONE CEREBRALE. Distinguiamo: le "EXPECTANT EXPERIENCES", iscritte nel nostro patrimonio genetico, in cui i potenziali circuiti cerebrali vengono stabilizzati dalle esperienze ambientali; le "DEPENDENT EXPERIENCES", esperienze nuove e impreviste, come per esempio quelle con i coetanei che comportano la creazione di nuovi circuiti cerebrali. L'ambiente influenza il COMPORTAMENTO individuale. Distinguiamo:
- le INFLUENZE AMBIENTALI CONDIVISE (SHARED) che possono essere condivise da un gruppo di persone (per esempio il clima affettivo, la condizione economica e le regole familiari). Le esperienze comuni a tutti i membri della specie che realizziamo in quanto siamo predisposti geneticamente (per esempio l'attaccamento);
- le INFLUENZE AMBIENTALINON CONDIVISE (NOT SHARED) che gli individui vivono in modo diverso l'uno dall'altro (per esempio la relazione tra un genitore e un figlio specifico, la frequentazione scolastica, l'essere o meno il figlio preferito, gli atteggiamenti differenti dei genitori rispetto ai figli, un trauma, un ricovero in ospedale). Sono esperienze che variano da individuo a individuo e dipendono sia da esso che dall'ambiente in cui si trova a vivere.
Recentemente la ricerca genetica ha evidenziato che le influenze ambientali non condivise sono più importanti per lo sviluppo delle caratteristiche psicologiche individuali. Infatti si osserva che fratelli allevati nella stessa famiglia hanno personalità e capacità diverse. Le influenze familiari condivise, come per es. lo status socioeconomico, possono anche assumere valenze particolari, non condivise se, per esempio, uno dei figli vive con particolare difficoltà o vergogna il basso livello economico della famiglia. Per alcune caratteristiche psicologiche l'ambiente condiviso è molto importante, come nel caso della delinquenza giovanile. L'influenza ambientale si rivela determinante solo se continuativa nel tempo e di forte intensità.
MODELLO TRANSAZIONALE O INTERAZIONALE
Sia le caratteristiche del bambino che quelle ambientali concorrono nel determinare il suo sviluppo. In questo modello assume un aspetto centrale la trasformazione, che avviene attraverso due modalità: A) TRATTI E AMBIENTE INTERAGISCONO E PRODUCONO NUOVI COMPORTAMENTI, per esempio, se l'attaccamento insicuro interagisce con un ambiente positivo dà luogo a un esito positivo. L'attaccamento insicuro permane ma l'ambiente svolge una funzione compensativa (tratti e ambiente interagiscono e producono nuovi comportamenti); B) TRATTI E AMBIENTE INTERAGISCONO E PRODUCONO UN INSIEME DI COMPORTAMENTI che si TRASFORMANO in un attaccamento sicuro che conduce a un risultato positivo. In questo esempio un bambino con un attaccamento insicuro interagisce con un ambiente positivo e sviluppa un attaccamento sicuro che conduce ad un risultato positivo. Il bambino ha un ruolo attivo nei confronti dell'ambiente. Pattern interazionale circolare: il bambino influisce sull'ambiente e a sua volta l'ambiente influisce sul bambino. La comunicazione madre-lattante è caratterizzata dal processo di co- regolazione diadica, da un CONTINUO E RECIPROCO ADATTAMENTO ALL'ALTRO attraverso un'esperienza emotiva condivisa di significato che si realizza con il linguaggio verbale, con il linguaggio non verbale (l'orientamento posturale reciproco, la sinergia dello sguardo) e attraverso la progressiva vicinanza fisica. La qualità dell'esperienza intersoggettiva non solo è fondamentale per lo sviluppo della relazione madre-bambino ma anche per lo sviluppo del senso di sé del bambino. All'interno della relazione stessa, tuttavia, avvengono momenti di mancanza di corrispondenza, di conflitto, di reciproca incomprensione fino al distacco reciproco. La violazione delle aspettative o il MISMATCH è frequente nella relazione diadica e facilmente superabile. Quando il mismatch diviene una costante, si parla di rottura relazionale (es. madre depressa e figlio). Le ROTTURE RELAZIONALI possono essere riparate con più difficoltà. I conflitti si possono verificare in diversi modi:
- con la violazione delle aspettative (es. si desidera una bambina e nasce un bambino);
- con la difficoltà a fronteggiare i comportamenti (es. i risvegli notturni);
- atttraverso la patologia del genitore che ostacola la capacità di rispondere ai compito del parenting (es. depressione post partum).
Se in una famiglia i modelli operativi sono inflessibili (con atteggiamenti iperprotettivi o distanziati) si possono aggravare i disturbi del comportamento infantile. Secondo Sameroff il comportamento del bambino è il prodotto della transizione tra
- FENOTIPO (il bambini)
- GENOTIPO (l'organizzazione biologica)
- ENVIRONTYPE (l'esperienza esterna).
L'importanza del tempo condiviso
L'immaturità del neonato implica una notevole dipendenza dal contesto di cure ambientali per un periodo abbastanza lungo. Fin dalla sua nascita si sviluppa una sincronia: i ritmi biologici del neonato (suzione, pianto ... ) servono come indicatori su cui la madre costruisce i suoi ritmi interattivi. Il corpo della madre e la sua presenza fisica funzionano come un sistema regolatorio esterno per l'organizzazione neurobiologica, sensoriale, percettiva, emotiva, fisica e relazionale. I bambini che non sperimentano interazioni coordinate con un'altra persona durante le prime settimane di vita vanno incontro durante la loro vita a difficoltà nello sviluppo sociale, emozionale e regolatorio. Si può osservare nei primi mesi una sincronia di sguardo e delle vocalizzazioni, a volte all'unisono. La sincronia precoce nel primo anno si collega anche con lo sviluppo successivo del gioco simbolico e delle capacità di mentalizzazione. Un'applicazione di questo modello che ha un valore storico è il "Goodness of FitModel" (Adeguatezza del modello delle corrispondenze) secondo cui il conflitto o il mismatch sorge quando le caratteristiche del bambino non corrispondono e non si incontrano con le richieste ambientali. Il disadattamento e la psicopatologia sono la conseguenza del mismatch fra il temperamento e l'ambiente secondo un modello interattivo: per es. nel caso del bambino con temperamento attivo, se viene allevato in una famiglia che favorisce l'attivismo non si verifica nessun disadattamento. Se al contrario lo stesso bambino è allevato in una famiglia che valorizza il comportamento tranquillo /inibito si potranno creare problemi di adattamento.
Fattori di rischio e protezione per lo sviluppo del bambino
Durante il suo sviluppo un individuo può essere a contatto con fattori di RISCHIO o fattori di PROTEZIONE che possono aumentare o diminuire la probabilità dell'insorgere di un comportamento disadattivo o di una psicopatologia. Individuare tempestivamente la presenza di rischi psicosociali permette di migliorare e di PREVENIRE il disadattamento infantile. I FATTORI DI RISCHIO per lo sviluppo del bambino possono essere: monogenitorialità, abusi e maltrattamenti, psicopatologia del genitore, situazione socio-economico-culturale svantaggiata, relazione negativa tra la coppia. Il RISCHIO SOCIO-DEMOGRAFICO è costituito da basso livello socio-economico, situazioni di maltrattamento, eventi traumatici e un tasso elevato di attaccamenti disorganizzati nei bambini provenienti da queste tipologie familiari. I fattori di rischio tendono a presentarsi in modo associato. LE MADRI ADOLESCENTI: spesso sono soggette all'abuso di sostanze e sintomi depressive e i loro figli mostrano spesso deficit cognitivi e socioemotivi. I bambini esposti a condizioni psicopatologiche genitoriali rischiano di incorrere in esiti di sviluppo disadattivi. ABUSO DI SOSTANZE: l'esposizione in utero alla sostanza stupefacente può avere diversi effetti. Uno studio recente su primati esposti in utero alla cocaina ha dimostrato un'effettiva riduzione nella densità e nel numero di neuroni nella corteccia cerebrale. L'esposizione in utero a cannabinoidi ha mostrato permanenti disregolazioni. Bambini che nascono da madri che fanno uso di sostanze durante la gravidanza possono essere affetti da sindrome alcolico fetale o da sindrome fetale da abuso di sostanze. MALTRATTAMENTO INFANTILE: le conseguenze tendono a persistere anche in età adulta. Tali implicazioni sono riferite a modificazioni sul piano neurobiologico, a ritardi cognitivi, a comportamenti disfunzionali ed allo sviluppo di quadri disfunzionali. Queste situazioni possono condurre il bambino a sviluppare strategie difensive (come l'evitamento e il freezing) o comportamenti autoconsolatori (suzione del pollice, toccarsi i capelli) già dai primi mesi di vita, per compensare la mancanza di empatia e attenzione che dovrebbero dare loro i caregiver. I FATTORI DI PROTEZIONE per lo sviluppo del bambino sono: buona relazione della coppia, buona condizione socio- economica-culturale, supporto extra-familiare, le figure alternative con cui potersi identificare, l'assenza di conflitto, l'attaccamento sicuro, il temperamento, il Locus of control, resilienza, cioè la capacità di adattarsi in modo adeguato e di avere uno sviluppo nella norma nonostante l'aver vissuto situazioni avverse. Vi sono tre fattori di protezione che possono, in condizioni di rischio, consentire uno sviluppo sano e nella norma:
- FATTORI PERSONALI (temperamento facile, buon adattamento, autostima e autoefficacia, locus of control interno e resilienza);
- CONTESTO AMBIENTALE (ambiente caloroso, attaccamento sicuro con i caregiver);
- CONTESTO SOCIALE(buon vicinato, supporto extra-familiare, sistemi scolastici efficaci).
Strumenti per valutare un bambino
L'infanzia e l'adolescenza sono periodi di cambiamenti in cui un sintomo può essere l'espressione di una transizione evolutiva normale o il segno di una emergente psicopatologia, dunque il criterio diagnostivo può essere instabile. Il processo diagnostico deve prevedere diverse fonti di informazione e deve considerare sia la classificazione dei disturbi sia la valutazione degli individui. Per quanto riguarda la prima infanzia e l'età scolare devono essere inclusi nel processo di valutazione:
- Colloqui clinici o interviste con i genitori;
- Valutazione del funzionamento psicologico del bambino;
- Osservazione delle dinamiche familiari e dei pattern d'interazione.
Per quanto concerne l'adolescenza la valutazione deve tenere conto della fase evolutiva che vede contrapposte le spinte verso l'autonomia e la dipendenza dalla famiglia. Per questa ragione si sviluppano 2 settings paralleli:
- uno che consideri l'intero setting familiare, quindi l'impatto dell'adolescenza sulle dinamiche familiari
- uno che consideri di piu lo spazio personale. Esplorare le capacitá di sperimentare e mantenere relazioni familiari a amicali.