Storia delle città italiane dal Tardoantico al primo Rinascimento, UNIMI
Documento dall'Università degli Studi di Milano sulla storia delle città italiane dal Tardoantico al primo Rinascimento. Il Pdf esplora le trasformazioni urbane, politiche e sociali, con un focus sui periodi gotico e longobardo, per il corso di Storia a livello universitario.
Mostra di più43 pagine
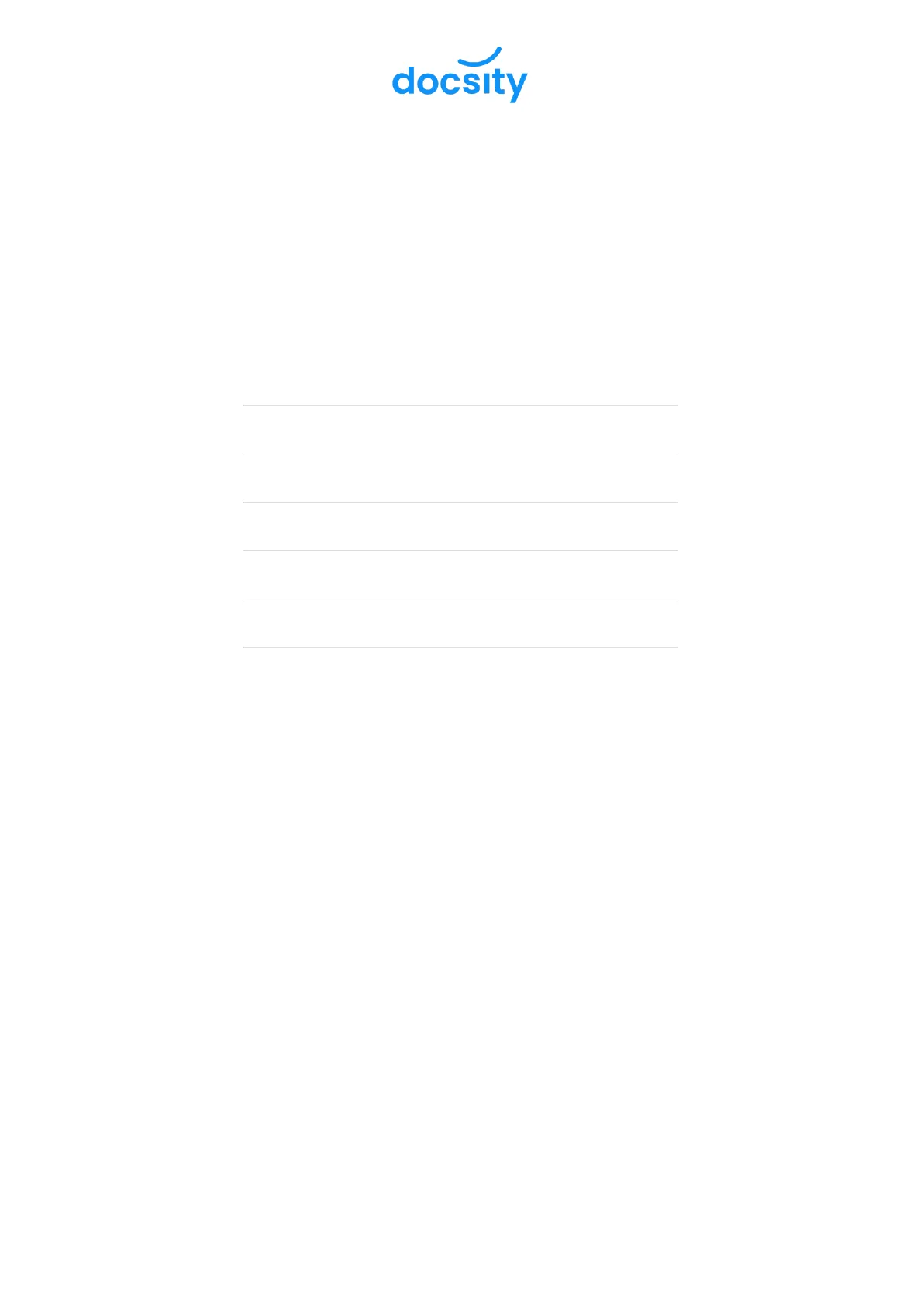

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Definizione di città
La città è il frutto delle trasformazioni che la società che le abita ha saputo imprimerle attraverso i tempi, ma la società è, a sua volta, il frutto delle trasformazioni politiche, istituzionali, economiche, culturali, spirituali che ha vissuto.
In passato i Romani distinguevano la struttura fisica (urbs) dagli abitanti che godevano del diritto di cittadinanza (civitas). Del diritto di cittadinanza godevano tutti gli abitanti dell'Italia ma dal 212 d.C. con la Costitutio Antoniana il diritto venne esteso a tutti gli abitanti dell'Impero. Questa concessione giuridica unifica tutti gli abitanti del territorio, coloro che abitavano all'interno e all'esterno dell'urbs. Il termine città, infatti, indica oggi l'insieme delle pietre e delle persone.
Ancora nel VII secolo Isidoro di Siviglia nelle sue Etymologiae, distingueva fra urbs (costituita dagli edifici) e civitas (costituita dagli abitanti); anche se a poco a poco il termine civitas comincia ad assorbire, per metonimia, quello di urbs.
Nel Medioevo andava approfondendosi il solco fra città e campagna circostante. Urbs e oppidum acquistarono più rilievo della civitas che andò affievolendosi a causa dell'affermarsi dell'autorità civile del vescovo nelle città e quella del conte nel territorio.
Così gli abitanti del territorio diventarono dei comitatini (cioè residenti nel comitatus, il territorio dipendente dal comes, il conte) e quelli all'interno delle mura divennero i vicini. Le mura non erano più strumento di difesa ma servivano a controllare chi entrava e chi usciva dalla città.
Tra la fine dell'XI secolo e per tutto il XII, glia abitanti dell'interno delle mura, che chiamvano se stessi cives, conquistarono il territorio circostante, che divenne dipendente dalla città dominante e gli abitanti sottoposti ad oneri personali e reali in favore della città. Ma esistevano anche i Comuni rurali che godettero di forme di autonomia locale prima di essere conquistate dalle città dominanti.
Il Duecento fu il grande secolo dei Comuni italiani, una stagione di prosperità economica ma anche di tensioni politiche che portarono al collasso i governi cittadini in favore di governi costituiti da una sola famiglia: le signorie (Estensi - Ferrara, Gonzaga - Mantova, Torriani e poi Visconti - Milano, Medici - Firenze).
Nel XV secolo le città più forti economicamente, politicamente e militarmente diedero vita alla formazione di stati regionali (Sforza in Lombardia, Medici in Toscana) che inglobarono comuni autonomi limitrofi in un contesto di dipendenza politica pur mantenendo autonomia nella gestione interna.
Nei secoli successivi si andò consolidando una gerarchia fra i centri abitati: come i nobili costituivano l'elite cittadina, le città costituivano l'apice della gerarchia fra le comunità.
Le città che facevano parte dei territori peninsulare e insulari a sud dello Stato della Chiesa non conobbero la fase politica dell'autonomia cittadina nelle forme e con l'intensità dei Comuni dell'Italia centro-settentrionale.
Oggi il titolo di città non ha alcun rilievo istituzionale, ma solo valore onorifico.
Dopo l'Unità d'Italia tutti i comuni furono sottoposti al controllo dello stato centrale e regolati tutti secondo uno stesso modello.
La Costituzione italiana attualmente in vigore ha abrogato tutte le disposizioni riguardanti il conferimento dei titoli nobiliari. Il titolo è privo di effetti giuridici ma è un titolo onorifico e viene conferito dal Presidente della Repubblica.
La storiografia urbanistica attuale è convinta che non sia possibile definire la città, perché la considera come un'unità che comprende gli edifici e le strade, ma anche gli uomini e le donne, con tutto il complesso sociale, economico, istituzionale, culturale e religioso che ha contribuito a trasformarla.
Tuttavia sappiamo tutti cos'è una città, la riconosciamo, sia nella sua valenza fisica sia in quella sociale, politica ed economica.
La città è uno stato d'animo, cioè è tale solo quando i suoi abitanti sono consapevoli di appartenervi e di sentirsi dei cittadini.
L'UNESCO con la Carta di Venezia del 1964 ha chiarito che il concetto di monumento storico abbraccia non solo i singoli oggetti architettonici ma anche l'ambiente urbano e rurale in cui sono collocati; infatti nella lista UNESCO appaiono intere città: Firenze, Venezia, Napoli, Ferrara, Verona, Urbino, Siena, Verona.
Fonti per la storia delle città
La storia è l'insieme degli avvenimenti accaduti e la storiografia è la ricostruzione e il racconto di quegli avvenimenti. Lo storico è l'interprete dei fatti che ricostruisce: l'attività di ricostruzione dei fatti (storia) si fa con un metodo rigoroso, sicuro, mentre l'interpretazione dei fatti (storiografia) dipende dalla formazione culturale e dall'ambiente politico, istituzionale e ideologico in cui si è formato e in cui vive lo storico.
Le fonti sono le testimonianze cronologicamente più vicine ai fatti che si vogliono accertare (no fonti, no fatti attendibili). Al primo posto nel bagaglio metodologico dello storico sta la capacità di individuare le fonti necessarie per ricostruire i fatti. Le fonti sono molto eterogenee per genere, numero e qualità in base ai periodi storici studiati.
Lo storico della città antica utilizza al meglio le fonti letterarie affiancandole ai ritrovamenti archeologici e deve leggere la trama viaria della città attuale per vedere se sono rimaste tracce dell'antica morfologia urbana.
L o storico delle città medievale può contare anche sui documenti conservati negli archivi che, per l'età comunale, sono ricchissimi di informazioni.
Lo storico dell'età moderna e contemporanea deve far riferimento all'archeologia industriale e deve districarsi fra l'enorme quantità di documentazione pubblica e privata pervenuta ed esaminare la stampa.
Quando oggetto dello studio è la città medievale bisogna tener conto anche del ciclo santorale, cioè le dedicazioni delle chiese; infatti anche quando le chiese vengono ricostruite per obsolescenza, molto raramente viene sostituito il santo originario a cui era stata dedicata sin dalle sue origini.
Ogni epoca e ogni comunità è caratterizzata da dedicazioni tipiche di quel momento storico o per quella comunità.
La prima fonte per lo studioso di storia della città e la città stessa. Si parte dalle fonti iconografiche più affidabili: le piante catastali (disponibili per quasi tutte le città a partire dal XIX secolo). Sono molto precise ma a causa della larga scala di rappresentazione non consente una visione d'insieme.
Molto utili da questo punto di vista risultano invece le fotografie aeree zenitali perché mostrano immediatamente la diversa struttura delle maglie stradali e delle unità catastali al suolo; queste informazioni ci consentono di avere indirettamente notizie sulla cronologia delle diverse parti della città.
Scheda 2.1 Come leggere una foto aerea zenitale: l'esempio di Ferrara
Ripartizione in periodi e loro caratteri principali
La complessità nel tempo e nello spazio degli avvenimenti che caratterizzano la storia delle città; è necessario quindi utilizzare una periodizzazione.
- Antichità e Medioevo fino al secolo XIII
- Dalla crisi del Trecento fino alla crisi del secolo XVII
- Secoli XVIII e XIX, assolutismo, rivoluzioni, imperialismo
- Novecento
Le grandi tappe della storia urbana
L'urbanizzazione ha preso le mosse dalla Mesopotamia e dal Mediterraneo orientale molti secoli prima di Cristo e si è poi sviluppata verso il centro e il nord del continente europeo in un percorso millenario.
Le città dell'Asia minore dell'Egeo hanno prodotto fenomeni di colonizzazione verso occidente nell'Italia meridionale, nota come Magna grecia, a partire dal secolo VIII a.C.
Le tracce dello schema urbanistico applicato in Magna Grecia, è costituito da isolati ortogonali molto allungati con un asse centrale di scorrimento. Questo schema è stato utilizzato anche nei millenni successivi, prima nelle città coloniali romane, poi nei borghi franchi medievali.
Mentre nel sud dell'italia si formavano e si affermavano città ricche e potenti, nell'italia centrale si svilupparono in maniera autonoma le città etrusche, Perugia, Populonia, Veio, Cerveteri.
Dal secolo VIII a.C. Roma assunse i connotati di una grande città, insieme a Felsina (ora Bologna).
La colonizzazione romana. A partire dal IV secolo a.C. ha avuto inizio la grande colonizzazione effettuata dai Romani; le strutture viarie ortogonali, presenti ancora oggi nelle parti più interne della città, sono le tracce ancora vive di quell'organizzazione urbanistica che ha conferito loro una razionale struttura per la mobilità interna e che è stata utilizzata nelle terre dominate.
Durante la dominazione romana molte città della provincia, divenute municipi con cittadinanza romana, si dotarono di infrastrutture e di un'edilizia pubblica, civile e religiosa.
L'età tardo antica. La grande crisi che condusse alla fine dell'Impero romano fu dovuta a molteplici cause di carattere economico, sociale, politico, religioso e perfino meteorologico. Si formarono i regni romano-germanici e si diffuse il Cristianesimo. Questi fatti hanno determinato delle trasformazioni nella storia delle città. La città antica va in crisi a causa di tutti quegli elementi nuovi che determinano un uso delle strutture urbane diverso dal passato. E' caratteristica di questo periodo la spoliazione degli edifici pubblici e il reimpiego dei materiali recuperati. Gli imperatori d'oriente