Cos'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰ's the general theory of law, comparing it with Kelsen's pure theory and the philosophy of law. It examines the concepts of positive and natural law, the relationship between law and justice, and the sociology of law. It further explores the legal system, the constitution, and the validity of norms. The Pdf offers a comprehensive overview of the general theory of law, distinguishing it from Kelsen's pure theory and the philosophy of law, suitable for university students studying law. This document, ideal for university-level law studies, delves into the concepts of positive and natural law, the relationship between law and justice, and its connection to the sociology of law. It also discusses the legal system, the constitution, and the validity of norms.
Documento sulla teoria generale del diritto, confrontandola con la teoria pura di Kelsen e la filosofia del diritto. Il Pdf, adatto a studenti universitari di Diritto, esplora i concetti di diritto positivo e naturale, il rapporto tra diritto e giustizia, e la sociologia del diritto, analizzando l'ordinamento giuridico e la validità delle norme.
Mostra di più44 pagine
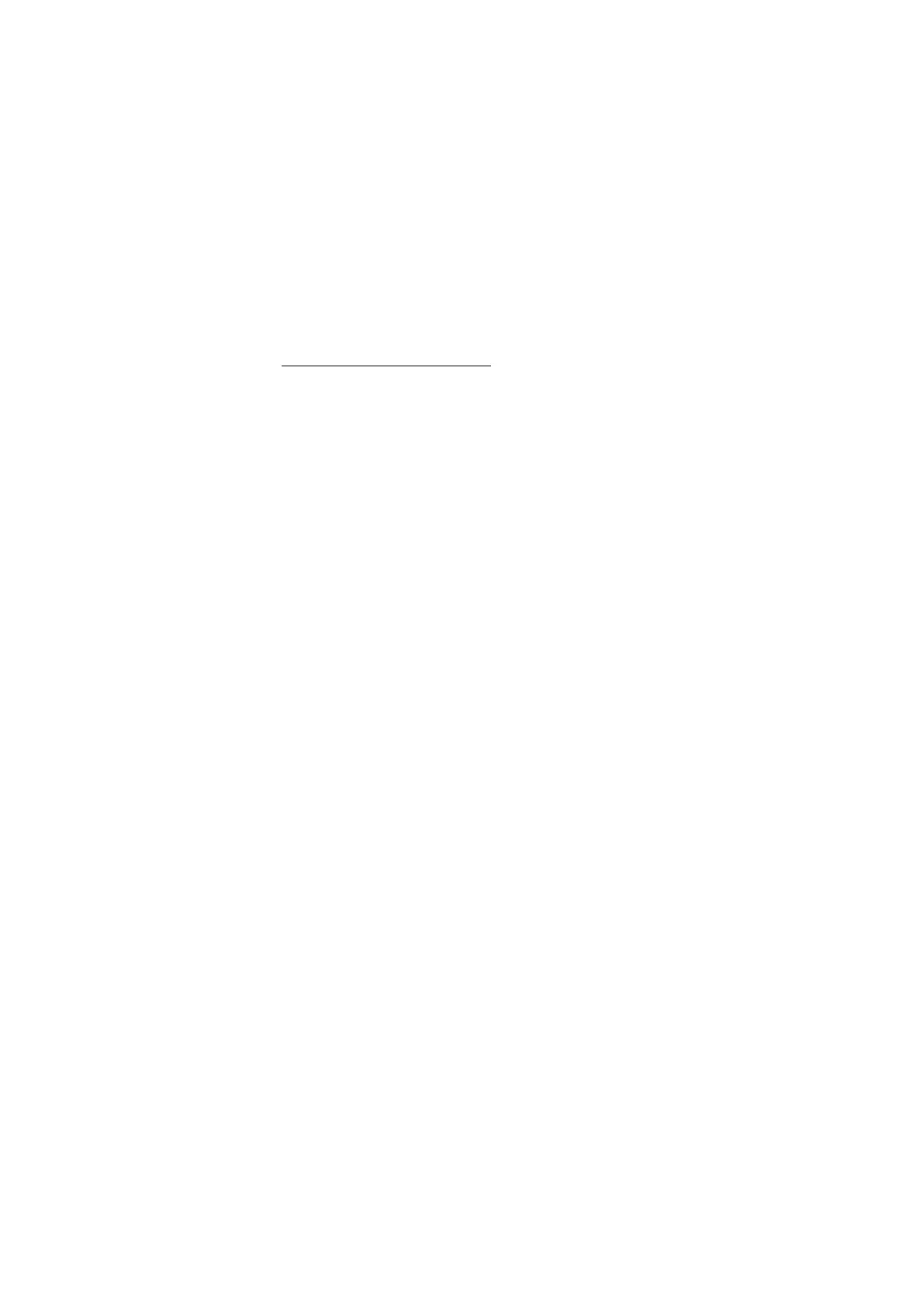

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Capitolo 1: La teoria generale del diritto
Cap.1: Cos'è la teoria generale del diritto. Teoria generale del diritto La teoria generale del diritto si occupa di delineare, attraverso la comparazione dei contenuti degli ordinamenti giuridici, concetti di uso comune (si occupa degli aspetti che sono comuni a molti diritti o a tutti i diritti). L'impresa di scrivere una teoria generale del diritto è ardua, soprattutto in una società come la nostra che vive un secolo tormentato e fragile, ma non per questo impossibile, e anzi forse è necessaria. Essa, dunque, si occupa del diritto così come esso è.
Teoria pura di Kelsen
La teoria generale del diritto non deve essere confusa con quella PURA di Kelsen, perché qui il termine generale vuole significare elaborazione di strumenti quali i concetti di norma, validità ed efficacia, che possono aiutarci a capire meglio le esperienze dei vari ordinamenti giuridici. In Kelsen, invece, il termine PUREZZA, mira ad indicare indipendenza del diritto da condizionamenti ideologici o politici, cercando di conoscere il diritto e non di creare una politica dello stesso. Oggi, richiamare Kelsen sarebbe assolutamente inattuale, dato che la nostra teoria generale presenta una intrinseca impurezza. Per cui una teoria generale può essere solo elaborazione di concetti generali che non devono tradire il carattere impuro del diritto stesso. Piuttosto c'è da dire che mediante la teoria generale del diritto, si mira al delineamento di figure e nozioni generali che ci permettono di conoscere e penetrare il mondo giuridico sociale nella sua impurezza- complessità e nelle sue contraddizioni. Distinzione con la filosofia del diritto.
Distinzione con la filosofia del diritto
La teoria generale del diritto, si distingue dalla filosofia del diritto, la prima guarda al diritto positivo la seconda studia invece studia sia il diritto naturale che positivo.
- Noi parliamo di DIRITTO POSITIVO, ossia il diritto posto in essere dai consociati validamente e descritto come tale. Ciò vale a dire che spesso i filosofi del diritto attuano una contrapposizione tra diritto positivo e naturale.
- Il DIRITTO NATURALE è quello che si autorappresenta come diritto che viene ispirato da una fonte soprannaturale, che sfugge al controllo degli uomini (es: dio, la natura). Ed è quel diritto che si aveva prima della costituzione e prima dello stato liberale. È un diritto non scritto
La prima (teoria generale del diritto) affronta il problema ontico del diritto, e quindi della sua esistenza, mentre la seconda (filosofia del diritto) affronta il problemadeontologico del diritto, e quindi il problema inerente al tema del giusto e all'elaborazione di un diritto giusto. La filosofia del diritto studia il diritto da un punto di vista deontico (piano che descrive come il diritto dovrebbe essere). Si serve della teoria generale del diritto, si domanda il perché debba esistere un diritto, come mai si è sviluppato in un determinato modo ecc. Si sofferma sul diritto e come esso potrebbe essere e dunque analizza il rapporto tra diritto e giustizia. La teoria generale del diritto e la filosofia del diritto non coincidono ma sono strettamente connesse. Perché non possiamo parlare di come il diritto dovrebbe essere senza sapere com'è. La teoria generale del diritto esclude, quindi, a priori la categoria ideale della giustizia nell'elaborazione del diritto.
Rapporto tra diritto e giustizia
Il diritto serve a darci delle norme di convivenza. Nella nostra costituzione la giustizia è amministrata in nome del popolo. Nel nostro ordinamento: legge, diritto, giustizia sono considerati tre elementi con un unico rapporto. La legge viene spesso identificata con la giustizia, ed è amministrata dal diritto. Il nostro diritto coincide con la giustizia secondo i principi che noi stessi ci siamo dati, una giustizia convenzionale. Il rischio è quello dell'ineffettività delle norme rapporto di tensione tra la realtà e le norme. "Il diritto non può cambiare una società se essa non è pronta, difatti le persone non saranno pronte a seguirla"
Rapporti con la sociologia del diritto
La sociologia del diritto indaga i rapporti che esistono tra il diritto e la realtà, in modo particolare tra le norme ed il comportamento dei consociati (come i consociati reagiscono al diritto, come il comportamento dei consociati influenza il diritto e come il loro comportamento è influenzato dal diritto). La teoria generale affronta lo studio deontico delle norme (cos'è il diritto e cosa sono le norme) concentrandosi sui temi quali la validità del diritto, il potere, l'onere; la sociologia si occupa dei comportamenti in relazione al diritto stesso e affronta il problema fenomenologico del diritto; quindi, come il diritto viene assorbito e applicato psicologicamente e concretamente dai consociati e questi comportamenti vengono definiti come l'ambito dell'effettività o efficacia del diritto.Quindi la prima si occupa della validità (dover essere) delle norme, la seconda dell'efficacia (essere) delle norme. L'effettività è il riscontro sociale dell'applicazione delle norme. Ad oggi la teoria generale e la sociologia del diritto si muovono attorno allo stesso fenomeno (il diritto), ma una si muove nell'ambito degli elementi deontici e l'altra si muove nell'ambito dei fatti fenomenologici. Il diritto per Catania si può spiegare solo dando conveniente spazio ad entrambi gli elementi, quindi sia deontici che fenomenologici. Essendo pertanto le due discipline legate ed interconnesse, l'effettività è stata spesso definita come la condicio sine qua non della validità del diritto, cioè la "condizione senza la quale non si può verificare la validità del diritto".
Capitolo 2: Il diritto
Cap.2: Il diritto. Nel nostro secolo e nella nostra cultura giuridica italiana si possono distinguere tre teorie generali del diritto:
- teoria relazionale o del rapporto giuridico;
- teoria istituzionalistica;
- teoria normativistica.
In tutte deve essere tenuto sempre presente e come punto fermo lo ius positivum, e quindi il diritto soggettivo.
Teoria relazionale o del rapporto giuridico
La prima teoria (relazionale, spesso ritenuta comunque inadeguata per comprendere gran parte degli aspetti del diritto) pone al centro del fenomeno giuridico la rete dei rapporti intersoggettivi , essendo inteso il diritto come la limitazione reciproca, attraverso regole, delle sfere di libertà tra individui-arbitri. Questa teoria trova il suo massimo esponente in Kant, e in Italia in Del Vecchio, Alessandro Levi e Cicala.
Teoria normativista
Quella normativistica trova i suoi massimi esponenti in Kelsen, Hart e (in Italia) in Bobbio, venendo presentata come teoria dell'ordinamento giuridico. Per Bobbio l'ordinamento giuridico è il complesso di norme ad efficacia rafforzata, cioè insieme di norme che sono dotate di coercibilità. Nel normativismo ci occupiamo della validità delle norme e dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato. La teoria istituzionalistica e quella normativistica, invece, sono molto legate ed intrecciate anche dal punto di vista storico-evolutivo. Oggi c'è il neoistituzionalismo con cui alle norme si affianca l'importanza dei concetti giuridici che si riferiscono ai valori sociali e alle istituzioni culturali.
Teoria istituzionalistica
La teoria istituzionalistica insiste sul fenomeno organizzatorio del diritto ossia sulla complessità delle strutture istituzionali in cui i fenomeni giuridici si presentano. Essa trova esponenti in Francia, ma anche in Italia come Santi Romano.
Il diritto come ordinamento
Oggi il diritto come ordinamento è sostanzialmente il diritto costruito sull'unità formale dell'ordinamento stesso. L'unità è perseguita in funzione della conoscenza. Elementi come completezza e coerenza, quali valori che hanno svolto un'importante funzione storica nella costruzione dello Stato liberale e che sono strettamente connessi al valore della certezza, in relazione al diritto hanno sempre il ruolo di valori-ideali da perseguire, senza essere mai un qualche cosa di "dato". Questa unità non è però da confondersi con i concetti sostanziali di ordine e di pace sociale. Il diritto deve essere inteso come unitario. Un ordinamento deve essere sempre interpretato come una unità, pur se costituito da lacune e profonde incoerenze nei suoi contenuti, perché solo così le norme dell'ordinamento potranno esistere come valide, altrimenti, se singolarmente considerate, appariranno incoerenti e lacunose. I maggiori tentativi di costruire una teoria ordinamentale sono stati eseguiti da Kelsen e Hart. In entrambi il problema viene affrontato attraverso il ricorso ad una norma fondamentale che in Kelsen è intesa come IPOTESI o FINZIONE e in Hart è intesa come NORMA DI RICONOSCIMENTO SUPREMA E DEFINITIVA.
Ordinamento e organizzazione: l'istituzionalismo
La teoria istituzionalistica vede come suo maggiore esponente Santi Romano che la espone nel suo libro intitolato "L'ordinamento giuridico". Questa teoria trova suo fondamento proprio nella cultura giuridica italiana, e si concentra sulla riflessione giuridica della crisi dello Stato moderno, che trova la sua prima affermazione nel fenomeno storico della prima guerra mondiale. Il termine istituzione in sede sociologica può indicare qualsiasi comportamento che si ripete uniformemente nel tempo da parte di una collettività; in sede giuridica identifica l'organizzazione giuridica di un fenomeno sociale. Non per questo però la teoria di Santi Romano deve essere confusa con la sociologia del diritto, perché la teoria generale del diritto, detta istituzionalista, in linea generale afferma che l'essenza del fenomeno giuridico può essere individuata esclusivamente nella sintesi tra struttura sociale e forma giuridica e non negli elementi oggettivistici della prima e formalistici della seconda.
Istituzionalismo di Hauriou
Sottolineava la coesistenza nel sistema giuridico, di caratteri soggettivi, di caratteri "oggettivi", non volontari, che esprimo la "durata" e la continuità istituzionalistica dei fatti giuridici. Un'organizzazione sociale mantiene nel tempo, nella "durata" la forma propria entro la quale si verifica il continuo mutamento dell'elemento umano.