Xvii Tesi: L'evoluzione dell'opera lirica italiana dal XVIII al XIX secolo
Documento sull'opera lirica italiana dal XVIII al XIX secolo. Il Pdf esplora l'evoluzione del melodramma, l'opera napoletana, l'opera buffa e sentimentale, con contributi di Scarlatti, Bellini, Donizetti e Verdi, utile per lo studio universitario di Musica.
Mostra di più45 pagine
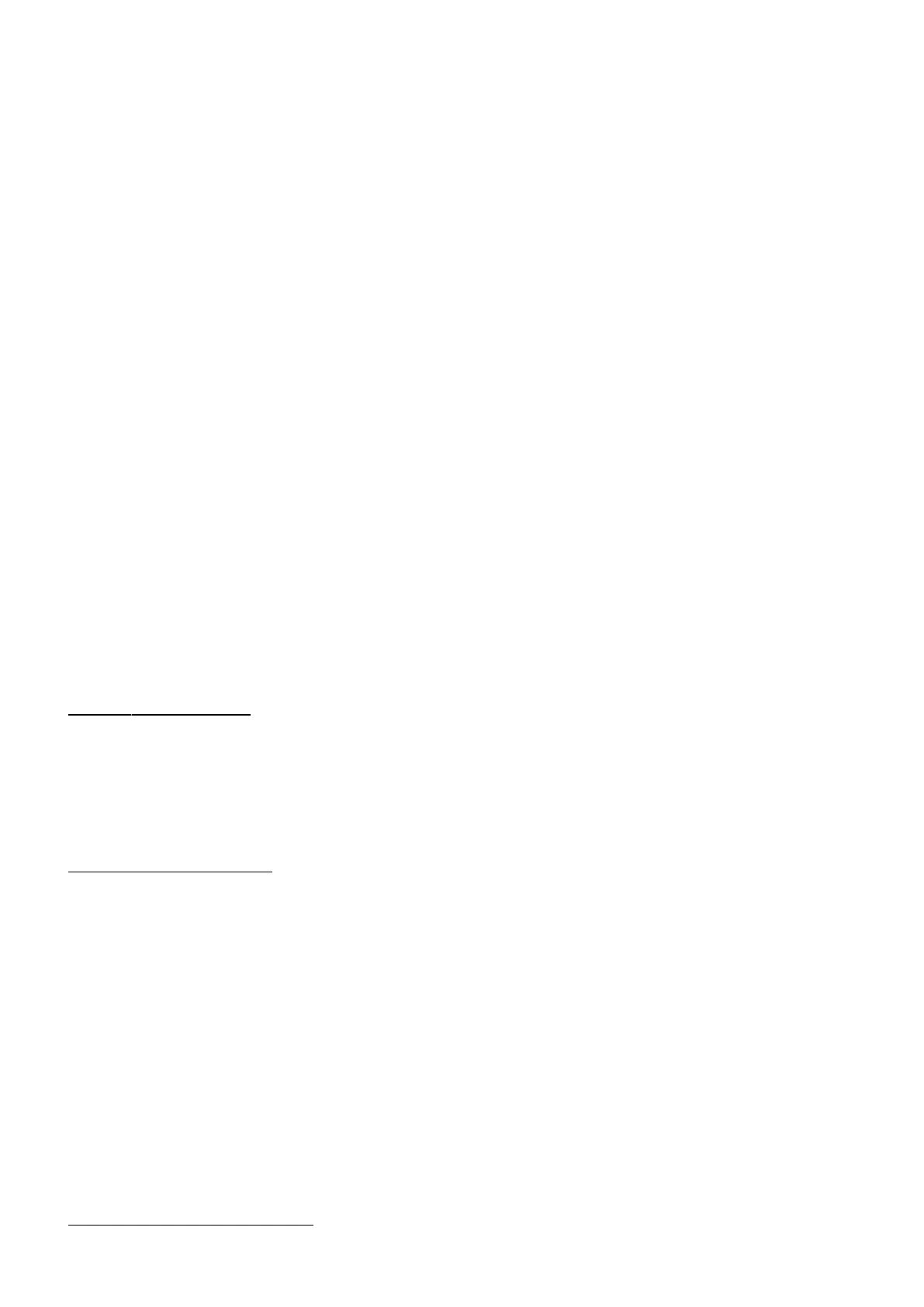
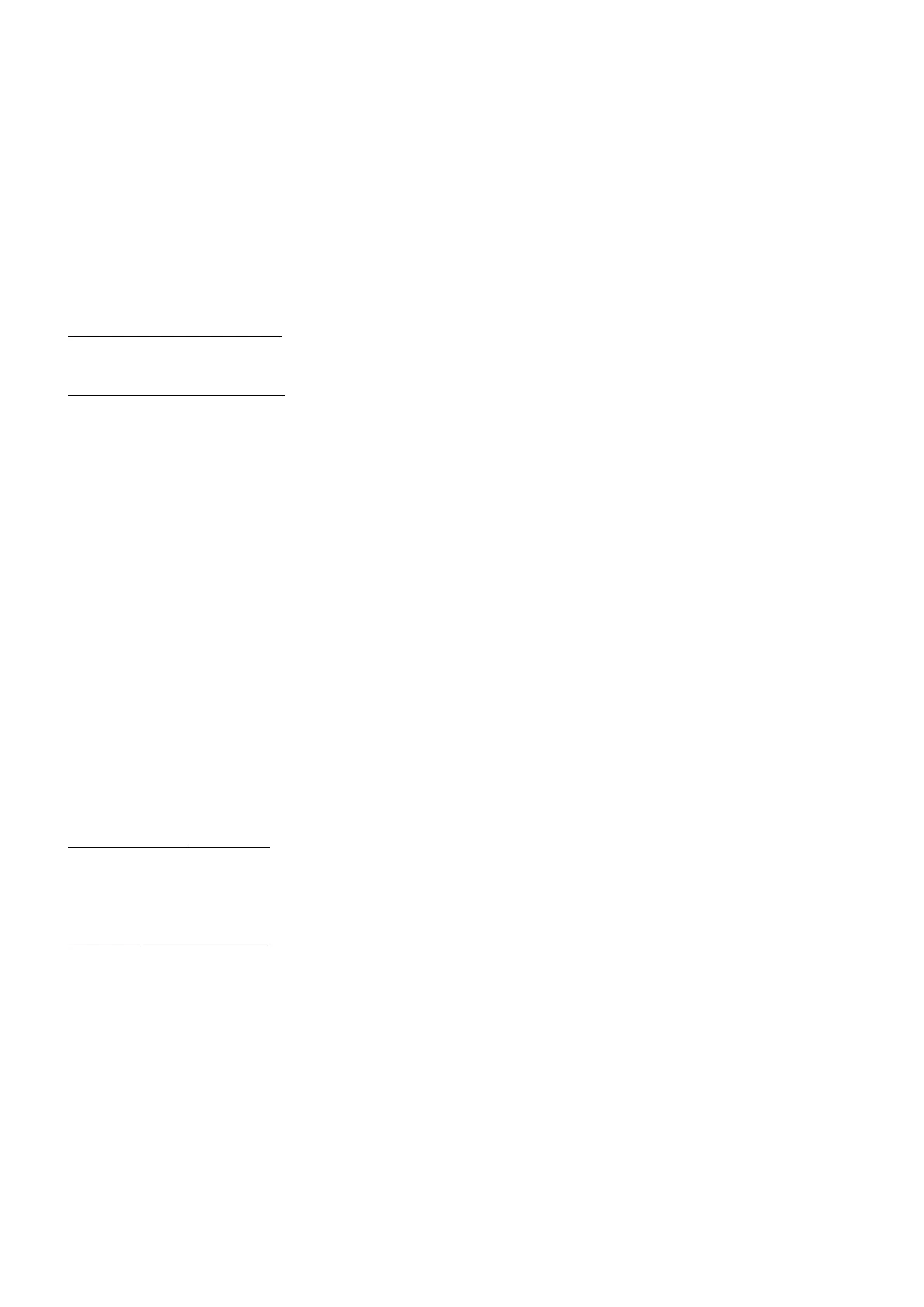
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
XVII TESI
L'opera napoletana - Alessandro Scarlatti - L'opera buffa e l'opera sentimentale
Il XVIII secolo rappresenta un'epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali. Se, infatti, in precedenza l'aristocrazia traeva potere e benessere dallo sfruttamento delle classi sociali inferiori, alla fine del secolo con la Rivoluzione Francese, scoppia il conflitto fra le due classi sociali. Le classi subaltern lottano per l'affermazione della propria dignità e da questo momento in poi si aprirà un'epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali. I maggiori divulgatori di tali trasformazioni furono i "philosophes francesi". La filosofia dei lumi della critica e della ragione ebbe in quei pensatori, da Voltaire a D'Alembert da Diderot a Rousseau, il suo nerbo principale. Alla propagazione delle innovative idee illuministiche contribuì tutta l'intellettualità europea, compresa quella italiana e germanica; ne prese parte anche una frazione dell'intellettualità nobiliare, non mancando, infatti, "i principi illuminati". Il genere musicale dominante è il melodramma e in particolar modo, il melodramma italiano che aveva trovato giusta dimora all'interno dei teatri. Si poteva evincere una differenza tra il teatro pubblico e quello privato o di corte: il primo era un'impresa economica che si reggeva interamente sulla vendita dei biglietti; il secondo era sovvenzionato da aristocratici e da principi e il suo pubblico era alquanto ristretto. Il teatro pubblico doveva essere costantemente all'avanguardia; il teatro di corte era più cauto nell'accettare novità. I cantanti rappresentavano la maggior attrazione per il pubblico medio; la voce di soprano era la preferita; ciò favorì l'abitudine a far interpretare anche le parti maschili ai soprani e soprattutto ai castrati. Ma fu solo nel ' 700 che il fenomeno dei castrati assunse un'importanza determinante nell'opera ed essi divennero spesso grandi divi, molto ammirati dal pubblico. L'opera settecentesca non si differenziava molto da quella veneziana per l'organizzazione delle stagioni, degli spettacoli e per il ruolo della messinscena. Vi furono, però, delle importanti innovazioni che toccarono due aspetti primari della creazione artistica: 1) la struttura del libretto; 2) la definizione della nuova forma musicale dell'opera. La prima mette in luce l'attività poetica di Zeno, di Metastasio e di Goldoni; la seconda esalta l'ingegno creativo di Alessandro Scarlatti. In Italia durante il '700, il problema che impegnò maggiormente i teorici, immersi in pieno clima illuministico che poneva in primo piano la ragione e la parola quale unico tramite per giungere ad essa, fu la riforma del melodramma e quindi i rapporti tra musica e poesia. Interessante, a riguardo, appare l'opera di alcuni letterati, teorici musicali e musicisti quali Algarotti, secondo il quale la musica può raggiungere la sua piena espressione solo accompagnando la parola, e Arteaga, secondo il quale l'opera non deve essere considerata come una fusion ma come l'incontro tra momento musicale (rappresentato dall'aria), momento drammatico (nel recitativo accompagnato), momento narrativo (nel recitativo secco) e messinscena.
La librettistica
Zeno, Metastasio, Goldoni
Nell'ambito della polemica illuministica nei confronti del melodramma e relativa ai rapporti tra musica e poesia, si leva l'opera di poeti eminenti quali Apostolo Zeno, prima, e Pietro Metastasio, dopo.
Apostolo Zeno (1668-1750)
Veneziano, scrisse il suo primo libretto nel 1695. Riscosse grande successo, per cui fu subito richiesto come prezioso collaboratore dagli impresari della sua città. Nel 1718 fu invitato a Vienna alla corte di Leopoldo I come "poeta cesareo" (poeta dell'Imperatore) nella cui carica fu poi sostituito da Metastasio, alla corte di Leopoldo I. Autore di 35 libretti d'opera e 17 di oratori, Zeno restituì al melodramma autonomia drammatica, riportando logica nell'azione teatrale. Soppresse le scene comiche e reintrodusse con moderazione i cori. Gli intrecci teatrali dei libretti di Zeno, erano permeati di un forte senso morale che egli derivò soprattutto dalle tragedie francesi. Riteneva che i drammi dovessero avere una funzione educativa e civile.
Pietro Metastasio (1698-1782)
Nato a Roma, iniziò a Napoli l'attività di poeta. Nella Vienna di Carlo VI e di Maria Teresa trascorse la restante parte della sua vita, che fu operosa e feconda, ricoprendo la carica di 'poeta cesareo'. Metastasio perfezionò gli interventi di Zeno e definì il modello che l'opera seria italiana avrebbe seguito per gran parte del secolo. Formalmente i suoi drammi sono tutti in 3 atti, con scene composte da lunghi recitativi conclusi da arie di pochi versi. Il livello letterario e poetico dei libretti del Metastasio è infinitamente più alto rispetto a quello di tutti gli altri librettisti del tempo. Egli sapeva adattarsi anche alle esigenze pratiche dello spettacolo: egli stesso promosse la collocazione dell'aria alla fine dell'episodio narrato, cioè dopo i dialoghi in stile recitativo, per far si che il cantante, ricevuta la sua dose di applausi, uscisse di scena e permettesse il cambio dei personaggi presenti.
L'OPERA A NAPOLI
Premessa
L'opera in musica fu introdotta a Napoli a metà del XVII secolo. Il viceré spagnolo conte d'Oñate fece venire da Roma una compagnia nomade di cantanti, i Febi Armonici, i quali presentarono l'opera Didone di Cavallli, alla quale seguì, l'anno dopo, L'Incoronazione di Poppea di Monteverdi. Nel 1654 fu aperto al pubblico il teatro S.Bartolomeo. Durante il periodo che precedette l'arrivo di Alessandro Scarlatti, a Napoli si eseguivano unicamente opere del repertorio veneziano. Essi erano abbastanza spesso rimaneggiate secondo le esigenze locali.
Francesco Provenzale (1627ca .- 1707)
1Primo operista napoletano fu un musicista di solida formazione tradizionale e fu tra i primi cultori del genere melodrammatico a Napoli. Oltre alla conoscenza del teatro monteverdiano, esse rivelano il gusto per il poetico e una vivacità comica di stampo popolare.
I Conservatori Napoletani
Intanto i "quadri" dei compositori e dei cantanti, si andavano formando in 4 orfanotrofi che erano chiamati "Conservatori": "dei Poveri di Gesù Cristo"; "della Pietà dei Turchini"; "di S.Maria di Loreto" e di "S.Onofrio a Capuana". Essi furono le prime istituzioni pubbliche in Europa destinate alla formazione professionale dei musicisti. Erano nati durante il secolo XVI come istituzioni caritative assistenziali con il nobile proposito di raccogliere l'infanzia abbandonata e gli orfani. Per integrare le entrate della beneficenza, i "figlioli" ospitati partecipavano alle cerimonie di culto, celebrate con l'accompagnamento della musica e del canto, nelle chiese cittadine, e queste prestazioni rese necessario fornire loro una, non rudimentale, educazione nel canto e nella musica. Queste esigenze stimolarono l'istituzione, all'interno dei Conservatori, di vere scuole di musica le quali a poco a poco assunsero una definita fisionomia didattica in quanto si insegnavano il canto, gli strumenti a fiato e ad arco, il clavicembalo e il contrappunto.
Francesco Durante (1684-1755)
Fu il caposcuola della scuola napoletana. Maestro a S.Onofrio, ai Poveri di Gesù Cristo e a S. Maria di Loreto, lasciò una produzione copiosa di musiche religiose e di composizioni strumentali.
Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Nato a Palermo, svolse la maggior parte della sua attività artistica a Napoli e a Roma. A Roma era arrivato a 12 anni per compiere gli studi musicali; nel 1684 si trasferì a Napoli, dove fu nominato maestro della cappella reale. Motivi vari lo indussero nel 1702 a lasciare Napoli; dopo un breve soggiorno a Firenze, riprese la strada di Roma. Nel 1707 ritorna a Napoli dove trascorse il resto della sua vita ed ivi morì. Nella sua copiosissima produzione il primo posto spetta alle opere, anche perché l'attività di compositore teatrale fu quella che assorbì tanta parte del suo ingegno creativo. Lasciò anche una copiosa produzione in altri generi vocali e strumentali. Le forme adoperate da Scarlatti sono le stesse che egli aveva ereditato dalla tradizione. L'aria si stabilizza nella forma detta "col da capo", procedimento quest'ultimo già introdotto da Antonio Cesti nelle precedenti opere veneziane ma oggetto di maggiore sviluppo musicale durante il Settecento. Il da capo doveva servire soprattutto ai cantanti castrati per mettere in luce le loro doti vocali. La struttura di questo tipo di aria era abbastanza semplice: le prime 2 parti (A e B), oggetto di elaborazione musicale con l'inserimento anche di ritornelli strumentali, si adattavano a 2 strofe poetiche ben distinte con 2 motivi melodici diversi; dopo la seconda parte (B) veniva ripetuta la prima (A) e qui il cantante si esibiva con fioriture e improvvisazioni.
L'opera buffa
Un fatto di grande importanza fu la messa in scena di "opere buffe", alcune in dialetto napoletano. Essa segnò il tramonto dell'inclusione di scene comiche nelle opere di argomento serio e preparò la demarcazione in 2 generi: l'opera seria da una parte e l'opera buffa dall'altra. Nelle opere buffe erano messe in scena vicende plausibili, di ambiente borghese. Le sedi teatrali napoletane che ospitavano opere buffe furono diverse da quelle dell'opera seria. Fu inizialmente il teatro dei Fiorentini e ad essi si aggiunsero il teatro Nuovo e il Teatro Del Fondo. Tra gli operisti napoletani delle generazioni successive, quelli che acquistarono maggiore fama furono Jammelli e Traetta.
Niccolò Jommelli (1714-1774)
Il periodo più fulgido della sua attività fu quello trascorso a Stoccarda, quale maestro di cappella di Karl Eugen duca di Wüttemberg. Per assecondare il gusto eclettico del duca, combinò insieme la drammaturgia metastasiana e quella francese, immettendo liberamente nella struttura dell'opera italiana cori, brani d'insieme, balli e dando rilievo alle parti strumentali ed agli accompagnamenti.
Tommaso Traetta(1727-1779)
Animò l'azione introducendo brevi cori e danze e irrobustendo i recitativi. Unità stilistica e qualità drammatica sono i pregi delle migliori opere serie di Traetta: il coro non di rado vi ha parte di rilievo e consistente è la presenza del recitativo accompagnato che sfocia con naturalezza nell'aria, mentre l'orchestra è ricca di colori adeguati alle circostanze drammatiche.
L'opera sentimentale
Una fase evolutiva dell'opera buffa è rappresentata dall'opera sentimentale o commedia sentimentale o "larmoyante". Essa pretende di ritrarre la realtà com'è, cioè mista di comico e di serio, lasciando parte larghissima al patetico, al malinconico. Tra gli autori più importanti si ricordano: Nicolò Piccinni (1728-1800), che a poco più di 30 anni scrisse il suo capolavoro, La Cecchina o La buona figliola su libretto di Goldoni. Giovanni Paisiello (1740-1816) che scrisse 2 opere giocose di successo: La molinara e Nina pazza per amore.
L'OPERA A VENEZIA
Per tutto il XVIII secolo la città lagunare rimase il più vivo centro musicale dell'Italia Settentrionale e i teatri continuavano ad essere un'attività imprenditoriale lucrosa. C'era, inoltre, concorrenza tra i vari teatri e in alcuni di essi si allestivano solo opere serie, mentre in altri si2rappresentavano anche opere buffe.