Medicina dello sport: visita, aggiustamenti cardiocircolatori e allenamento
Documento di Appunti sulla Medicina dello Sport. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Biologia, descrive gli aggiustamenti cardiocircolatori durante l'esercizio fisico e gli adattamenti all'allenamento, con un focus sulle risposte cardiovascolari.
Mostra di più60 pagine
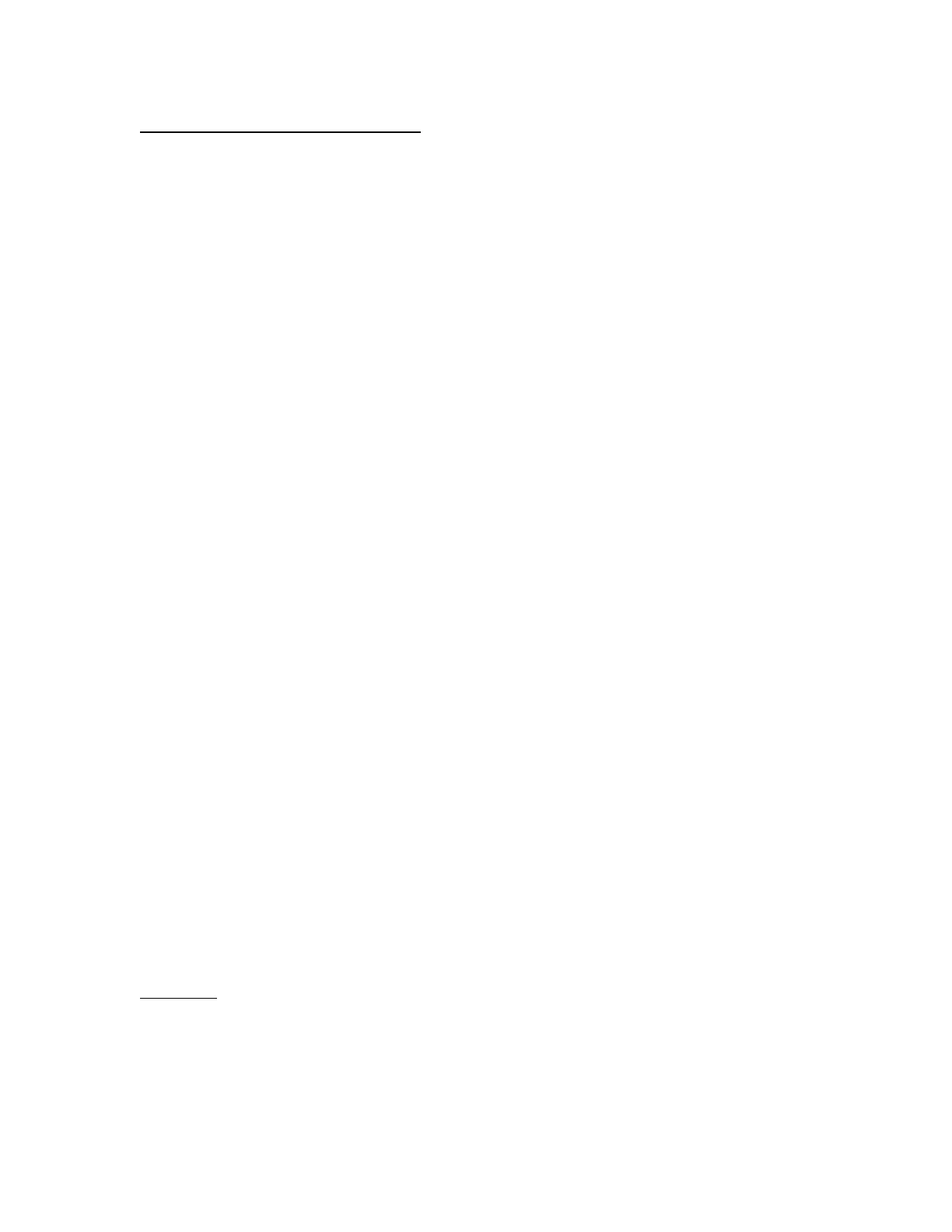

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Medicina dello Sport: Panoramica
MEDICINA DELLO SPORT -> Branca autonoma della medicina che si interessa di giovani sani che esercitano attività ginnico-sportive e per questo è una medicina preventiva e sociale.
La medicina dello sport si divide in due aspetti distinti:
- Medicina dello sport formativo ( medicina preventiva e sociale ) = ha precisi obiettivi di pubblico interesse e riguarda la massa;
- Medicina dello sport agonistico ( fisiologia dell'atleta ) = ha un'importanza scientifica e pratica nei confronti delle grandi prestazioni dell'organismo umano.
La medicina dello sport è l'applicazione della scienza medica, dal punto di vista preventivo e terapeutico, alla pratica dello sport e delle attività fisiche al fine di sfruttare le possibilità che offre lo sport di mantenimento o di miglioramento dello stato di salute ed evitare eventuali danni.
La medicina dello sport oggi è in grado, attraverso esami attitudinali e valutazioni clinico- strumentali periodiche, di garantire nelle varie età e per i diversi tipi di esercizio fisico, una idonea selezione ed un obiettivo riscontro delle possibilità di ognuno di sopportare senza danno una giusta dose di attività fisica.
La prevenzione si rivolge alla selezione iniziale, al controllo periodico, allo studio patogenetico delle lesioni da sport e alla riabilitazione dell'infortunio sportivo.
La visita medico sportiva, può essere eseguita solo da un medico specialista in medicina dello sport abilitato all'esercizio della professione, in un ambulatorio di medicina dello sport pubblico o privato, accreditato o convenzionato a seconda delle locali leggi regionali. Le visite effettuate in contesti differenti ( spogliatoi, palestre, ambulatori non autorizzati ) non possono essere considerate valide ed il certificato quindi risulta nullo a tutti gli effetti medico legali ed assicurativi.
Classificazione degli Sport
Gli sport vengono suddivisi in due tipologie, a seconda dell'impegno necessario:
- Sport di TABELLA A = ad impegno muscolare e cardio-respiratorio lieve o moderato. Accertamenti sono visita medica, ECG a riposo , esame completo delle urine. Certificato ha validità annuale (motociclismo ,tuffi ecc) o biannuale (bocce,golf ,arco)
- Sport di TABELLA B = ad impegno elevato. Accertamenti sono visita medica, spirometria, ECG a riposo, esame urine. Certificato ha validità annuale.
VISITA MEDICO-SPORTIVA
Anamnesi e Valutazione Iniziale
- Valutazione preliminare degli antecedenti anamnestici familiari per mettere in evidenza la presenza di cardiopatie, aritmie o storie di infarto ecc, dopodichè viene effettuata una valutazione dell'ECG di base a riposo, frequenza cardiaca, pressione arteriosa.
- Raccolta delle info sullo stato di salute personale del soggetto e su eventualipatologie pregresse di interesse per il rilascio dell'idoneità, sulla qualità delle attività lavorative e sportive svolte, su alcune abitudini ( fumo, assunzione di integratori, alcool ... ) e sulla conoscenza dei danni derivanti dall'assunzione di sostanze doping.
- Raccolta dei dati antropometrici ( peso e altezza ).
- Esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso.
- Esame del senso cromatico ( solo per gli sport motoristici o automobilistici ).
- Rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a 4 metri di distanza.
- Esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificatamente impegnati nello sport praticato.
- Visita clinica con ascoltazione toracica e misurazione della P.A.
Esame Completo delle Urine
Si evidenzia : colore delle urine, il ph, il peso specifico, la presenza di glucosio, di proteine, di sangue, di corpi chetonici, dell'urobilinogeno e della bilirubina, l'eventuale presenza di batteri e si analizza il sedimento. Non è possibile valutare se una persona fa uso di doping o di sostanze stupefacenti. L'esame completo delle urine da utili indicazioni di funzionalità epatica, renale e metabolismo glicidico. Si fa uso di strisce di cartine tornasole.
ECG a Riposo
Rimane ancora oggi l'esame di primo livello più economico e di facile esecuzione al fine di una valutazione iniziale della popolazione sportiva. Esso registra l'attività elettrica delle cellule miocardiche ed è solo in parte influenzato dalle modificazioni anatomiche, fisiologiche ( come nel cuore d'atleta ) o patologiche, che l'organo subisce. Nell'ambito della valutazione cardiologica ai fini dell'idoneità sportiva solo un ECG normale, associato ad anamnesi ed esame obiettivoprivi di elementi di patologia, possono con ragionevole certezza indicare una condizione di cuore sano. Si possono distinguere le seguenti componenti:
- L'onda P rappresenta l'attivazione ( depolarizzazione ) atriale, che essendo costituita da una porzione relativamente ridotta di miocardio, risulta di piccolo voltaggio.
- Il complesso QRS corrisponde alla depolarizzazione ventricolare.
- L'onda T corrisponde alla ripolarizzazione atriale.
- La ripolarizzazione atriale, essendo contemporanea al complesso QRS, è inglobata in esso e non è possibile quindi osservarla all'ECG di superficie.
NB : Se non c'è l'onda P si avrà un ritmo di tipo giunzionale ( in quanto mancando la fase di sistole atriale per saturazione del NSA, il NAV starà svolgendo sicuramente il lavoro di genesi elettrica al posto del nodo senoatriale ).
Alterazioni Elettrocardiografiche negli Atleti
Le alterazioni elettrocardiogramo ritrovarsi negli atleti sono state studiate e classificate in 3 gruppi:
- modificazioni fisiologiche = queste sono la conseguenza dell'allenamento e costituiscono elementi caratteristici del cuore d'atleta ( bradicardia sinusale, bloccoatrio ventricolare [BAV] di 1º grado, battiti o ritmi di scappamento atriali e giunzionali ). Tali alterazioni che tipicamente scompaiono con il non allenamento sono da considerarsi varianti della norma e non richiedono ulteriori indagini;
- modificazioni border- line = anch'esse sono generalmente espressione dello stato di allenamento e quindi "benigne", tuttavia devono essere indagate in modo approfondito per distinguere con certezza da anomalie patologiche ( marcate aritmie ipocinetiche, BAV di grado avanzato, anomalie della ripolarizzazione ventricolare );
- modificazioni anormali = sono reperti rari negli atleti, non rientrano negli adattamenti funzionali all'allenamento e devono considerarsi patologiche ( aritmie ipercinetiche, pre- eccitazione cardiaca .. )
La presenza di alterazioni ECGgrafiche riferibili al 2° o 3º gruppo impone l'esecuzione di esami di secondo livello: in primis un ecocardiogramma per valutare la presenza di anomalie strutturali, un ECG dinamico secondo Holter nelle 24 ore a riposo, un ECG dinamico secondo Holter con normale seduta di allenamento e un test da sforzo massimale. Ricorrere eventualmente ad esami ulteriori altamente specialistici RMN, test d'alternanza dell'onda T quando i primi non siano stati sufficienti a chiarire la natura benigna o patologica delle alterazioni riscontrate
Ecocardiografia
E' la principale metodica che consente lo studio morfologico e funzionale del cuore. Ha rivoluzionato la cardiologia e la medicina dello sport, consentendo di definire:
- le caratteristiche del cuore d'atleta nelle diverse discilpine;
- di stabilire i limiti della cosiddetta ipertrofia fisiologica e i criteri morfologici e funzionali per la diagnosi differenziale con le forme patologiche di ipertrofia cardiaca, prima fra tutte la cardiomiopatia ipertrofica, ben nota al cardiologo dello sport come prima causa di morte improvvisa nei giovani atleti.
Attualmente l'ecocardiografia è considerata un esame di secondo livello a cui indirizzare solo i soggetti con anamnesi familiare positiva per morte improvvisa cardiaca giovanile o coloro che presentino segni clinici ( soffi, click ecc .. ) e /o elettrocardiogramme, alterazioni della ripolarizzazione ) suggestivi di patologia. E' pertanto auspicabile un impiego sempre maggiore di tale metodica nella visita medico sportiva, di routine diremmo, al fine di evitare che molte anomalie cardiace asintomatiche possano passare inosservate.
ECG secondo Holter
L'elettrocardiogrammamica secondo Holter si è diffusa negli anni 70 rivoluzionando la cardiologia sportiva , dove rappresenta un esame di grandissima utilità, spesso risolutiva nella formulazione del giudizio di idoneità all'attività agonistica. L'ECG secondo Holter trova nell'aritmologia il suo principale campo di applicazione consentendo di identificare l'aritmia ( ipo o ipercinetica ), di caratterizzarne gli aspetti qualitativi e quantitativi, di stabilirne i rapporti con l'attività fisica.ECG dopo test da sforzo
ECG dopo Test da Sforzo
L'ECG da sforzo utilizzata normalmente è di tipo sottomassimale ( cioè non spinta fino all'esaurimento muscolare ), effettuata mediante salita e discesa per 3 minuti da un gradino ( step test ), di altezza variabile da 30 a 50 cm. Negli ultimi anni i medici dello sport preferiscono, soprattutto negli atleti di età > ai 40 anni, eseguire una prova da sforzo massimale al cicloergometro o al tapis roulant. L'ECG da sforzo , offre maggiori informazioni sullo stato di salute del cuore perchè ne aumenta il lavoro , evidenziando eventuali patologie non riscontrabili a riposo. Ciò perchè con questo test viene estrapolato il VO2 max , ovvero il massimo consumo di ossigeno, che è il parametro più importante nella fisiologia dell'esercizio. In crementi progressivi di carico applicati servono a valutare la risposta cardiovascolare progressiva, nell'ambito della natura del test ( circa 20 min mediamente ). Il test viene immediatamente interrotto in caso di positività ( cioè se patologico ), allorchè metta in evidenza segni elettrocardiogra ischemia ( che si manifestano principalmente con un sottoslivellamento del tratto ST ). Se invece durante lo sforzo il paziente accusa dei disturbi ( dolore toracico, mancanza di respiro ) in assenza alterazioni ECG, il test ergometrico viene considerato "non diagnostico" e può essere indicato un approfondimento diagnostico con altri test ( es. scintigrafia miocardia ).
Spirometria
Rappresenta il primo livello nella diagnostica funzionale respiratoria, semplicemente è la misura dell'aria che entra ed esce dai polmoni durante l'attività respiratoria, in particolar modo durante un'espirazione forzata. E' un esame semplice, non invasivo, ripetibile e di basso costo. L'esame viene eseguito con uno spirometro, che consiste in uno strumento che misura il flusso chiuso ( spirometro a campana ) oppure a circuito aperto ( spirometro a turbina ). La maggior fonte di variabilità dell' esame risiede nella collaborazione del paziente e nell'incitamento da parte dell'operatore. E' indispensabile una stretta collaborazione tra i due per ottenere dei risultati interpretabili. Per eseguire un'adeguata spirometria sono importanti alcuni requisiti :
- ottenere almeno 3 spirogrammi accettabili ( Volume Espiratorio Max e Capacità vitale forzata non devono differire più di 200 ml o del 5% );
- inspirazione completa prima del test;
- inizio soddisfacente della respirazione ( massimo sforzo, nessuna esitazione );
- assenza di tosse durante il primo secondo;
- durata adeguata del test ( espirazione di durata non inferiore ai 6 secondi o ai 15 in caso di ostruzione bronchiale );
- perfetta tenuta e idoneità del boccaglio.
Con la spirometria possiamo valutare parametri:
- statici = si ottengono facendo inspirare lentamente e profondamente al paziente dentro al boccaglio monouso, dopodichè si fa espirare completamente e profondamente, in modo da espellere tutta l'aria.