Nozioni generali sul Patrimonio Culturale italiano, Fp Cgil Corsi
Documento da Fp Cgil Corsi su Nozioni generali sul Patrimonio Culturale italiano. Il Pdf esplora il concetto di patrimonio culturale italiano, analizzando l'interesse culturale, le Linee guida per la verifica archeologica e la giurisprudenza in materia di beni culturali, utile per concorsi pubblici in Diritto.
Mostra di più17 pagine
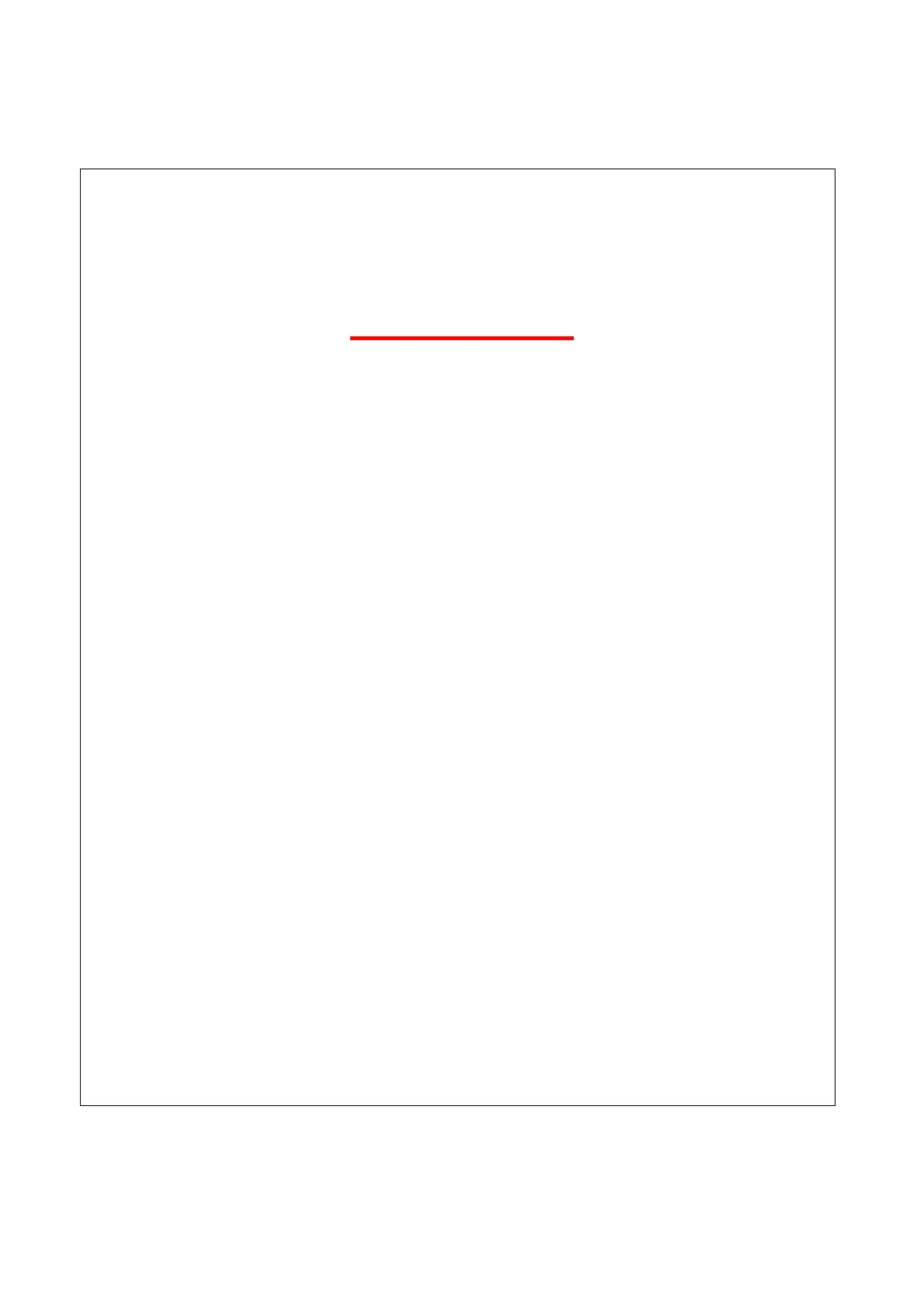

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Nozioni generali sul Patrimonio Culturale italiano
Nozioni fondamentali del patrimonio culturale italiano
CAPITOLO 2 Nozioni generali sul Patrimonio Culturale italiano 2.1. Nozioni fondamentali del patrimonio culturale italiano 2.2. La storia del diritto dei beni culturali 2.3. Aggiornamenti sui beni culturaliFP CON CORSI CGIL BIBLIOTECA DEI SAPERI Nozioni fondamentali del patrimonio culturale italiano
Uno dei primi concetti da fissare, facendo riferimento al patrimonio culturale italiano, è certamente quello di "bene culturale".
Nell'ordinamento italiano, una prima definizione di bene culturale era data dalla legge Rosadi-Rava del 1909 e comprendeva le "cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico".
Oggi, l'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, offre una definizione più articolata e complessa, in cui rientrano le cose mobili e immobili che "presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".
La caratteristica identificativa del bene culturale è, dunque, la sussistenza di un interesse culturale. L'accertamento in concreto di tale interesse avviene, caso per caso, attraverso valutazioni tecniche riservate ad Amministrazioni altamente specializzate.
Nella definizione del Codice è significativo il riferimento al concetto di "testimonianza": tra i beni culturali sono infatti comprese le vestigia e le tracce significative del passato.
La nozione di bene culturale è mutata profondamente nel corso del tempo. In particolare, da una concezione estetizzante, focalizzata sul carattere della bellezza, si è passati a una concezione ontologica e identitaria.
Il bene culturale è quindi tale per le sue qualità intrinseche e per il suo valore di testimonianza di civiltà, a prescindere dal suo aspetto esteriore e dal suo stato di conservazione.
Va anche specificato che alcuni beni culturali sono tali di per se stessi, ad esempio un quadro d'autore, mentre altri acquistano interesse soltanto se considerati in un complesso organico, ad esempio gli archivi o le collezioni.
Infine, il bene culturale si distingue dal bene paesaggistico, che è invece l'immobile o l'area espressione di valori storici, naturali, morfologici ed estetici del territorio.
Esaminiamo ora la nozione di "patrimonio culturale".
In un primo momento i testi normativi adottavano la diversa locuzione "patrimonio storico e artistico", contenuta anche nel nostro testo costituzionale, all'art. 9 e già prima nella Legge Bottai del 1939.
Nel corso del tempo, è invece invalso il più ampio e complesso concetto di patrimonio culturale, presente nel tessuto normativo comunque già da tempi remoti.
@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL
Oggi, ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il "patrimonio culturale" comprende i beni culturali e quelli paesaggistici, che sono quindi considerati in un insieme unico, con un'identità comune.
Il termine "patrimonio" è particolarmente efficace, perché descrive un insieme di risorse, stratificatesi nel tempo e consolidatesi, che sono unite da un collegamento organico e da uno scopo comune e che sono oggetto di conservazione e protezione.
Oggi la nozione di "patrimonio culturale" deve essere in parte riconsiderata alla luce della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, firmata a Faro, in Portogallo, nel 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata soltanto di recente con la legge 1º ottobre 2020, n. 133.
Tale Convenzione, all'art. 2, propone una nuova visione del patrimonio culturale (cultural heritage) come "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi".
Questa definizione evidenzia il ruolo delle persone e della loro interazione nella costruzione del valore culturale: la comunità diventa parte attrice nel forgiare, individuare, proteggere e valorizzare l'eredità del passato.
La nozione offerta dalla Convenzione di Faro ha un valore prevalentemente simbolico, con il fine di orientare le azioni future degli Stati sul piano politico e normativo. A livello nazionale, resta invece decisiva la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali.
Va rilevato che il nostro ordinamento ha storicamente dato particolare rilievo alla dimensione fisica e tangibile dei beni culturali. Molti altri ordinamenti, invece, ammettono da tempo la possibilità di tutelare beni privi di supporto fisico e dunque immateriali, o comunque intangibili.
La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, ha disciplinato a livello internazionale l'esistenza di beni culturali "intangibili", ossia "le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale".
Alla convenzione è collegata una lista di elementi rappresentativi del patrimonio culturale immateriale, cui l'Italia ha contribuito inserendo, ad esempio, l'Opera dei Pupi Siciliani, l'alpinismo, la transumanza e l'arte del pizzaiuolo napoletano. Nel patrimonio culturale immateriale rientrano quindi essenzialmente i comportamenti e le azioni che hanno per la comunità un valore di testimonianza di civiltà.
Con riguardo ai beni culturali immateriali, la conservazione e la tutela sono più complesse perché richiedono un costante intervento attivo della comunità, mediante la ripetizione delle tradizioni e la trasmissione di conoscenze di generazione in generazione.
In Italia, nonostante i beni culturali immateriali siano stati oggetto di notevole attenzione e sia stato persino creato un apposito Istituto centrale presso il Ministero della Cultura, la normativa è ancora essenzialmente impostata su una concezione materialista, che pretende l'esistenza di un supporto fisico da tutelare.
@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CGIL CON CORSI
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 ha inserito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio un apposito articolo 7 bis, con il quale si ammette che possano essere oggetto di riconoscimento e tutela anche le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, ma soltanto "qualora siano rappresentate da testimonianze materiali" e sussistano gli altri requisiti di legge. Dunque la materialità rappresenta ancora oggi un presupposto indefettibile perché siano attivati i meccanismi di tutela previsti nel Codice.
@ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservatiFP CON CORSI CGIL BIBLIOTECA DEI SAPERI
La storia del diritto dei beni culturali
La consapevolezza di dover individuare e proteggere i beni aventi rilievo culturale e le testimonianze del passato risale fino a tempi remotissimi. Con lo svilupparsi dell'esperienza giuridica, la tutela delle risorse culturali è stata attuata principalmente proprio mediante il diritto.
Considerando la storia recente, una significativa produzione normativa in materia di beni culturali si rinviene nello Stato Pontificio dal quindicesimo secolo in poi.
In particolare, molti provvedimenti papali si concentrarono sulla protezione degli edifici storici, delle opere d'arte e degli altri beni ecclesiastici aventi rilievo culturale.
Dapprima, una Bolla di Pio II del 1462 vietò la demolizione e la modificazione, senza autorizzazione, dei monumenti storici.
In seguito, una Bolla di Sisto IV del 1474 impedì la spoliazione delle chiese e impose il divieto di vendita dei beni culturalmente rilevanti di proprietà della Chiesa.
È poi significativa una bolla di Martino V del 1425, che ordinò l'abbattimento delle costruzioni recenti ravvicinate a edifici storici, nel caso di stili incompatibili. Quest'ultimo provvedimento valorizzò una nozione molto ampia e progredita di bene culturale, considerato nelle sue interrelazioni con il contesto spaziale circostante.
Dal diciassettesimo secolo, anche molti editti cardinalizi riguardarono la materia dei beni culturali. Tra questi, nel 1820, l'editto del Cardinale Pacca ordinò la catalogazione e il restauro di tali beni, prevedendo forme organiche di salvaguardia e persino un diritto di prelazione pubblica sui quadri.
Per quanto riguarda il resto d'Italia, già alcuni stati preunitari avevano adottato specifiche legislazioni in materia di patrimonio culturale: ad esempio il Granducato di Toscana, il Regno di Napoli o il Regno lombardo-veneto. Si trattava di norme concernenti prevalentemente la tutela dei beni culturali immobili e la circolazione di quelli mobili.
Il Regno di Sardegna, invece, non aveva maturato una disciplina specifica in materia.
Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, già la legge n. 2359 del 1865 si concentrò sulla tutela dei beni culturali, in particolare degli immobili storici e di antichità nazionale, prevedendo persino la possibilità di espropriare i monumenti in rovina.
Sulla circolazione del patrimonio culturale intervenne poi la legge Nasi del 12 giugno 1902, n. 185, che statuì l'inalienabilità di alcune categorie di beni appartenenti a enti pubblici.
Un intervento normativo di ampio respiro fu la legge n. 364 del 1909, conosciuta come legge Rosadi-Rava. Essa dettò anzitutto una nuova nozione di bene culturale, in cui venivano ricomprese le "cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico". Approntò poi una serie strumenti per proteggere i beni culturali dal pericolo di distruzione, compromissione o dispersione e per attrarli nella proprietà statale. In particolare, stabilì l'inalienabilità dei beni culturali già in mano pubblica, @ 2021 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. Tutti i diritti riservati