Il Decadentismo: caratteristiche, temi e confronto tra Pascoli e D'Annunzio
Slide sul Decadentismo che ne definisce caratteristiche e temi, confrontando le figure di Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio. Il Pdf, utile per la scuola superiore in Letteratura, fornisce una chiara comprensione del periodo letterario e dei suoi esponenti, con un focus sulle vite dei due autori.
Mostra di più12 pagine
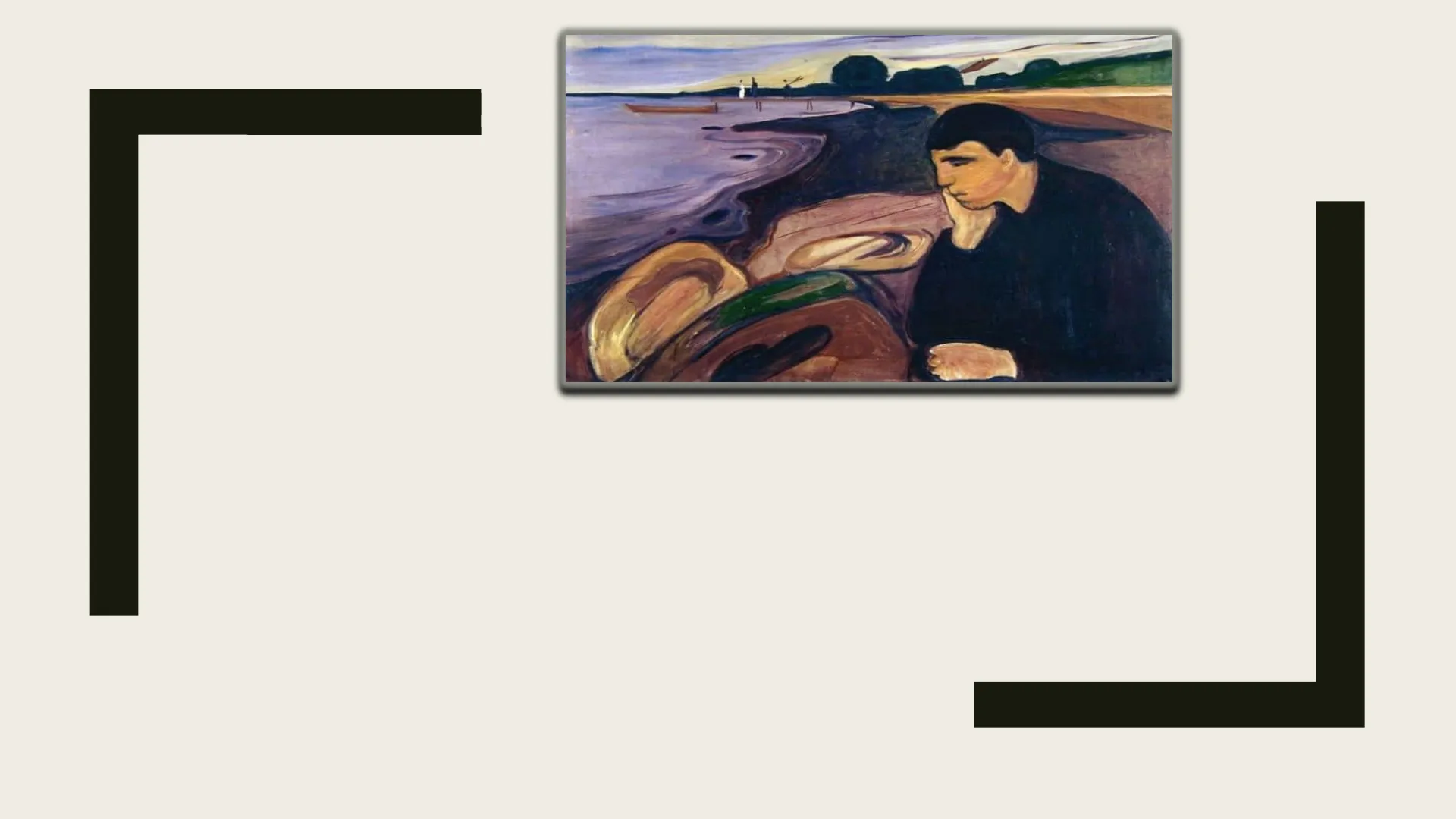
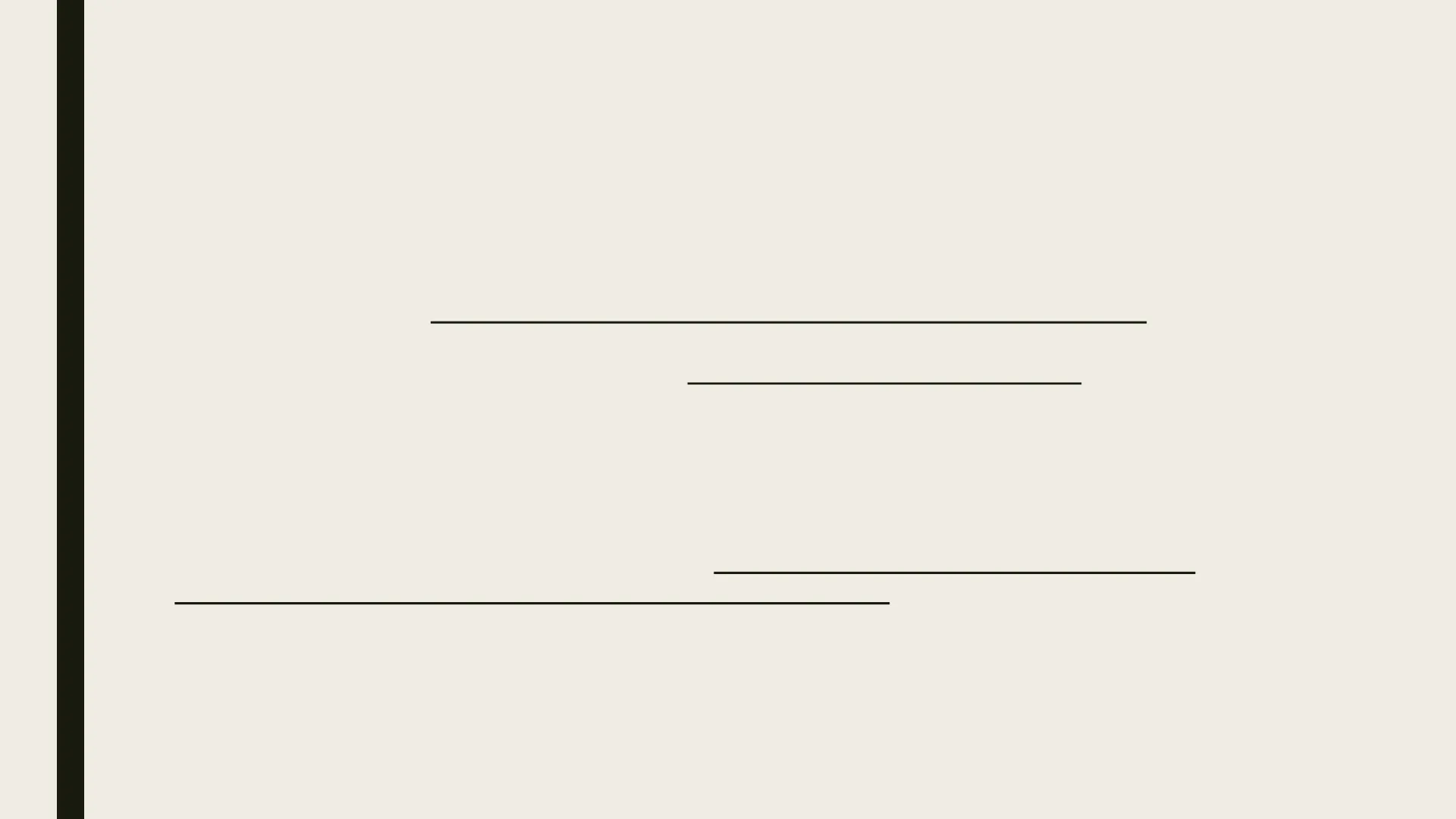
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Il Decadentismo
I
IL DECADENTISMO
GIOVANNI PASCOLI VS GABRIELE D'ANNUNZIO
Cos'è il Decadentismo?
1Cos'è il DECADENTISMO?
Il termine «decadentismo» deriva dal verso del sonetto intitolato «Languore» di
Verlaine e sta ad indicare il «vivere in un tempo di crisi sebbene la società esalti il
progresso».
Per i decadenti la ragione e la scienza non possono conoscere la realtà: essa è
avvolta nel mistero. Per giungere all'essenza della realtà i decadenti si
abbandonano a stati ALTERATI come la follia, la nevrosi ed il delirio, potenziate con
l'assunzione di droghe.
Per i decadenti l'arte è lo strumento di conoscenza migliore poiché celebra sé
stessa (è autocelebrativa) e perciò non deve rendere conto. Questo culto per l'arte
dà vita a una diramazione del decadentismo nell'ESTETISMO.
I temi principali del decadentismo sono: la malattia, la perversione sessuale,
l'angoscia, l'esaltazione della vita e il culto della forza.
Lo stile di scrittura che si diffonde è il romanzo psicologico (il cui massimo
esponente è Oscar Wilde ne «Il ritratto di Dorian Grey») che si basa sulla poetica
dell'introspezione.
L'Estetismo
L'Estetismo
Come abbiamo detto, l'estetismo è una diramazione del decadentismo, una sorta
di sottogruppo. L'arte è vista dai decadenti come primo strumento di conoscenza.
Gli artisti di conseguenza vengono considerati «veggenti», persone capaci di
spingere lo sguardo più in là dove l'uomo comune non vede.
L'arte, secondo questa poetica, coincide con «il bello» così il culto quasi
«religioso» che i decadentisti hanno per l'arte diventa culto del bello e quindi
estetismo.
L'arte celebra soltanto sé stessa allontanando da sé le intenzioni utilitaristiche
della politica e della morale.
L'artista decadente si allontana anche dalla «cultura di massa» molto diffusa
agli inizi del '900
Tecniche espressive del decadentismo
Tecniche espressive del
decadentismo e altri still
Oltre all'arte figurativa e pittorica si diffonde anche la musica utilizzata, dai
decadenti, come mezzo di espressione, come una parola.
In questo senso gli artisti (sia poeti che pittori che musicisti) decadenti utilizzano
molte metafore, simboli, analogie per alludere ad altro, rifacendosi alle
tematiche già citate (la stanchezza esistenziale, la perversione, l'angoscia, la
pienezza vitale ecc)
In questo contesto si sviluppa un genere poetico chiamato «poesia simbolista», in
cui cioè ogni parola diventa «simbolo» di una parte di realtà. Di questa poetica
fanno parte Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio.
D'Annunzio e Pascoli a confronto
I
D'ANNUNZIO E PASCOLI
A CONFRONTO
Le vite di Gabriele D'Annunzio
ILE VITE
Gabriele D'Annunzio
Gabriele D'annunzio nasce a Pescara nel 1863 in una famiglia borghese.
Nel 1879 a soli 16 anni pubblica la sua prima opera in versi che ottiene un discreto
successo.
Nel 1881 si trasferisce a Roma per gli studi universitari che abbandona per concedersi i
divertimenti giovanili della capitale.
Acquista grande notorietà sia grazie alle sue scritture in prosa e in versi, spesso con
contenuti erotici, sia grazie al suo stile di vita stravagante (fatto di avventure, lusso,
duelli). Con questo si procura la fama di «esteta».
Intorno al 1890 si trasferisce a Napoli dove lavora per il quotidiano «Il Mattino».
Negli stessi anni il filosofo tedesco Nietzsche elabora il mito del «Superuomo».
Rifacendosi al pensiero del filosofo D'Annunzio tenta di entrare anche nella vita politica
italiana come deputato parlamentare dell'estrema destra nel 1897.
Prende il soprannome di «poeta vate» come guida spirituale oltre che poetica.
Gabriele D'Annunzio e la Grande Guerra
LE VITE
Gabriele D'Annunzio
Dopo lo scoppio della Grande Guerra, D'Annunzio si schiera con gli interventisti e si
arruola volontario a 52 anni.
Dopo la guerra organizza una marcia volontaria per l'occupazione della città di Fiume.
D'Annunzio fu grande sostenitore del partito fascista pur guardandolo con sospetto.
Il poeta muore nel 1938 nella sua villa a Gardone Riviera.
Il mito del Superuomo di Nietzsche
1
CCos'è davvero il «mito del Superuomo» di
Nietzsche
Per anni considerato erroneamente l'iniziatore del mito di supremazia ariana preso in
considerazione da Hitler, il mito del «Superuomo» di Nietzsche aveva poco a che
vedere con l'ideazione di un uomo «migliore, superiore agli altri uomini».
Il «Superuomo» o anche chiamato «Oltreuomo» di Nietzsche non è altro che una
condizione morale, una figura metaforica.
Nietzsche afferma nella celebre frase «Dio è morto» che in realtà sono morti quei
valori morali e religiosi che hanno segnato un'epoca. Il Superuomo (o Oltreuomo) è
colui che di fronte alla «morte» di questi valori anziché abbattersi si sente libero dalle
catene dei falsi valori etici stabiliti dalla società e se ne crea di nuovi personali.
Più in generale l'Oltreuomo è colui che di fronte alla «morte di Dio» riesce a
costruire la PROPRIA RESPONSABILITA' sulle proprie azioni e credenze,
indipendentemente da ciò che detta la società religiosa, morale e politica.
Purtroppo Nietzsche è stato riletto sbagliando, successivamente alla morte, in chiave
suprematista, e spesso utilizzato come giustificazione delle credenze razziste ed
eugenetiche del totalitarismo nazista.
Lo stile e le opere di D'Annunzio
Lo stile e le opere - D'Annunzio
Tra le opere principali troviamo sia romanzi che componimenti poetici.
Tra i romanzi troviamo «Il Piacere» scritto nel 1889 (trama: Andrea Sperelli, esteta, vede
fallire il progetto di fare della propria vita un'opera d'arte.)
«Giovanni Episcopo» pubblicato nel 1891 e «L'Innocente» del 1892.
In quasi tutti i romanzi i protagonisti sono uomini, di solito deboli attratti dalla decadenza
e dalla morte. Queste due sono rappresentate di solito dai personaggi femminili di cui
uno rappresenta la perdizione e i piaceri l'altro rappresenta la morale che si dovrebbe
seguire.
Nelle opere poetiche troviamo: «Primo vere» e «Canto novo» scritte tra il 1879 e 1882;
successivamente abbiamo le prime raccolte tra cui la raccolta «Poema Paradisiaco».
Poi si passa al periodo delle Laudi, raccolte di poesie che D'Annunzio raccoglie in 5 volumi.
Il 3 volume in particolare ALCYONE (scritto nel 1904) rappresenta per l'autore la fusione tra
l'IO e la NATURA. Qui D'Annunzio utilizza un gran numero di metafore e simboli.
Le vite di Giovanni Pascoli
LE VITE
Giovanni Pascoli
Giovanni Pascoli nasce nel 1855 a San Mauro di Romagna, in una famiglia numerosa e
piuttosto agiata. Nel 1867 il padre viene assassinato.
Dopo la morte del padre la famiglia si trova in difficoltà economiche e nel corso degli anni
successivi Pascoli perderà anche la madre, una sorella e due fratelli.
Pascoli si iscrive alla facoltà di Lettere di Bologna e si avvicina alle idee socialiste.
Dopo la laurea Pascoli insegnò prima al liceo e poi all'unversità.
Il poeta riesce così a ricongiungere il nucleo familiare chiamando a vivere con sé le
due sorelle.
Dopo il matrimonio di una delle due Pascoli si getta nello sconforto: l'attaccamento
morboso alla famiglia rivela la fragilità del poeta che non riesce ad avere legami
significativi con l'esterno.
Parallelamente all'insegnamento Pascoli pubblica le sue raccolte poetiche: «Myricae»
(1891), «I poemetti» (1897), «Canti di Castelvecchio» (1903), «Poemi conviviali» (1904)
Tematiche della poetica di Pascoli
Tematiche della poetica di Pascoli
Anche Pascoli come gli altri poeti decadenti utilizza il simbolismo nelle
sue poesie tramite l'inserimento di analogie, metafore e simboli.
Pascoli presenta la sua visione della realtà nel saggio «Il Fanciullino»:
per Pascoli il poeta coincide con il fanciullo che sopravvive nell'animo di
ognuno. Questo fanciullo vede tutte le cose come se fosse la prima
volta, cioè, con meraviglia e stupore.
Per Pascoli sono degni della poesia gli argomenti più umili, fatti di
piccoli particolari.
La poesia di Pascoli è caratterizzata da un tono nostalgico verso
quelli che sono i momenti dell'infanzia che a lui sono stati negati a
seguito della morte del padre (e delle successive disgrazie).
D'Annunzio e Pascoli a confronto
D'Annunzio e Pascoli a confronto.
- D'Annunzio incarna perfettamente
l'ideale dell'esteta: viaggi, lussi,
donne, imprese avventurose, persino
nel corso della sua carriera politica.
- La sua poesia è un rimando all'lo: la
natura si fonde con il sé di ogni
uomo, la magnificenza della natura
è anche magnificenza dell'uomo.
- Crede nel carattere del Superuomo
come «uomo superiore» che incarna i
principi dell'estetismo e fa della sua
vita un'opera d'arte (ambizione di
D'Annunzio fin dal romanzo «Il
Piacere»)
- Gli argomenti da trattare devono
essere sfarzosi e rimandare sempre
all'idea di maestosità
-
Pascoli vive una vita cercando di
rincorrere i ricordi di un'infanzia felice e
spensierata, riportandola nella vita adulta,
senza mai riuscire a creare una rete di
legami affettivi.
-
La sua poesia è intrisa di nostalgia: nella
descrizione della natura vi è un senso di
pace. La meraviglia della natura è anche la
meraviglia del bambino.
-
Crede nel carattere del «Fanciullino» il
bambino che è all'interno di noi e che va
stimolato poiché questo sentimento
infantile (in senso positivo) guarda al
mondo con meraviglia e immaginazione.
-
Gli argomenti da trattare sono quelli umili,
per Pascoli la poeticità è nelle piccole
cose.