Il metabolismo dell'azoto: degradazione di proteine e amminoacidi
Documento della Prof.ssa Maria Letizia Penolazzi sul metabolismo dell'azoto. Il Pdf esplora la degradazione delle proteine e degli amminoacidi, l'eliminazione dello ione ammonio e il ruolo del fegato nel catabolismo, utile per studenti universitari di Biologia.
Mostra di più12 pagine
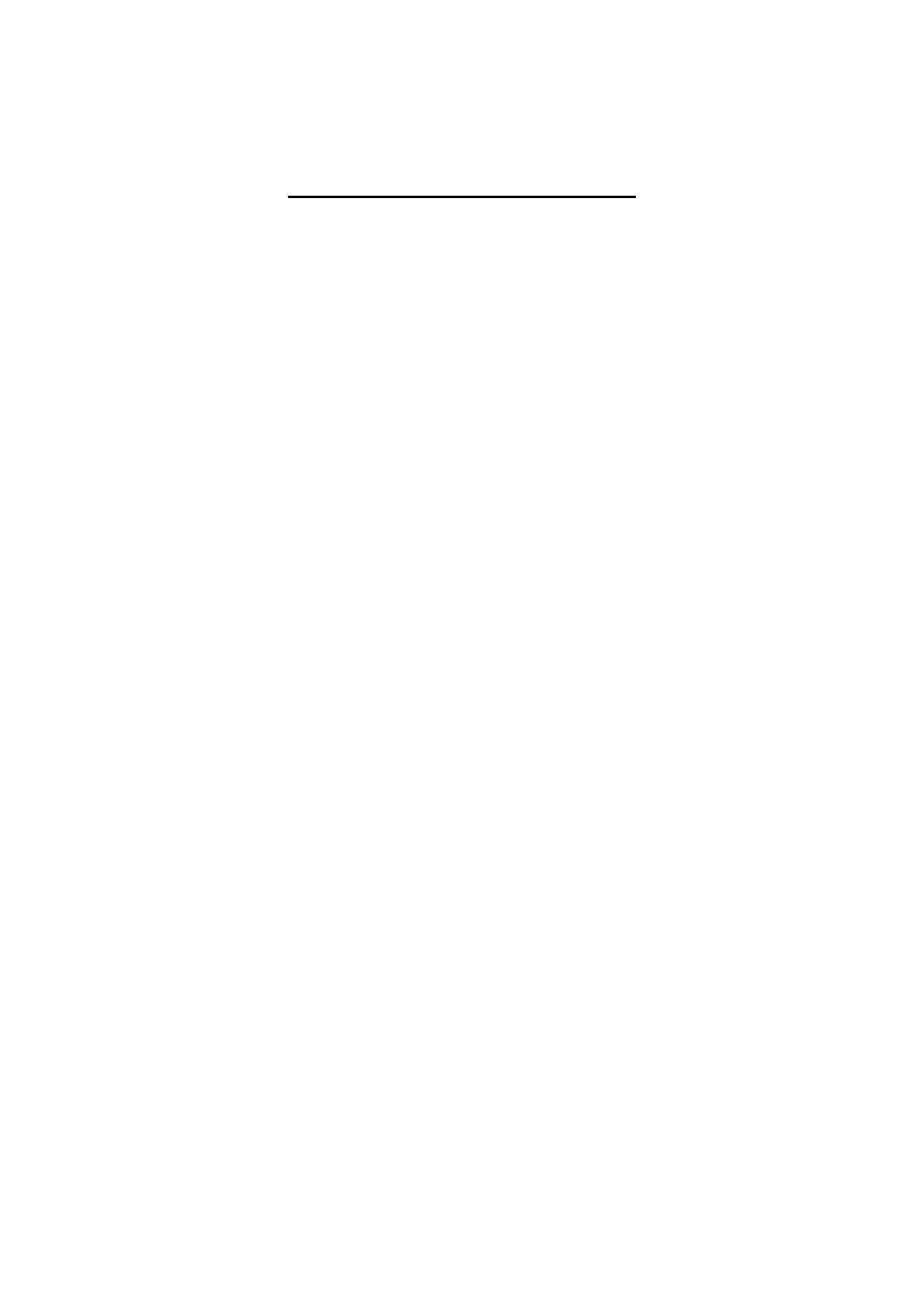

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Il metabolismo dell'azoto
Biochimica II e biologia molecolare, Lezione 24, 09/11/2023
Prof.ssa Maria Letizia Penolazzi
IL METABOLISMO DELL'AZOTO
La professoressa suggerisce di andarsi a riprendere le cose già viste per altre macromolecole che, come sistema di
neosintesi, degradazione e sistema enzimatico, sono simili a quelle che affronteremo oggi.
La prima parte della lezione è legata alla degradazione delle proteine e a come arrivano gli amminoacidi alla cellula;
la seconda parte riguarda lo smaltimento dello ione ammonio, punto chiave della via catabolica che affronteremo: quindi
come la cellula, e l'organismo in generale, cerca di eliminare una molecola che è tossica.
Introduzione agli amminoacidi
Introduzione: gli amminoacidi (aa)
Si sottolinea il fatto che si sta parlando di sostanze che non posso essere usate come deposito, non hanno una funzione
di stoccaggio, ma hanno una funzione specifica: gli aa sono le componenti le proteine e le proteine hanno una funzione
specifica all'interno del nostro organismo (non esistono le proteine di riserva).
Arrivo degli amminoacidi nell'organismo
Gli aa arrivano nel nostro organismo in vari modi:
- a seguito di degradazione di proteine cellulari, già presenti nel nostro organismo: le proteine hanno il
cosiddetto 'turnover', hanno un'emivita, infatti ci sono proteine che rimangono a disposizione della cellula
per pochi secondi, e altre che invece rimangono per più di 100 ore (dipende dalla funzione della proteina
stessa); - a seguito di degradazione di proteine alimentari, giunte tramite la dieta: la quantità di proteine che arriva
dipende dal tipo di dieta che abbiamo. - a seguito di degradazione delle proteine del corpo: la maggiore componente proteica del nostro organismo
è rappresentata dal tessuto muscolare; in una condizione di digiuno prolungato, ovvero quando l'organismo
non ha più niente da bruciare, anche se da un punto di vista energetico non è molto favorevole (la quantità
di energia che viene liberata dall'azione catabolica su un aa è irrisoria, il concetto verrà ripreso in seguito),
inizia ad essere intaccata la massa muscolare, con conseguente atrofizzazione dei muscoli e tutto quello che
ne deriva.
Scopo del turnover proteico
Le cellule quindi si trovano della condizione di dover sintetizzare e degradare continuamente le proteine. Lo
scopo di questo turnover è di:
- avere a disposizione dei nutrienti pronti all'uso: in situazioni estreme anche le proteine possono
rappresentare una fonte di energia - eliminare le proteine difettose: è possibile che le proteine arrivino o fin dall'inizio o successivamente a
subire modificazioni che sono considerate dannose per la cellula e quindi devono essere eliminate - esercitare un preciso controllo metabolico: in parte legato al controllo genomico, ovvero in condizioni
particolari è possibile che non ci sia soltanto un'attivazione o una disattivazione di un enzima, ma anche che
cambi il numero di molecole di quell'enzima presenti, quindi il fatto di cambiare il numero di molecole
1presenti può avere varie possibilità: o il gene da cui deriva quella proteina viene trascritto più o meno
lentamente, oppure quella proteina, una volta sintetizzata, viene eliminata. Questo dev'essere finemente
controllato, perché avere un enzima stabile è diverso dall'avere un enzima che dura dieci millisecondi,
dunque è necessario comprendere l'importante della regolazione di questo passaggio.
Contributo al pool di amminoacidi
Quindi a questo "pool" di aa contribuisce:
- idrolisi delle proteine della dieta
- idrolisi delle proteine dei tessuti
- aa liberi, che arrivano alla cellula
- aa di neosintesi: alcune cellule del nostro corpo sono in grado di sintetizzare questi aa a partire dai
componenti
Regole fondamentali sugli amminoacidi
Si procede ad una rassegna di "regole" da tenere sempre a mente che riguardano gli aa.
- Gli aa non sono conservati: come le proteine, che posso avere varie funzioni (strutturali, di catalisi, di
membrana, ecc .. ), anche gli aa non possono essere conservati, infatti all'interno della cellula non ci sono
delle vescicole che rilasciano gli aa (meccanismo che funziona per le gocce lipidiche), ma semplicemente
sono presenti - Gli aa vengono in parte riciclati in nuove proteine, ma molti aa sono la
partenza per derivati amminoacidici - Alcuni aa possono venire catabolizzati
Struttura e degradazione degli amminoacidi
H
R
H2N-C-COOH
La struttura dell'aa: C centrale, gruppo amminico NH2, gruppo carbossilico COOH, H e R, che detta le
caratteristiche chimiche di ogni aa.
Ogni volta che si colpisce un aa, bisogna distinguere tra le vie che portano all'eliminazione del gruppo
carbossilico e le vie che portano all'eliminazione del gruppo amminico. L'eliminazione del gruppo amminico
determina la formazione dello ione ammonio, e quindi quella fase che le cellule del nostro organismo devono
innescare per eliminare quello che è tossico.
Il metabolismo degli amminoacidi
L'organo principale deputato ad occuparsi del catabolismo degli aa (e anche di alcune vie anaboliche) è fegato,
con gli epatociti.
Molti enzimi collegati a tutta una serie di modificazioni degli aa e agli spostamenti e all'eliminazione dello
ione ammonio sono ubiquitari, altri invece sono specifici di alcuni organi: ad esempio, alcuni tipi di
transaminasi (verranno riprese in seguito) sono indicatori di un danno tissutale perché se si trovano in circolo
significa che sono state danneggiate alcune cellule di alcuni tessuti, visto che si sa che quelle sono presenti
solo in un determinato tessuto.
Il fegato è un organo generoso: qui avvengono molte cose e quello che succede nel fegato viene condiviso con
le altre cellule di altri organi. Anche in questo caso dunque il fegato ha un ruolo importantissimo.
Amminoacidi essenziali e non essenziali
2Come accade per gli acidi grassi, ci sono degli aa essenziali e non essenziali. Quelli essenziali sono quelli aa
le cui vie di sintesi non si sono mantenute nell'uomo, dunque da un punto di vista evoluzionistico, l'uomo non
ha la capacità di sintetizzare questi aa partendo da precursori più semplici, perché, per una serie di motivi,
alcune vie metaboliche sono particolarmente complicate, dispendiose, e sono state perse (come per gli acidi
grassi essenziali: sono stati introdotti doppi legami che fanno si che debbano essere assunti da altri organismi
vegetali).
Amminoacidi semi-essenziali
Talvolta si parla anche di aa semi-essenziali: per alcuni motivi, come durante le fasi di crescita o in
concomitanza di una gravidanza (per cui c'è un altro essere vivente che sta crescendo), capita che aumenti
tanto la richiesta metabolica di un dato aa, che la quantità che l'uomo riesce a sintetizzare non riesca a tenere
il passo dell'effettivo utilizzo. Gli aa semi-essenziali sono anche chiamati "parzialmente essenziali", in quanto
l'uomo non riesce a soddisfare l'effettivo fabbisogno, ma di solito questo è collegato a situazioni fisiologiche
particolari che possono riguardare la vita dell'individuo.
Degradazione delle proteine cellulari
Degradazione delle proteine cellulari
Come detto in precedenza, gli aa possono derivare dalla degradazione delle proteine cellulari. La cellula può
ricorrere a due sistemi di proteolisi per degradare le proteine cellulari che ha a disposizione:
- Sistema lisosomiale ATP-indipendente (non serve energia): riguarda una serie di enzimi presenti nei
lisosomi, quindi un ambiente circoscritto, compartimentato in modo specifico con un doppio straterello
lipidico e che agisce su:
- proteine extracellulari
- proteine di membrana
- organelli danneggiati
- Sistema citosolico ATP-dipendente: coinvolge il proteasoma (la prof non vi si soffermerà), che funziona
grazie ad un processo di legame covalente con l'ubiquitina. L'interazione con l'ubiquitina (= sistema di
ubiquitinazione) rappresenta una sorta di marcatura, segnalazione di morte immediata per la proteina, ed
è dunque un sistema la cui regolazione è fondamentale. Vengono coinvolte le:
- proteine danneggiate
- proteine di regolazione: talvolta il fatto di avere un enzima con una funzione specifica importante
(magari di innesco di una via metabolica, ad es. quella che porta alla biosintesi di alcuni derivati
amminoacidici che regolano il ciclo cellulare), molto presente e con un'emivita che non viene
regolata correttamente, parte in modo indiscriminato un sistema di duplicazione del DNA nel ciclo
cellulare che può essere l'innesco di una situazione patologica invece che di una situazione
controllata. Dunque, specialmente per le proteine di regolazione, è fondamentale avere un sistema
preciso che vada a colpire una zona specifica della sequenza e che determini in modo specifico
l'eliminazione della proteina. - proteine citosoliche
3Sia il sistema lisosomiale sia quello citosolico vanno a condizionare diversamente la velocità di turnover
delle proteine stesse.
Ubiquitinazione
Ubiquitinazione
La presenza dell'ubiquitina e il fatto che siano presenti nella struttura primaria delle sequenze in determinate
posizioni che vengono riconosciute da essa, dice molto sull'emivita della proteina stessa. Nello specifico, la
proteina si attacca all'ubiquitina, che trascina la proteina nel proteasoma, al cui interno avviene l'idrolisi: la
Proteina
destinata
alla
degradazione
Un enzima
attacca
l'ubiquitina alla
proteina ...
... che viene riconosciuta
da un proteasoma.
L'ubiquitina viene
rilasciata e riciclata
Il proteasoma idrolizza
a proteina bersaglio.
Ubiquitina
80
Esiste la regola dell'N-terminale: ogni aa che
compone la proteina ha un numero, che parte dall'1,
Proteasoma
che è il residuo presente nella parte N-terminale,
fino a, ad esempio, 400, che è l'ultimo aa presente
nella parte C-terminale. Quindi a seconda di alcune sequenze amminoacidiche presenti nell'N-ter, può esserci
un sistema diverso di regolazione della stabilità: ad esempio, se ci sono tante serine, di solito la regola dice che
la durata dell'emivita è maggiore rispetto ad avere l'arginina, oppure se ci sono delle sequenze PEST (prolina,
glutammato, serina, treonina) la regola suggerisce una durata molto bassa dell'emivita della proteina che le
presenta nella parte N-ter.
Dunque uno dei sistemi che si occupa della degradazione delle proteine cellulari coinvolge l'ubiquitina, una
molecola particolare che è implicata in un meccanismo di interazione
0
covalente che prevede l'impiego di tre diversi tipi di enzimi e consiste in tre
Ubiquitina
C
O
diversi step:
- HS
El
+ ATP
1. C'è l'ubiquitina, arrivano gli enzimi chiamati E1, enzimi attivatori
dell'ubiquitina. Avviene il legame dell'ubiquitina con El, che determina
la formazione di un legame tioestere e un intermedio adenilato con alla
fine la liberazione di AMP e pirofosfato; la forza energetica di questo
passaggio è legata al pirofosfato: grazie alla pirofosfatasi poi vengono
liberati due P inorganici ed è questo che da la spinta alla reazione. Alla
fine del primo step avremo dunque l'ubiquitina attivata.
2. Arrivano E2, enzimi che legano l'ubiquitina. Avviene un passaggio di
consegne: El, enzima attivatore dell'ubiquitina la fa passare a E2,
enzima che la lega l'ubiquitina
3. Arriva la proteina. L'ubiquitina si lega ad un residuo di lisina di una
proteina bersaglio individuata come target dell'ubiquitina; l'ubiquitina è
in grado di legare questa lisina grazie all'interazione con l'ubiquitina
0
Ubiquitina
-C-S-
El
E2
- HS -
- HS
El
0
Ubiquitina
-C-S-
E2
HN -Lys-
Proteina bersaglio
E3
HS -
E2
0
Ubiquitina
C-NH-Lys-
Proteina bersaglio
1
Cicli ripetuti portano all'attacco
di un'altra ubiquitina
4
proteina non esiste più, rimangono gli aa che la
componevano, che verranno poi riciclati in altra
maniera.
AMP + PP