Il processo privato romano: dalle legis actiones alle cognitiones extra ordinem
Documento sul processo privato romano, partendo dalle legis actiones. Il Pdf esplora le diverse tipologie di processo, inclusi i rimedi pretori e le cognitiones extra ordinem, fornendo una panoramica completa dell'evoluzione del diritto processuale romano per l'Università.
Mostra di più18 pagine
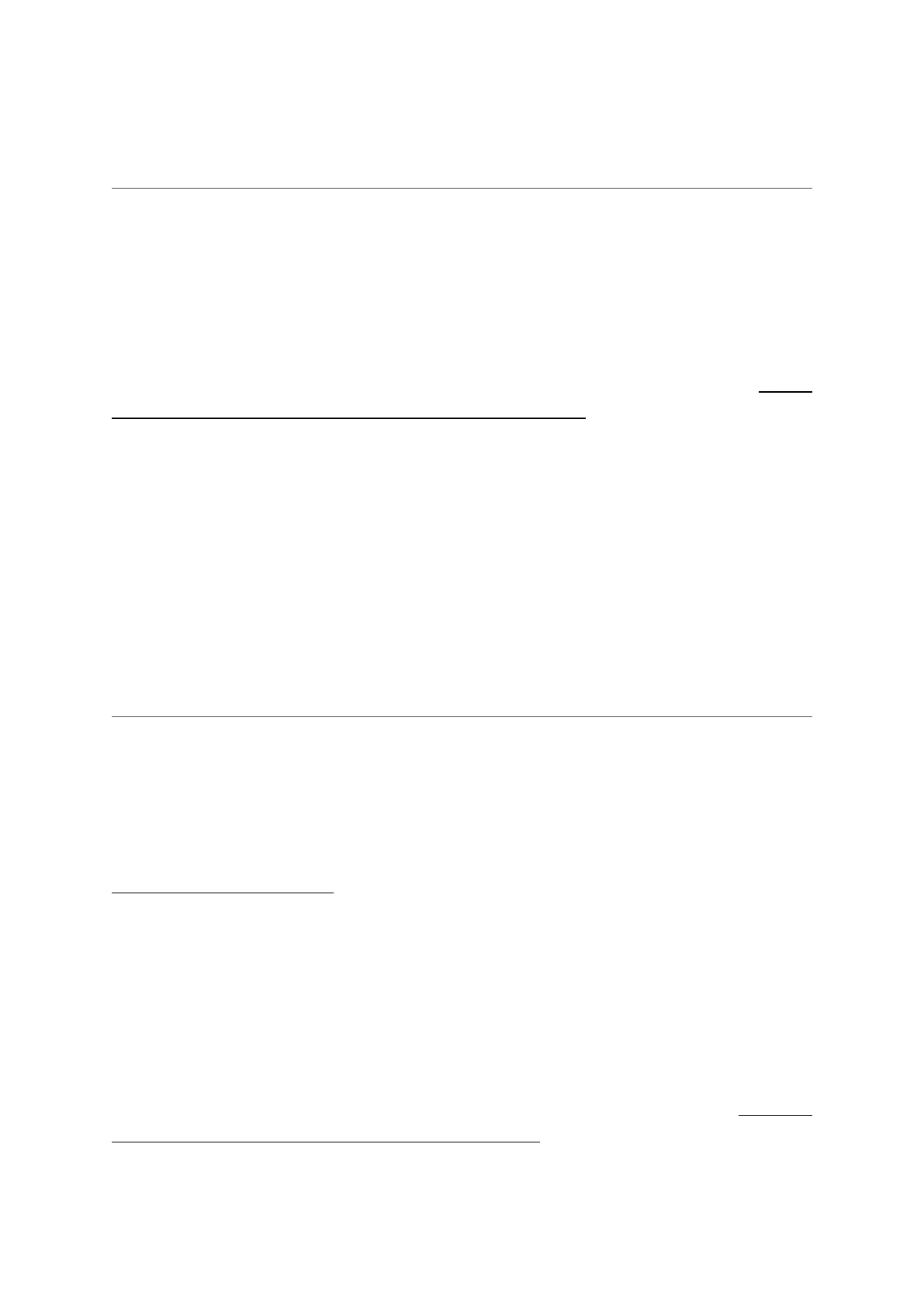
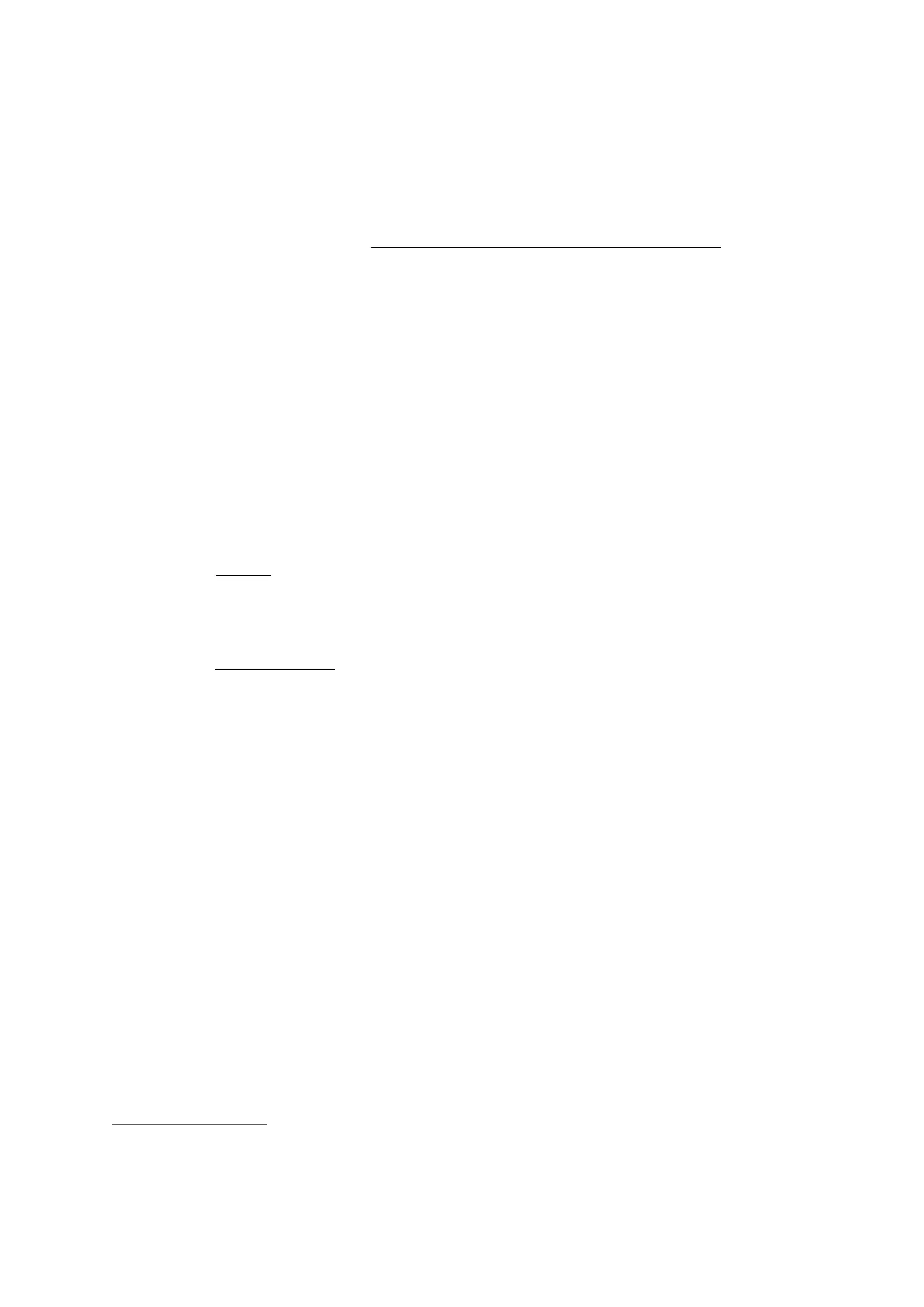
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Il processo privato romano
Le legis actiones
Cos'è il processo privato?
È un complesso di attività dirette ad accertare o realizzare un diritto soggettivo, cioè la pretesa di un soggetto che viene riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo.
Il soggetto titolare del diritto soggettivo è titolare del potere di azione. Ha il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni.
Tipologie di processo romano:
- Processo per legis actiones;
- Processo formulare
- Cognitio extra ordinem
- Processo postclassico
- Processo giustinianeo.
Processo per legis actiones
Processo dell'epoca arcaica. È l'unico processo privato fruibile da parte dei cives in età arcaica -> è solo per i cittadini romani.
Caratteristiche del processo
Stesse dello ius dell'epoca:
- Oralità
- Formalismo: per il compimento di certi atti bisognava pronunciare certa verba.
Tipi di processo
Quando parliamo di processo privato per legis actiones noi facciamo riferimento a 5 riti diversi di processo ovvero
- 3 legis actiones di cognizione, altrimenti dette dichiarative, cioè volte ad
accertare situazioni giuridiche incerte o controverse.
- Legis actio sacramenti
- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem (per crediti che nascevano da stipulatio, divisioni di eredità comuni, divisione di singoli beni)
- Legis actio per condictionem
- 2 legis actiones esecutive, volte a realizzare posizioni giuridiche certe
- Legis actio per manus iniectionem
- Legis actio per pignoris capionem
Struttura del processo per legis actionem
- entrambe le parti: attore e convenuto. L'attore è colui che chiama in giudizio (in ius vocatio). Il convenuto è colui che è costretto a presentarsi
- Un magistrato con Iurisdictio (che dal 367 a. C. Con leggi Liciniae Sextiae era il pretor)
- È un processo bipartito:
- Fase in iure: si fissavano i termini giuridici della lite, alla fine di questa fase, il pretore nominava un iudex1, giudice davanti al quale si svolgeva la seconda fare
- Fase apud iudicem, davanti al iudex
Legis actio sacramenti
Qualificata come generalis perché era utilizzabile per ogni pretesa (riconosciuta) per la quale non fosse prescritto l'esercizio di un'altra legis actio. Poteva essere:
- in rem
- In personam
Legis actio sacramenti in rem
Impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute, era con essa che il proprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli o l'erede che affermava l'eredità fosse sua. La fase in iure si svolgeva davanti al pretore, dove comparivano entrambi gli intendenti e veniva portata la cosa controversa (o un suo simbolo). Poteva essere utilizzata anche per affermare la proprietà su uno schiavo. Se era un terreno ad essere conteso si portava una zolla di terra.
- La parte attrice, tenendo in mano una festuca2, faceva un atto di apprensione della cosa, cioè la toccava e affermava solennemente (tramite certa verba) che gli appartenenza. (vindicatio dell'attore) Ad esempio, se oggetto di controversia era un servo, i certa vera erano i seguenti: Hunc ego hominem ex iure Quiritium.
- L'altra parte compiva gli stessa gesti e pronunciava le stesse cose (controvindicatio del convenuto)
- Il pretore ingiungeva alle parti di deporre la cosa (mittite ambo tren)
- Le parti obbedivano all'intimazione del pretore e si sfidavano al sacramentum (giuramento solenne poi divenuto una scommessa3 da pagare all'erario in caso di soccombenza)
- Prestato il giuramento il pretore emanava un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso interinale o provvisorio della cosa al soggetto che aveva più garanti, che aveva il ruolo di garantire che, una volta soccombente, la parte che avesse il possesso della cosa l'avrebbe restituita.
A questo punto si chiudeva la fase in iure e si apriva la fase apud iudicem:
- Sia l'attore che il convenuto cercavano di dimostrare al iudex che la cosa gli apparteneva. L'onere della prova gravava su entrambe le parte perché entrambe avevano affermato che la cosa gli appartenesse.
- Il giudice raccoglieva le prove e si pronunciava se quale sacramenta fosse iustum o iniustum 4 (conforme o no al Ius).
- Chi non risultava proprietario veniva dichiarato soccombente e pagava all'erario l'importo del sacramentum.
Legis actio sacramenti in personam
Tutela di posizioni giuridiche soggettive relative (come i crediti) e non quelle assolute.
- il creditore insoddisfatto agiva affermando "aio te mihi per mila dare oportere. Id postulo aies an neges"
- Il debitore poteva
- Ammettere (confessio in iure): interrompeva il rito e il debitore doveva adempiere entro 30 giorni. Se non lo faceva -> legis actio per manus iniectionem)
- Negare -> le parti si sfidavano al sacramentum nelle stesse modalità di cui sopra
- Se il convenuto era riconosciuto debitore ma persisteva nell'inadempimento, il creditore poteva agire con la legis actio per manus iniectionem, che è una legis actio esecutiva.
Legis actio per manus iniectionem
Con essa si agiva per realizzare posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi avesse fatto rinvio. Poteva essere esperita:
- per disposizione della Lex Duodecim Tabularum per l'esecuzione di un giudicato (sentenza in cui l'avversario è stato riconosciuto come debitore)
- Per difetto di iudicatum (per via di confessio) per situazioni riconosciute a priori come certe
Procedimento
- creditore e debitore si presentavano davanti al magistrato giusdicente. Il presunto creditore pronunciava con certa verba la causa del credito che gli spettava, indicava il debitore, dichiarava l'importo e la volontà di manus inicere.
- Il debitore poteva:
- indicare un vindex il cui intervento l'avrebbe sottratto alla manus iniectio. Il vindex poteva
- Negare il debito e contestare il diritto dell'attore di procedere alla manus iniectionio. Se il vindex fosse stato dichiarato soccombente, sarebbe stato condannato al duplum (doppio dell'importo del debito)
- Non indicare un vindex -> il pretore pronunciava l'addiction del debitore in favore del creditore, che avrebbe potuto trascinare con se l'addictus in catene per 60 giorni. In questi 60 giorni il creditore avrebbe dovuto condurre il debitore in 3 mercati diversi (nundinae), dovre proclamava l'importo del debitore per dare modo a qualcuno di riscattarlo pagando la somma. Se nessuno lo riscattava il debitore poteva essere venduto come schiavo trans Tiberim (fuori Tevere) o essere ucciso. Se fossero stati più creditori potevano anche suddividersi il corpo (Partes secanto).
Il processo formulare
Il processo del Pretore - seconda tipologia di processo privato. Perché il processo del pretore? Nel processo per legis actiones trovavano tutela solo situazioni giuridiche riconosciute dal ius civile e, pertanto, potevano usare questo processo solo i cives. Con l'intensificarsi delle relazioni commerciale dal III secolo a. C. sorse la necessità di riconoscere nuove posizioni giuridiche (stranieri) con l'esigenza di strutture diverse. Provvide il Pretore urbano facendo cosa? Consentendo e/o imponendo agli interessati di litigare per formulas. Processo che si svolgeva davanti al Pretore fondato sui suoi poteri di Iurisdictio e Imperium. La formula era l'atto scritto che regolava lo svolgimento del processo formulare nel diritto romano. Era predisposta dal pretore nella fase in iure e consegnata al giudice privato nella fase apud iudicem per risolvere la controversia. Con l'introduzione del processo per formulas si poteva litigare sia per legis actiones sia litigare per formulas. C'è stato un periodo, infatti, in cui il processo per formulas di età successiva si affianca il processo per legis actiones. Tuttavia, ben presto un Praetor non bastava più e nel 242 a.C. fu istituito un'altra figura di Pretore, il Praetor Peregrinus, che si affiancava all'urbanus col compito particolare di giudicare in controversie tra romani e stranieri o anche solo tra stranieri. Nel frattempo le legis actiones erano sempre più inadeguate a una Roma che entrava in contatto con altre popolazioni. Erano troppo formalistiche e furono progressivamente soppresse. Intorno al 130 a. c. Una lex Aebutia abolì la legis actio per condictionem poi nel 17 a. C. la Lex Iulia Iudiciaria di Augusto abolì tutte le legis actiones. Al processo formulare vennero cosi attribuiti effetti per il ius civile e con la Lex Iulia ludiciaria divenne il processo ordinario per tutta l'età classica.
Caratteri del processo formulare
- carattere unitario: a differenza del processo per legis actiones, il processo formulare aveva un solo procedimento che poteva essere impiegato per l'esercizio delle varie actiones (no distinzione tra dichiarativo ed esecutivo); Per ogni actio, nell'editto era previsto una diversa forma di azioni.
- Era aperto anche agli stranieri;
- Era diviso in due fasi: in iure e apod iudicem (il carattere unitario era riferito alle 5 tipologie di processo per legis actiones. Il processo formulare, benché unico, era sempre bipartito);
- Le formulae erano scritte (altra importante differenza col processo per legis actiones);
- Anche nel processo formulare vi era la in ius vocatio5, necessario per assicurare la presenza della parte convenuta. La in ius vocatio era un atto privato dell'attore senza la partecipazione dell'organo pubblico. Non si aveva più la facoltà di portare il convenuto al processo con la forza, ma la sua presenza era assicurata a monte dal Pretore con la sua missio in bona, clausola presente nell'editto del Pretore che prevedeva che, qualora il convenuto non si fosse presentato, l'attore veniva immesso in tutti i suoi beni (coazione indiretta)
- A questa in ius vocatio si affiancò il vadimonium, il convenuto prometteva all'avversario, tramite stipulatio, di comparire davanti al magistrato nel giorno concordato. In questo modo il convenuto si sottraeva all'obbligo di seguire immediatamente l'attore in iure.
Fase in iure
Fase in cui venivano fissati i termini giuridici della lite. Come nel progetto per legis actiones era necessaria la presenza di entrambe le parti e del magistrato con iurisdictio. Il magistrato, approvato il testo della formula (iudicium) concordata tra le parti, concedeva l'azione richiedente (datio actionis), così che la lite potesse proseguire fino alla sentenza. I magistrati giusdicenti erano:
- pretore urbano
- Pretore peregrino
- Edili curuli
- Governatori provinciali
Tutti esercitavano la giurisdizione sulla base dell'editto. Tuttavia nel processo formulare il pretore occupava una posizione preminente, pertanto verrà considerato come unico magistrato giusdicente.