Il modello contestualistico in psicologia: interazione tra individuo e ambiente
Documento sul modello contestualistico in psicologia, che evidenzia l'importanza dell'interazione tra individuo e ambiente. Il Pdf esplora concetti chiave come previsione, controllo e comportamento nel contesto, e introduce il passaggio da un approccio problema-soluzione a uno esperienziale, utile per gli studenti universitari di Psicologia.
Mostra di più18 pagine

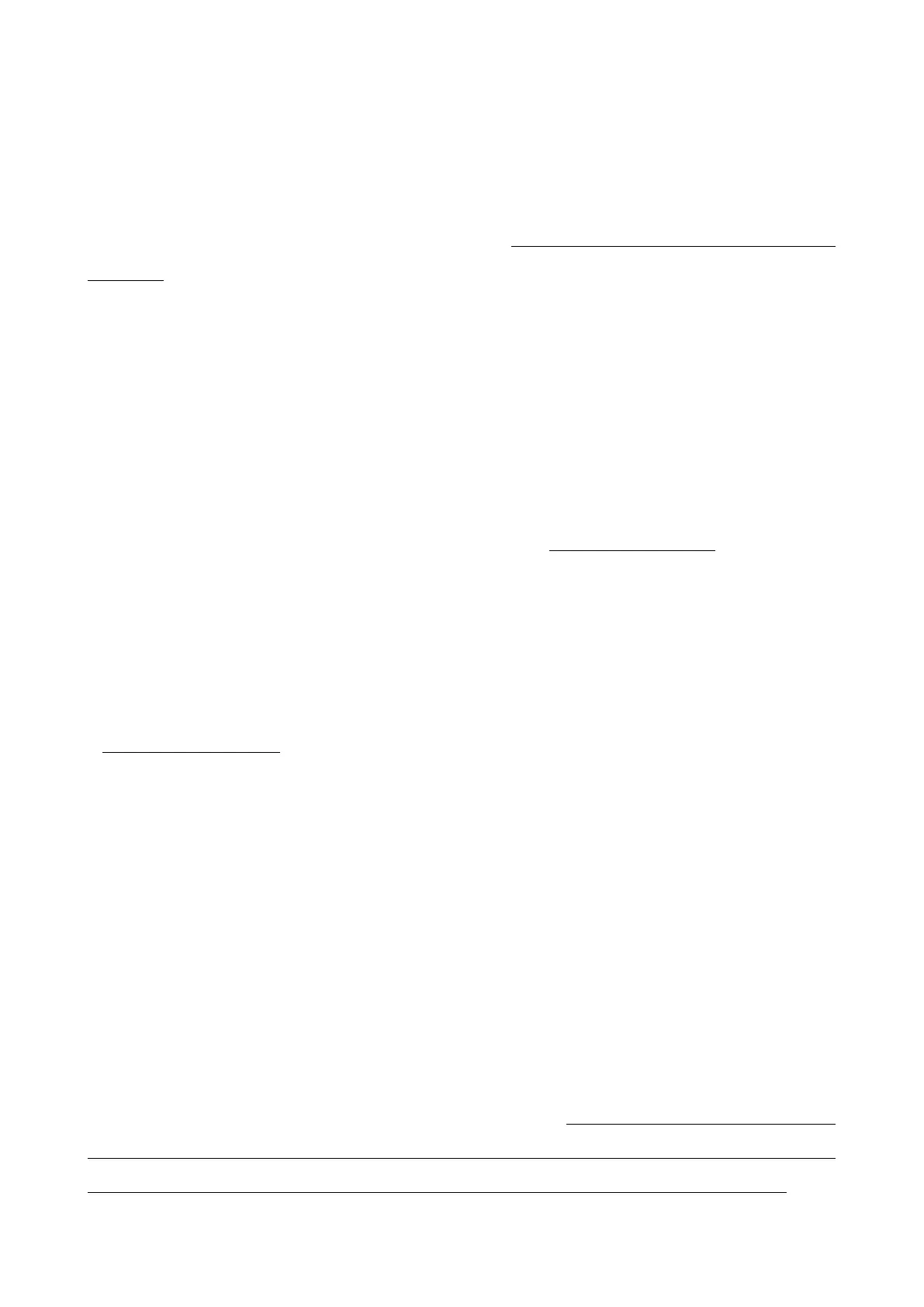
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
MODELLO CONTESTUALISTICO
Il modello contestualistico nasce dallo sviluppo della psicologia sperimentale (Wundt), che ha iniziato a studiare l'interazione tra gli organismi e il loro ambiente utilizzando il metodo scientifico. Con il tempo, questa prospettiva si è evoluta fino a includere un approccio basato sulla previsione e sul controllo delle relazioni tra individuo e contesto. Uno degli esempi più importanti di applicazione del modello contestualistico è l'analisi del comportamento (Behavior Analysis), sviluppata da B.F. Skinner. Questo approccio si basa su una rigorosa raccolta di dati per descrivere e prevedere i comportamenti attraverso il controllo delle variabili ambientali.
CONCETTI CHIAVE DEL MODELLO CONTESTUALISTICO
- Previsione > analizzare come le variabili indipendenti influenzano quelle dipendenti, ovvero come l'ambiente condiziona il comportamento;
- Controllo > manipolare le variabili indipendenti per produrre risposte specifiche da parte dell'organismo;
- Comportamento come azione-nel-contesto > ogni comportamento (manifesto, emotivo o cognitivo) è strettamente legato all'ambiente e può essere osservato, previsto e influenzato.
Il modello contestualistico considera l'organismo non come entità statica, ma in continuo divenire, poiché le sue risposte sono il risultato dell'interazione con l'ambiente. Questa visione è alla base dell'analisi a tre termini (ABC - Antecedenti, Comportamento, Conseguenze), che permette di spiegare come le esperienze pregresse e il contesto influenzino la funzione di uno stimolo.
Il modello contestualistico viene applicato nei servizi per le PcD (persone con disabilità) per comprendere come l'ambiente e le interazioni sociali influenzino il loro comportamento e la loro QdV (Qualità di vita). Alcuni aspetti fondamentali sono:
- Adattamento all'ambiente per favorire l'autodeterminazione e ridurre le barriere;
- Interventi basati sull'analisi funzionale del comportamento per modificare le condizioni antecedenti e conseguenti dei CP (comportamenti problema);
- Valutazione delle variabili individuali e contestuali, considerando sia la storia personale dell'individuo sia le condizioni ambientali momentanee (es. stanchezza, temperatura, presenza di altri individui).
Il modello contestualistico è un approccio che pone l'obiettivo sull'interazione tra individuo e ambiente, enfatizzando l'importanza di prevedere e modificare i contesti per favorire il benessere e l'apprendimento. Questo modello è particolarmente efficace nei servizi per PcD, poiché aiuta a strutturare interventi che migliorano la QdV e promuovono l'autonomia della persona.
CAMBIO DI PARADIGMA
Il cambio di paradigma rappresenta il passaggio da un modello tradizionale basato su un approccio problema-soluzione (riabilitativo, clinico, funzionale), a un modello esperienziale fondato sui valori e sulle aspettative della persona. Nel modello tradizionale, l'attenzione è focalizzata unicamente sul funzionamento della persona e sull'attesa di esiti di apprendimento tipici per l'età di riferimento. Questo modello presenta diversi limiti:
- È assente l'attesa di un esito legato alla soddisfazione personale
- Manca un'attenzione agli interventi ambientali per favorire autonomia e comunicazione.
Il modello esperienziale, invece, introduce una prospettiva valoriale, che cambia il modo di pensare e progettare gli interventi:
- Si prende in considerazione la percezione della persona rispetto alla propria qualità della vita (QdV);
- Si creano condizioni ambientali favorevoli che garantiscano l'espressione delle scelte personali, anche in situazioni di grave disabilità;
- Vengono adottate metodologie per favorire l'espressione delle preferenze, in modo da ridurre le fonti di frustrazione e aumentare il coinvolgimento attivo.
Il cambiamento chiave sta nel considerare gli interventi non come obiettivi separati, ma come tappe di un unico percorso. Tutti gli operatori coinvolti devono avere una meta comune per garantire coerenza e continuità nel supporto della persona. Questa nuova visione permette di spostare il focus dalla semplice riduzione del deficit, alla costruzione di un ambiente in cui la persona possa autodeterminarsi, svilupparsi e partecipare attivamente alla propria vita.
QUALITA' DELLA VITA (QdV) DELLE PERSONE CON DISABILITA' (PcD)
La QdV viene definita dall'OMS (1995) come "la percezione dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi". Per le persone con disabilità, Schalock (1997) descrive la QdV come: "il grado di soddisfazione nelle principali aree della vita". Brown et al., (1994) suggeriscono che il miglioramento della QdV sia correlato alla riduzione della discrepanza tra le necessità soddisfatte e quelle non soddisfatte, considerando sia una valutazione oggettiva sia una percezione soggettiva. Nel meta-dominio di Schalock e Verdugo Alonso, la QdV si articola in 8 domini (indicatori specifici per valutare la QdV delle PcD):
- Benessere fisico (salute, alimentazione, esercizio fisico);
- Benessere emotivo (autostima, esperienze positive, sicurezza);
- Benessere materiale (condizioni economiche, lavorative e abitative);
- Autodeterminazione (capacità di fare scelte, autonomia personale);
- Sviluppo personale (educazione, apprendimento continuo);
- Relazioni interpersonali (amicizie, famiglia, supporto sociale);
- Inclusione sociale (partecipazione alla comunità, accessibilità);
- Diritti ed empowerment (dignità, uguaglianza, libertà di espressione).
L'obiettivo degli interventi basato su questo meta-modello è quello di aumentare il controllo dell'individuo sul proprio ambiente, garantendo opportunità di scelta e partecipazione attiva nella società. La QdV delle PcD è un tema di grande importanza, poiché la vita delle PcD è particolarmente autodeterminata e i diritti fondamentali che per le persone a sviluppo tipico vengono dati per scontati, per le PcD invece sono da tutelare. Per questo motivo è necessario identificare degli indicatori specifici (8 domini) che possano mettere in luce gli elementi che influenzano la QdV delle PcD. Il percorso di Consesus Conference promosso dal WORLD HEALTH ORGANIZATION'S QUALITY OF LIFE (WHOQOL) ci fornisce un comune punto di riferimento per il modello di QdV per le PcD: quello ad 8 domini di Schalock e Verdugo Alonso.
QdV
- GRADO DI SODDISFAZIONE
- RIDUZIONE DELLA DISCREPANZA
- AUMENTARE IL CONTROLLO SUL PROPRIO AMBIENTE
PROPOSTA DI ATTIVITA'
ERRORI CHE SI POSSONO COMPIERE NELLA PROPOSTA DI ATTIVITÀ
- CONFUSIONE nell'organizzazione dell'attività
- COMPITI MOLTO DIFFICILI
- PROPORRE CONTEMPORANEAMENTE TUTTA LA SEQUENZA
- L'OPERATORE É PIÙ INTERESSANTE DELL'ATTIVITÀ
PER PROGETTARE TEMPO E SPAZIO
- Considerare età cronologica e non «mentale»
- Garantire individualizzazione, flessibilità, indipendenza
- Cambiare punto di osservazione
ORGANIZZARE TEMPO E SPAZIO
Aumenta
- Comprensione
- Prevedibilità
- Indipendenza
- Significati condivisi
Diminuisce
- L'ansia
- La confusione
- Il disorientamento
I CP
PROGRAMMI ESTESI DI LAVORO INDIPENDENTE
quattro principali componenti per svolgere il compito con la minor supervisione possibile:
- Analisi del compito: operazioni necessarie di cui verificare il grado di autonomia
- Organizzazione del materiale: il compito deve essere autoevidente ovvero comprendere in sé le istruzioni e le regole per portarlo a termine (ad es: ciò che si deve fare a sinistra, ciò che si fa al centro, ciò che si è terminato a destra)
- Controllo dei comportamenti problema: se il soggetto è capace di controllo posso essere usati strumenti interattivi/materiale statico
- Capacità di autorganizzazione/bisogno di aiuto- materiali diversi unico contenitore/diversi contenitori in sequenza (M.Leoni, 2016)
MATERIALI CHE PARLANO
devono saper indicare queste cose
- Cosa devo fare?
- Come?
- Dove?
- Quando?
- Per quanto tempo?
- Con chi?
- E dopo?
Fenotipi comportamentali e organizzazione dello spazio
AUTISMO E GRAVE DISABILITÀ CON COMPORTAMENTI AUTISTIFORMI
Deficit di coerenza - difficoltà a elaborare simultaneamente più stimoli per creare sistemi coerenti Necessità di lavorare sulla selezione di stimoli e sulla pulizia degli ambienti
GRAVE DISABILITÀ NEUROPSICHIATRICHE E DEMENZE
Difficoltà a integrare le informazioni sensoriali - difficoltà nel dare corretta interpretazione alla terza dimensione (profondità) - difficoltà nel vedere ciò che bianco o semitrasparente. - difficoltà nel distinguere un oggetto dallo sfondo
Caratteristiche di un'attività indipendente
- Il compito deve essere auto-evidente, quindi il materiale stesso deve esprimere chiaramente quello che la persona deve fare (evidenza dello svolgimento).
- Il compito deve mostrare indizi visivi circa la sua fine, l'attività deve mostrare da sé quando un compito è finito (evidenza della durata).
- Il compito deve essere costruito sugli acquisiti, basarsi prevalentemente su competenze che la persona possiede (acquisite), possono essere introdotti comportamenti emergenti, in percentuale molto bassa.
- Il compito deve essere semplice. I compiti complessi possono essere "spezzettati" in compiti più semplici (task analisi).
Per incrementare la Motivazione si può inserire l'immagine dei rinforzi che la persona avrà dopo aver finito il compito
I criteri di valutazione
La valutazione prevede la dimostrazione (ti faccio vedere io) e i criteri sono:
- "Acquisito" : quando la persona emette la risposta dopo la presentazione.
- "Emergente" : quando la risposta pur non corretta mostra che la persona ha "una qualche idea" su come si deve svolgere correttamente lo step.
- "Non Acquisito" : quando la persona non emette alcuna risposta.
L'AUTODETERMINAZIONE
L'autodeterminazione è un concetto fondamentale nella QdV delle persone con disabilità ed è legata al DIRITTO DI SCELTA e AL CONTROLLO PERSONALE SUL PROPRIO AMBIENTE. Le PcD evolutive hanno pochissime opportunità di effettuare scelte rispetto ai loro coetanei. Questo fenomeno viene definito IPOCONTRATTUALITA' e riguarda anche gli adulti. Secondo la Montessori, per favorire l'autonomia è essenziale adottare il principio: