Il percorso della ricerca: metodologie quantitative e qualitative in psicologia
Slide sul percorso della ricerca scientifica, distinguendo tra metodologia quantitativa e qualitativa. Il Pdf analizza il concetto di fatto sociale secondo Durkheim, l'idea di 'homo duplex' e le diverse forme di solidarietà, introducendo il funzionalismo come approccio sociologico per l'università in psicologia.
Mostra di più14 pagine
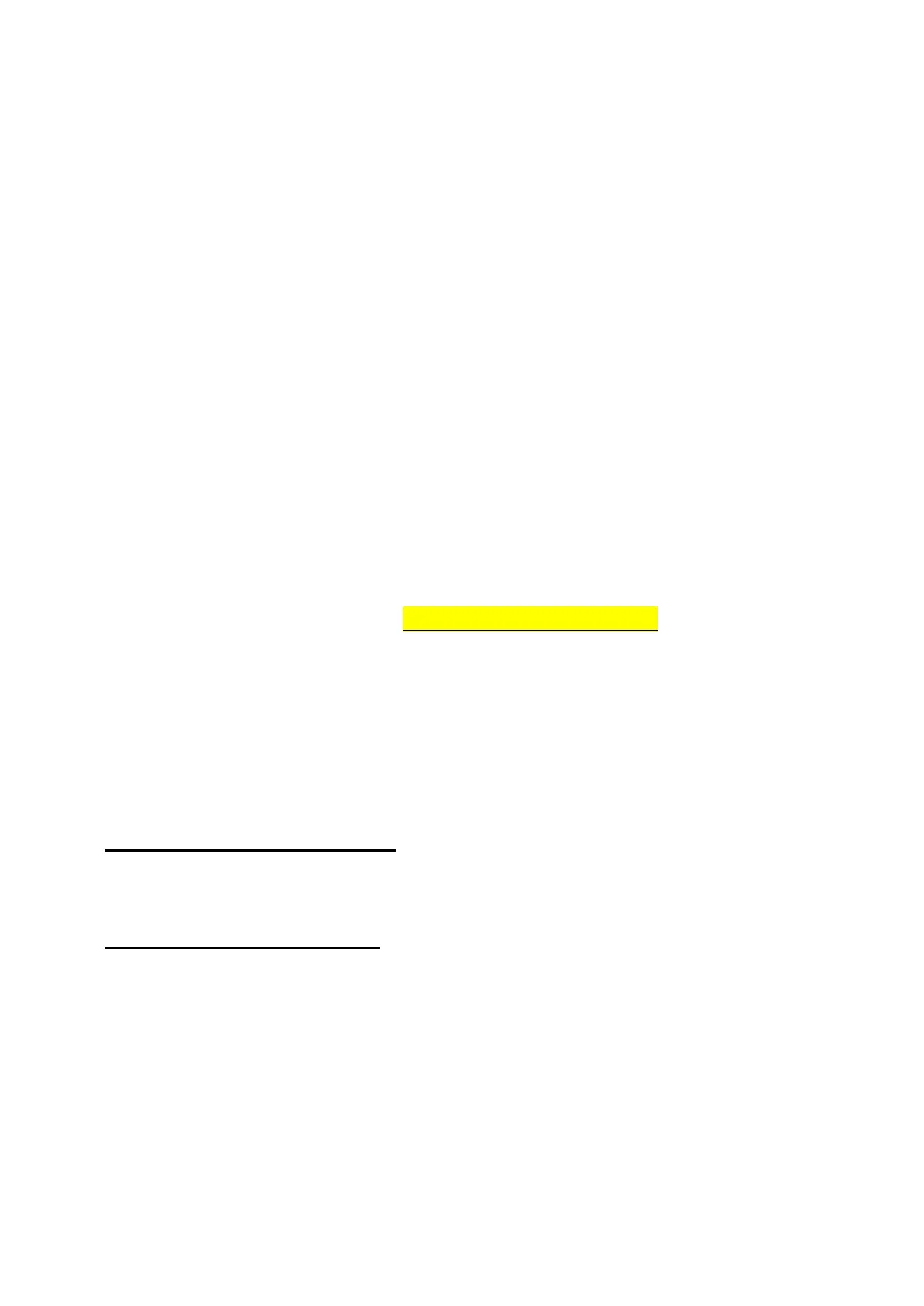
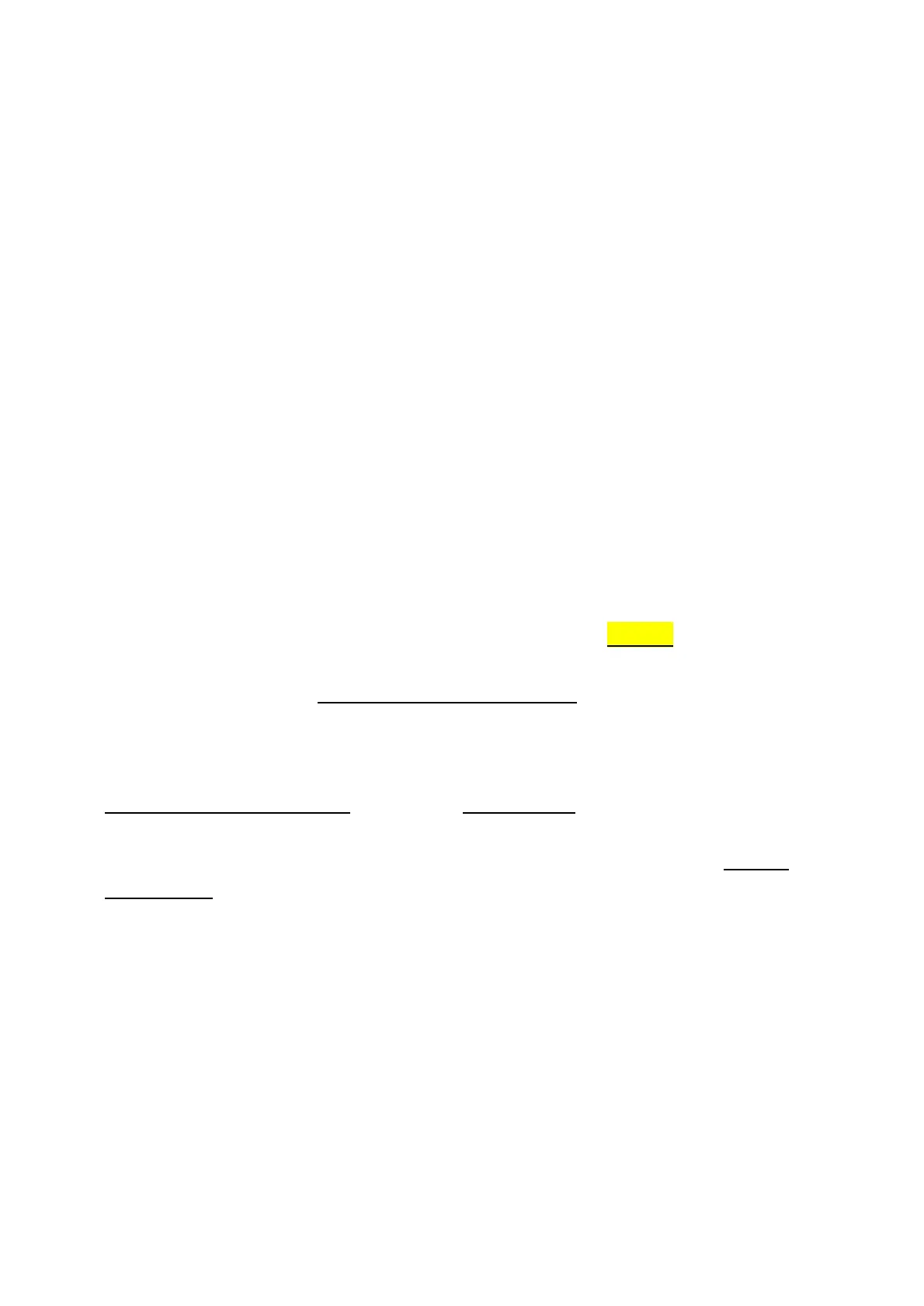
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Il percorso della ricerca
- Il percorso della ricerca
- Scelta del problema e delle ipotesi;
- Disegno della ricerca (progettazione, metodologia ecc);
- Raccolta dati ("documentale" - "sul campo";
- Sistemazione dati;
- Analisi ed interpretazione delle risultanze; -
- Rapporto di ricerca.
Il percorso della ricerca serve per studiare i fenomeni sociali in modo sistematico. Si inizia con l'identificazione di un problema o di un tema da analizzare, formulando ipotesi e domande di ricerca. Questo permette di definire l'obiettivo principale dello studio. Successivamente si consultano studi e teorie già esistenti sul tema per comprendere meglio il contesto, e da queste informazioni, si possono formulare ipotesi o definire specifici obiettivi di studio, che guidano il resto del processo. Una fase cruciale è la progettazione della ricerca, durante la quale si sceglie il metodo più adatto:
Il metodo
2.Il metodo
- Le metodologie (e conseguentemente le tecniche e gli strumenti) si suddividono generalmente in:
- Metodologia QUANTITATIVA (atti a quantificare determinati fenomeni) fornisce la "misura" del fenomeno studiato, va a misurare utilizzando dei dati quantitativi utilizzato a livello macro, non meno di 50 campioni,
- Metodologia QUALITATIVA (atti a rilevare caratteristiche strutturali dei fenomeni), metodi di interviste, va più in profondità non è un'analisi superficiale del fenomeno ma cerca di capire le macro categorie,
Metodologia quantitativa
2.1 Metodologia quantitativa La metodologia quantitativa si concentra sulla raccolta e analisi di dati numerici e misurabili. È un metodo più superficiale. Questo approccio è utilizzato per studiare fenomeni sociali che possono essere descrittiattraverso variabili e indicatori oggettivi, con l'obiettivo di individuare schemi, relazioni o tendenze statistiche, le principali caratteristiche:
- Si basa su dati numerici, raccolti tramite questionari, sondaggi, o analisi di grandi dataset.
- Utilizza campioni rappresentativi della popolazione per generalizzare i risultati.
- Le tecniche analitiche includono strumenti statistici, come correlazioni, regressioni o analisi multivariate.
- È utile per testare ipotesi, misurare fenomeni e fare previsioni.
Esempio: Uno studio quantitativo pu analizzare i fattori che influenzano il livello di istruzione in una popolazione, utilizzando questionari somministrati a un campione di individui e confrontando i dati con modelli statistici.
Metodologia qualitativa
2.2 Metodologia qualitativa La metodologia qualitativa esplora in profondità i significati, le esperienze e le interpretazioni che le persone attribuiscono ai fenomeni sociali. Nella ricerca qualitativa si utilizza come parola chiave la domanda "perché?", di fatti l'obiettivo nella metodologia qualitativa è spiegare, esplorare non descrivere o misurare un fenomeno. COSA LA CARATTERIZZA: il campione di dimensioni contenute;campioni
- I SUOI STRUMENTI: la traccia;
- LE SUE METODOLOGIE: interviste- focus group(metodo di ricerca in cui si mettono insieme da 5 a 12 persone che non si conoscono, in cui mettono a fuoco dei temi, questo gruppo deve avere qualcosa in comune); ricerca etnografica(osservazione che si distingue in partecipante mettersi in un ruolo all'interno del gruppo di interesse e fare delle domande nel quotidiano e non partecipante, osservatore esterno che non interviene sul campo), è una tecnica di ricerca di tipo qualitativo, che prevede l'osservazione delle persone nei loro contesti di vita reale per comprendere come pensano, come sentono, vedono e attribuiscono significati simbolici alla realtà. La funzione della metodologia qualitativa è andare in profondità, comprendere i bisogni o i moventi dei comportamenti condivisi da un gruppo [target].Si basa infatti su dati non numerici, come interviste, osservazioni, analisi di testi, o focus group. (campioni di dimensioni contenute), spesso raccoltitramite questionari, sondaggi, o interviste (non più di 30 e non meno di 15 interviste); Ed esistono: Interviste strutturate: Segue un formato rigido, con domande precise (chiuse), dove, l'intervistatore non pu aggiungere domande durante l'intervista. Si utilizza per ottenere informazioni specifiche, andando in profondità per comprendere i bisogni o i movimenti dei comportamenti condivisi da un gruppo [target]. ES. "Quando è arrivato a Palermo?", "Nel 1986." Interviste semi-strutturate: è più flessibile, include una guida con domande o temi principali, lasciando spazio per approfondire o deviare verso argomenti emergenti durante la conversazione. Contiene domande sia aperte che chiuse, l'intervistatore pu adattare l'ordine delle domande e formulare ulteriori quesiti. ES." Quando è arrivato a Palermo?", "Nel 1986"; "Perché è arrivato qui?" "Per scappare dalla guerra"; "Quale guerra?" ecc ... Privilegia un campione ristretto, selezionato per approfondire casi specifici piuttosto che per generalizzare.
- Nel libro "Le regole del metodo sociologico" (1895), Durkheim definisce il fatto sociale come l'oggetto della sociologia e la metodologia della ricerca empirica in sociologia: << Ogni modo di fare, più o meno fissato, capace di esercitare sull'individuo una costrizione esterna - oppure un modo di fare che è generale nell'estensione di una società data, pur avendo esistenza propria, indipendente dalle sue manifestazioni individuali>>. E.Durkheim
- Esempi di fatti sociali sono il linguaggio e le norme, che non sono innati ma esistono al di fuori dell'individuo e vengono da lui appresi durante i processi di socializzazione. Nell'approccio positivista durkheimiano i fatti sociali hanno una serie di caratteristiche distintive che li rende in tutto simili a fenomeni oggettivi.
- Esteriorità: i fatti sociali credenze pratiche linguaggio istruzioni precedono l'esistenza individuale ed esistono indipendentemente dall'uso che ne fa l'individuo singolo;
- Coercizione: il fatto sociale si impone all'individuo e si riconosce per la presenza di sanzioni. L'individuo pu ignorare la coercizione, ma dovrà comunque lottare contro le sanzioni sociali che ne conseguono;
- Generalità: un fatto sociale deve valere per i membri di una determinata società (concetto di "normalità" in contrapposizione a "patologico").
- I fatti sociali nel loro insieme formano la coscienza collettiva di una società, contrapposta alla coscienza individuale. La prima è formata da rappresentazioni sociali, la seconda da rappresentazioni individuali;
- L'essere umano è duplice, quindi: l'individuo teso tra due poli opposti: da un lato la sua individualità, dall'altro il suo essere sociale. . Come individuo è una realtà psico-fisica mossa da interessi e desideriegoistici illimitati; la socializzazione lo trasforma in persona morale la cui azione orientata in base a fini da perseguire a regole per raggiungerli;
- Attraverso i procedimenti di socializzazione l'individuo interiorizza valori e norme, forma la sua identità sociale e si eleva grazie al contributo di tutti coloro che lo hanno preceduto e di cui apprende le conquiste. L'uomo necessita della società per essere migliore, la cui appartenenza deriva dallo sviluppo di una coscienza sociale, che gli permetta di comprendere di essere parte di un tutto.
- Il valore morale per Durkheim consiste essenzialmente nel tipo di problema che risolve quella particolare credenza.
- Che tipo di problema?
- Per es. Come mai aiutiamo i malati, i disabili, gli anziani spendendo molti soldi? Fornendo ospedali, servizi e cure gratuite la società risolve un problema d'integrazione, mostra una solidarietà, un legame sociale che unisce i cittadini di quel paese.
- Ma, parrebbe che il mutamento di queste regole sia collegato in via generale alle condizioni materiali della loro esperienza.
- Per capire il tipo di moralità espressa da una società, occorre collocarla nello spazio e nel tempo ed esaminarne i suoi problemi pratici.
- I fatti morali dunque risolvono un problema relativo al legame sociale, realizzano il sociale nella sua natura più piena.
- I fatti sociali svolgono delle «funzioni», cioè esistono in corrispondenza di qualche bisogno dell'organismo sociale:«Ci che si deve determinare è se vi è corrispondenza tra il fatto considerato e i bisogni generali dell'organismo sociale e in che cosa consista questa corrispondenza, senza preoccuparsi se essa è o no intenzionale» (Durkheim, 1985).
- Sono differenziate tramite la ripetizione di segmenti (clan) uguali.
- Al loro interno la differenziazione dei ruoli è poco sviluppata (spesso soltanto in base all'età e al genere) e la sua struttura (della differenziazione dei ruoli) si ripete ugualmente in ciascun segmento della società
- I contatti tra ciascun segmento sono limitati alle ritualità religiose e molto raramente riguardano scambi di risorse materiali (cibo, legna, ecc.)
- Nelle società segmentarie, la penetrazione della coscienza collettiva in quella individuale è massima. Ne consegue che il gruppo (clan) e le regole che lo
1. Le analisi si concentrano su temi, narrazioni e prospettive individuali o collettive, spesso utilizzando tecniche interpretative. 2. È utile per esplorare nuovi fenomeni o comprendere contesti e significati complessi. Esempio: Uno studio qualitativo potrebbe analizzare le esperienze di migranti in una città, raccogliendo testimonianze attraverso interviste approfondite per comprendere i loro vissuti e le sfide quotidiane.
Raccolta dei dati
3.Raccolta dei dati Dopo la progettazione, si procede con la raccolta dei dati, in cui si ottengono le informazioni necessarie per analizzare il fenomeno studiato e rispondere alle domande di ricerca. La raccolta dei dati è un ponte che collega teoria e analisi, una fase molto importante per garantire risultati solidi per la comprensione dei fenomeni sociali applicando le tecniche stabilite. Infine, i risultati vengono interpretati alla luce delle teorie esistenti o delle ipotesi formulate in precedenza. Questo porta a trarre conclusioni chepossono confermare o confutare le ipotesi, oppure a proporre nuove spiegazioni. L'ultima fase consiste nella diffusione dei risultati, attraverso pubblicazioni o presentazioni, per contribuire alla conoscenza scientifica e al dibattito pubblico sui temi studiati.
Il fatto sociale
4.Il fatto sociale
Homo duplex
5.Homo duplex
Solidarietà e fatto morale
6.Solidarietà e fatto morale
Moralità ed esperienza
7.Moralità ed esperienza Le morali, i modi cioè di realizzare il legame sociale, cambiano con le società. Le differenze nelle strutture di valore che regolano le diverse società sono innumerevoli.
Funzionalismo
8.Funzionalismo Il funzionalismo è uno dei principali approcci sociologici. Nel funzionalismo la società è concepita come un insieme di parti interconnesse tra di loro. Nessuna di esse, quindi, pu essere intesa isolata dalle altre, ma solamente nel suo contesto.
Solidarietà meccanica vs solidarietà organica
9.Solidarietà meccanica vs solidarietà organica Nelle società primitive gli individui sono riuniti in piccoli gruppi e tutti simili tra loro. L'unità sociale deriva da questa somiglianza. Il tipo di coesione basato su tale somiglianza è definito <solidarietà meccanica>. Nelle moderne società industriali, in seguito all'aumento della densità della popolazione, le funzioni si differenziano, La solidarietà deriva in questo caso dall'interdipendenza funzionale e dalla percezione di questa interdipendenza ed è detta solidarietà organica. La solidarietà non dipende dalla loro somiglianza ma dalla loro reciproca differenza che ad un tempo ne esalta l'individualità e li rende più liberi, e dall'altra li rende reciprocamente dipendenti. Solidarietà meccanica dov'è c'è di una coscienza collettiva viene meno lo scambio commerciale,è un unione basata sulla somiglianza tra le persone, dovuta al fatto che nella società tutti agiscono all'incirca allo stesso modo e nessuno si distingue. Solidarietà organica quando le società diventano complesse si differenziano perchè le persone si specializzano in attività diverse. In queste condizioni non è più possibile la solidarietà meccanica e scatta la solidarietà organica, dovuta al fatto che si ha coscienza di essere interdipendenti, di aver bisogno l'uno dell'altro, e ci si pensa come parti di un unico grande organismo.
Società segmentarie
10.Società segmentarie