Farmaci Anti-Parkinson e Antipsicotici: meccanismi d'azione e strategie
Documento universitario sui farmaci anti-Parkinson e antipsicotici. Il Pdf esplora agonisti dopaminergici come Apomorfina e inibitori delle MAO-B, classificando gli antidepressivi per meccanismo d'azione, con focus su effetti collaterali e strategie terapeutiche per studenti di Farmacologia.
Mostra di più14 pagine
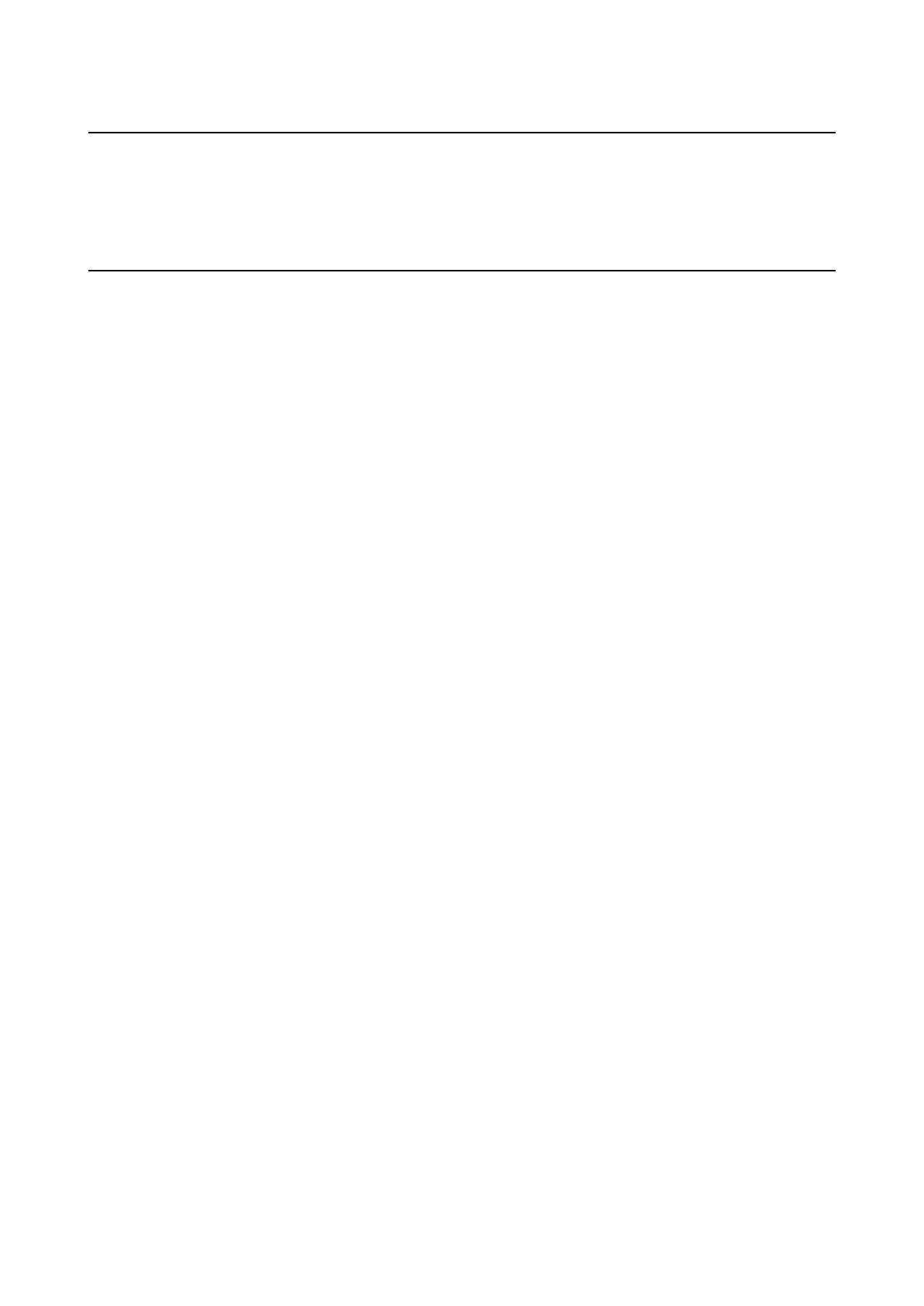

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Agonisti dopaminergici e strategie terapeutiche nel Parkinson
In questa lezione completeremo lo studio del Parkinson. Nella lezione precedente abbiamo visto che, col passare tempo, cominciano a comparire nuovi sintomi nonostante l'assunzione di Levodopa. A questo punto, quindi, possiamo considerare un'opzione terapeutica diversa: l'uso degli agonisti dopaminergici. Questi farmaci rientrano nella linea terapeutica del trattamento del Parkinson, perché hanno un effetto di potenziamento del segnale dopaminergico diretto a livello striatale. Tuttavia, non vengono utilizzati come terapia esclusiva nel lungo periodo, né tantomeno rappresentano la prima opzione terapeutica all'esordio dei sintomi. Gli agonisti dopaminergici diretti, soprattutto quelli più potenti, possono infatti comportare alcune problematiche. Ecco perché solitamente vengono utilizzati come terapia aggiuntiva.
La prima domanda che ci poniamo è se, nel trattamento del Parkinson, esista una preferenza per un sottotipo recettoriale dopaminergico da colpire. Come accennato anche nella lezione precedente, i recettori principali coinvolti sono i D2 e i D1 che regolano rispettivamente la via indiretta e la via diretta. Tuttavia, i farmaci attualmente disponibili non sono selettivi. Esistono agonisti dopaminergici, come il Pramipexolo, che sono preferenziali per i recettori D2 ma non sono selettivi in senso stretto.
Una caratteristica importante degli agonisti dopaminergici è la loro lunga emivita, che può variare tra le 8 e le 24 ore. Questo significa che si possono fare somministrazioni giornaliere, senza la necessità di suddividere le dosi nell'arco della giornata. Ancora meglio, in termini di durata dell'effetto, sono le formulazioni transdermiche - per esempio la Rotigotina, che può essere somministrata per via transcutanea. Si tratta di un esempio tipico di farmaco utilizzato nelle malattie croniche, dove la somministrazione transdermica permette di mantenere un effetto terapeutico costante e prolungato per diversi giorni.
La Rotigotina è ancora meno selettiva rispetto ad altri agonisti: agisce infatti su tutti i sottotipi recettoriali dopaminergici, compresi i D3 e i D4, e mostra anche un'affinità per alcuni recettori serotoninergici in base ai dosaggi terapeutici. In pratica, i suoi effetti terapeutici derivano da un'azione complessiva e poco specifica. Tutti questi agonisti, come già visto, hanno un effetto sul circuito dopaminergico, ma anche a livello corticale (nella corteccia frontale) e limbico. Questo spiega la comparsa di possibili effetti avversi, come allucinazioni, alterazioni comportamentali, disturbi dell'umore e, in alcuni casi, la cosiddetta sindrome da disregolazione dopaminergica. Quest'ultima può manifestarsi con dipendenza da farmaci, gioco d'azzardo patologico, e ipersessualità.
Oltre a questi effetti centrali, si possono avere effetti collaterali periferici come nausea, vomito, e ipotensione. Ma quello che è particolarmente rilevante è che questi agonisti dopaminergici possono causare attacchi di sonno improvvisi. Si tratta di un fenomeno ben documentato, anche se non ancora del tutto compreso: è stato osservato in circa il 50% dei pazienti, a volte con gravità variabile, e può manifestarsi anche in situazioni critiche come durante la guida o l'attività lavorativa. Il meccanismo non è noto: ci sono ipotesi, ma per ora restano tali.
Apomorfina e MAO-B
Un altro agonista dopaminergico che merita di essere menzionato è l'Apomorfina. Come suggerisce il nome, è strutturalmente simile alla morfina, ma il suo meccanismo d'azione è completamente diverso in quanto agisce sui recettori dopaminergici. È considerato più potente rispetto ad altri agonisti. È molto rapido e per nulla specifico: può essere somministrato per via sottocutanea e attraversa velocemente la barriera ematoencefalica. È inoltre agonista di recettori a2-adrenergici. Proprio per queste sue caratteristiche, si è pensato di usare l'Apomorfina in maniera mirata nei cosiddetti "momenti off", cioè quando il paziente ha un blocco motorio improvviso e la Levodopa non è più efficace. In questi casi, si somministra l'apomorfina per via sottocutanea e si ottiene un rapido miglioramento.
Nella pratica clinica, però, l'utilizzo dell'Apomorfina risulta più complesso. Il problema principale è che presenta gli stessi effetti collaterali degli altri agonisti dopaminergici, ma in forma ancora più marcata: nausea e vomito sono così forti che si è pensato addirittura di usarla per indurre il vomito. Immaginate la situazione: il paziente è in fase "off", assume Apomorfina per sbloccarsi, ma subito dopo vomita. Bisognerebbe quindi usarla insieme a degli antiemetici. Non si tratta di una soluzione semplice da gestire. Per questo motivo, l'Apomorfina viene utilizzata raramente e solo in pazienti ben selezionati, anche perché si tratta di un farmaco piuttosto costoso.
A questo punto, si può dire che stiamo mettendo in atto tutte le strategie terapeutiche a nostra disposizione: abbiamo aumentato il rilascio di dopamina (quindi potenziato il segnale dopaminergico), attivato i recettori e bloccato la degradazione della dopamina. Cos'altro possiamo fare dal punto di vista terapeutico? Un'ulteriore strategia consiste nel bloccare la ricaptazione della dopamina, che rappresenta un altro possibile bersaglio farmacologico. In particolare, esistono inibitori che agiscono selettivamente per bloccare le monoamino ossidasi presenti nel sistema dopaminergico (del sottotipo MAO-B). Alcuni farmaci attualmente in uso si basano proprio sull'inibizione delle MAO-B, ma oggi vengono utilizzati solo in associazione con la Levodopa. Tuttavia, questo tipo di approccio ha problemi di tollerabilità: a dosaggi bassi, questi farmaci possono determinare una stimolazione psico-fisica, probabilmente legata a un aumento dell'attività dopaminergica nel sistema limbico. Se si aumentano le dosi, gli effetti collaterali si fanno più importanti: possono comparire insonnia, cefalea, discinesie, tremore, allucinazioni.
Inoltre, se si continua ad aumentare il dosaggio, questi farmaci perdono la loro selettività per MAO-B e iniziano a inibire anche le MAO-A. In questo caso, possono interagire con altri sistemi, come quello adrenergico, dando origine a effetti collaterali ancora più complessi. Un esempio classico è l'interazione con gli alimenti contenenti Tiramina (formaggi stagionati o salumi). In presenza di inibitori delle MAO non selettivi, la tiramina non viene degradata correttamente e stimola il rilascio massivo di catecolamine. Questo può causare una crisi ipertensiva, potenzialmente pericolosa. Vedremo poi altri inibitori delle MAO-B, come la Safinamide. Si tratta di un farmaco sviluppato in Italia molto più selettivo. Proprio grazie a questa selettività, non dà problemi alimentari. La Safinamide agisce anche sui canali del sodio e del calcio, e sembra avere un potenziale effetto neuroprotettivo. Ha anche un'emivita lunga che rende sufficiente una sola somministrazione al giorno. È generalmente ben tollerata, con effetti collaterali molto rari.
Trattamenti non dopaminergici e anticolinergici
A questo punto, abbiamo esaurito tutte le principali strategie per sostenere il sistema dopaminergico. Ma se il paziente continua a peggiorare, cosa possiamo fare? Se la progressione della malattia continua e i sintomi peggiorano, possiamo considerare un'ulteriore opzione farmacologica: intervenire anche su sistemi non dopaminergici. Ne abbiamo già accennato anche la settimana scorsa, parlando dei farmaci antimuscarinici che hanno la capacità di superare la barriera ematoencefalica e agire su un equilibrio alterato tra acetilcolina e dopamina. Questi farmaci possono essere utili come ultima opzione, quando le terapie dopaminergiche non sono più sufficienti a controllare i sintomi.
A destra c'è uno schema che mostra come nella malattia di Parkinson l'attività dopaminergica sia ridotta. Questo comporta un eccesso dell'attività del segnale colinergico, in particolare a livello di alcuni interneuroni dello striato che normalmente inibirebbero la via indiretta. Quando i livelli di dopamina calano, il tono colinergico aumenta. Questo incremento rafforza la via indiretta, che a sua volta inibisce la via diretta e aggrava i sintomi motori del paziente. L'uso di farmaci anticolinergici ha, allora, una sua logica: riducendo il tono colinergico, si cerca di ristabilire un equilibrio funzionale.
Esempi di farmaci impiegati a questo scopo sono la Trihexyfenidile e la Benzotropina, entrambi antimuscarinici. Questi farmaci agiscono bene nel ridurre il tremore, mentre sono meno utili nel trattamento della bradicinesia e della rigidità. Hanno, però, molti effetti collaterali specialmente nei pazienti anziani: confusione, allucinazioni, agitazione, insonnia, secchezza delle fauci, stitichezza e ritenzione urinaria.
Un altro farmaco da considerare è l'Amantadina. Non è propriamente un dopaminergico. Il suo meccanismo d'azione non è del tutto chiaro: si ipotizza che possa favorire il rilascio di dopamina, ma sembra anche agire sui recettori glutamatergici di tipo NMDA con un possibile effetto secondario di tipo anticolinergico. Tuttavia, queste ipotesi non sono ancora state confermate in modo definitivo. Sebbene il meccanismo preciso non sia noto, si ipotizza che agisca anche sulla rigidità muscolare e, in parte, sul tremore. Purtroppo, la sua efficacia tende a ridursi nel tempo. Anche questo farmaco può causare effetti collaterali sia a livello centrale (confusione, agitazione, insonnia) che periferico (disturbi gastrointestinali e secchezza delle mucose).