Fare un Film: fasi della produzione cinematografica
Documento su Fare un Film, che descrive le fasi della produzione cinematografica: pre-produzione, produzione e post-produzione. Il Pdf approfondisce la creazione e la formattazione della sceneggiatura, il processo di spoglio per la pianificazione e i ruoli professionali coinvolti, utile per studenti universitari.
Mostra di più22 pagine
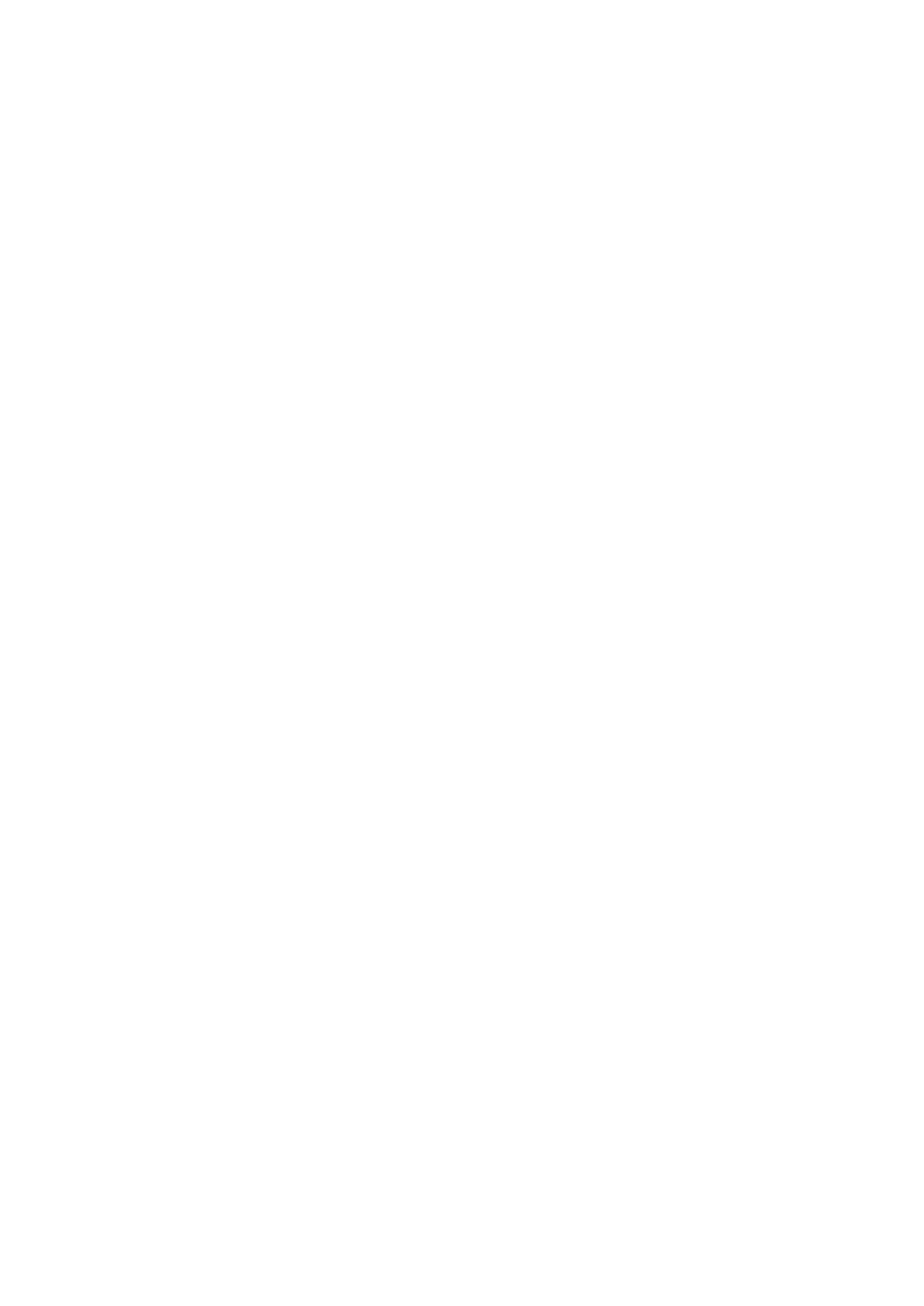

Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
Questo testo illustra il processo di realizzazione di un film, dalla formulazione dell'idea iniziale alla distribuzione del prodotto finito.
La suddivisione della materia è quella canonica e corrisponde alle tre fasi in cui si articola il ciclo industriale di un film: la pre-produzione, la produzione e la post-produzione.
La pre-produzione è la fase che precede le riprese: comprende la progettazione del film (che culmina con la stesura della sceneggiatura), la sua pianificazione (cioè la formazione del pacchetto finanziario e il preventivo di spesa) e la sua preparazione (cioè l'organizzazione dell'attività dei vari reparti).
La produzione invece è la fase delle riprese ed è stata suddivisa in due momenti: la lavorazione (cioè le routines organizzative e amministrative della troupe sul set) e lo shooting, cioè le riprese vere e proprie (quindi l'equipaggiamento tecnico, la regia e la fotografia).
La post-produzione è la fase che segue alla fine delle riprese: comprende il montaggio (cioè l'assemblaggio delle inquadrature girate), l'edizione (cioè la preparazione della copia definitiva), il lancio e la distribuzione (cioè la presentazione del film al pubblico).
Più in particolare, nell'organizzazione di una materia così complessa seguiamo il seguente schema:
- Pre-produzione:
- progettazione (ideazione e sceneggiatura);
- pianificazione (piano finanziario, spoglio della sceneggiatura, preventivo di spesa);
- preparazione (location, casting scenografie, costumi, storyboard, sceneggiatura tecnica, piano di lavorazione).
- Produzione:
- equipaggiamento tecnico;
- lavorazione (amministrazione, organizzazione, routines sul set);
- riprese (regia e fotografia).
- Post-produzione:
- montaggio;
- edizione e distribuzione.
Per ciascuna fase si sono approfonditi due aspetti: le figure professionali coinvolte e i processi lavorativi ricorrenti. Con gli inevitabili margini di semplificazione, perché il ciclo produttivo di un film è un processo lungo e complesso: l'arco temporale medio è di quasi due anni e durante la produzione i vari membri della troupe svolgono contemporaneamente decine di compiti che riguardano più ambiti differenti. Molti capitoli che qui si mettono in successione in realtà descrivono fasi che si svolgono simultaneamente.
La pre-produzione
Per semplificare la pre-produzione viene suddivisa in due parti:
- la fase letteraria, che corrisponde alla fase di progettazione e scrittura della sceneggiatura (dall'idea alla sceneggiatura);
- la fase industriale, che corrisponde invece alla fase di pianificazione e preparazione del prodotto cinetelevisivo.
La progettazione: la scrittura
La prima fase della realizzazione di un audiovisivo è di tipo progettuale letterario: si tratta cioè di definire, in poche parole, la storia che il film racconterà, attraverso la scrittura di tutti gli episodi e di tutti i dialoghi, mediante un lavoro "a tappe" progressive che dalla stesura della trama porta alla realizzazione di un vero e proprio "film sulla carta".
Idea drammatica E' l'esposizione del contenuto del film sotto forma di racconto sintetico (telegramma di 25 parole) E' la storia sotto forma di breve racconto letterario e contiene indicazioni sintetiche su: protagonista, luogo spazio-tempo, inizio, centro e fine della storia Soggetto Scaletta E' lo scheletro del film, un elenco degli eventi organizzato per scene-azioni, numerate progressivamente, che costituiranno l'intreccio E' il racconto in prosa dell'intera storia, scena dopo scena Trattamento SCENEGGIATURA
L'IDEA
Ogni prodotto audiovisivo parte da un'idea, che è il nucleo centrale della storia, in poche parole. Questa idea può sorgere spontanea in qualsiasi individuo, oppure essere pilotata da un produttore, un'agenzia pubblicitaria o altro. A volte le idee possono essere frutto di un brain storming, seduta di dibattito e di confronto delle idee e delle proposte espresse liberamente dai partecipanti.
L'idea è ciò di cui il film parla, quello che viene definito story-concept. Non il tema trattato ma il riassunto della storia. È un racconto sintetico delle azioni fatte da qualcuno (personaggio/i) in un determinato contesto (ambientazione).
Esempio: un fotoreporter costretto all'immobilità per la frattura di una gamba scopre che il suo vicino di casa ha ucciso la moglie. Con l'aiuto della fidanzata, riesce a smascherarlo. ("La finestra sul cortile" di A. Hitchcock, USA, 1954).
L'Idea, o story-concept, è quello che gli addetti ai lavori chiamano telegramma: le "venticinque parole" con cui i produttori pretendono di farsi riassumere dagli sceneggiatori la storia del film. Venticinque parole forse sono poche, sono simboliche, ma il principiuo è valido. L'idea è una sequenza sintetica che contiene tutti gli ingredienti di una storia: un protagonista, una motivazione, una serie di azioni, uno sviluppo e una risoluzione.
IL SOGGETTO
L'idea prenderà forma compiuta in un soggetto, cioè un piccolo racconto in forma letteraria della trama del futuro film, senza nessuna indicazione tecnica. Viene scritto molto in sintesi, da una ad un massimo di venti pagine.
Il soggetto deve raccontare la storia in modo completo, cioè avere un inizio, uno svolgimento e un finale.
Il soggetto potrà essere:
- originale: se è inventato per l'occasione;
- non originale o derivato: se è l'adattamento di un'opera preesistente (romanzo, racconto, dramma teatrale, musical teatrale, film già realizzato in passato, ecc.). In tal caso bisognerà curarsi dell'acquisizione dei diritti, cioè dell'autorizzazione da parte dell'autore o di chi al suo posto possiede la proprietà dell'opera originale , di solito a pagamento, a utilizzare e modificare l'opera a scopo audiovisivo.
Esempio di soggetto: "UMBERTO D.", soggetto di Cesare Zavattini [ ... ] lo voglio raccontarvi la storia di un vecchio e mi auguro alla fine non direte che l'ho inventata. Si chiama Umberto D., ha sessant'anni e una faccia sorridente perché ama la vita, l'ama tanto che protesta con tutte le forze contro il Governo che non vuole aumentare la sua magra pensione. Non meravigliatevi quindi se lo vediamo a un ordinato corteo di vecchi che attraversano la città con dei cartelli sui quali è scritto "Vogliamo soltanto il necessario per vivere". Ma le guardie hanno avuto l'ordine di proibire ai dimostranti di proseguire e i dimostranti cercano allora di forzare il cordone. Ne nasce un parapiglia. Niente di grave, per fortuna. Il nostro Umberto con le sue gambe un po' arrugginite fugge per una traversa, quasi pentito, certamente meravigliato di avere osato tanto, A un angolo della strada incontra altri vecchi che corrono, e con loro si rifugia in un portone, Tenteranno un'altra volta, dicono, La speranza li sorregge. Hanno lavorato trent'anni, quarant'anni fedeli allo Stato, curvando la schiena per il miraggio di una vecchiaia tranquilla. La loro vecchiaia invece è piena di umiliazioni. Umberto abita presso una donna che affitta camere, Le affitta a ore, e voi sapete cosa significa: I frequentatori della casa sono amanti, adulteri, uomini anziani con giovanette o giovani con donne anziane, Umberto ha una buona camera tutta per lui, la prese in affitto anni fa, ma la nuova padrona vorrebbe cacciare via Umberto cui rivolge la parola soltanto per offenderlo, Tanto più che Umberto ha un cane e la signora Antonia odia il cane perché odia il padrone. È un cane bastardo, attaccatissimo a Umberto, Umberto gli vuole bene come a un figlio, Alla sera Umberto si siede vicino alla finestra e il cane si accovaccia sui suoi piedi. La finestra dà sopra tetti, ballatoi, terrazze e una grande cupola. E la cupola di un cinematografo. Quando la cupola si apre, vengono fuori i suoni, le voci della settimana Incom o del film. Dalle camere vicine giungono invece risate, sospiri, pianti, e il vecchio osa persino guardare dal buco della serratura, non perché ami le cose sconce ma per una curiosità più profonda. Vuol vedere in faccia i protagonisti delle vicende d'amore che appaiono e scompaiono in quella casa come meteore.
LA SCALETTA
La scaletta è uno schema che riassume le situazioni essenziali del futuro audiovisivo. Pone le basi della successione delle scene, brevemente descritte anche nella loro ambientazione e disposte nell'ordine di montaggio definitivo. Corrisponde più o meno all'indice di un romanzo. L'ordine della scaletta è quindi già quello definitivo del film.
La scaletta è, per così dire, la mappa dell'audiovisivo, che permette di scorrerlo con una sola occhiata e di individuare le mancanze e le parti superflue, le contraddizioni e gli errori narrativi.
Non ha forma letteraria, ma quella degli appunti, degli elenchi, dal momento che è riservata a chi sta lavorando alla stesura del film ed è quindi spesso indecifrabile per qualsiasi altra persona. È scandita in punti numerati per consentire di trovare facilmente ogni passaggio della narrazione. Ogni punto rappresenta un nucleo, un momento narrativo, e non necessariamente si riferisce a una sola scena o a un solo ambiente.
Esempio di scaletta di "Umberto D." di Vittorio De Sica, 1952 (soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini):
- Corteo di vecchi pensionati in via Nazionale. Presentazione di Umberto e del suo cane.
- La Celere scioglie il corteo perché fatto senza permesso: nei pressi del Viminale.
- Umberto si rifugia durante il fuggi-fuggi in un portone con un altro vecchio: il vecchio, uditi i suoi guai, gli consiglia un posto dove si ottengono piccoli prestiti.
- Umberto va alla casa piccoli prestiti e ottiene seimila lire. Vorrebbe di più cedendo anche l'orologio perché lui ha ventimila lire di debito con la padrona di casa. Ma non ci riesce.
- Umberto rincasando è fermato dal calzolaio davanti al quale cerca di passare di nascosto.
- Entra in casa e trova la sua camera occupata da amanti. Lite tremenda con la padrona. La serva intanto amoreggia coi cavalleggeri della caserma Macao dalla finestra. Nella camera accanto gli amanti fanno sfacciatamente l'amore.
- Umberto offre alla padrona ottomila lire ma la padrona li vuole tutti o niente, preferendo sfrattarlo.
IL TRATTAMENTO
Una volta completata la scaletta, lo sceneggiatore può svilupparla nel trattamento, che è il racconto in prosa dell'intera storia, scena dopo scena. Può essere semplicemente il soggetto ampliato (trenta/quaranta cartelle), sviluppato nell'ordine stabilito in scaletta, oppure una storia sotto forma di romanzo (cento/centocinquanta cartelle). Di solito è scritto al presente: pochi i dialoghi, ma molto dettagliate le descrizioni degli ambienti e della psicologia dei personaggi.