Breve storia dello Stato Sociale: origini, evoluzioni e politiche di welfare
Documento dall'Università degli Studi di Torino su Breve Storia Dello Stato Sociale. Il Pdf esplora le origini e le evoluzioni delle politiche di welfare, la crisi del keynesismo e le sfide attuali per lo Stato Sociale, utile per lo studio universitario di Storia.
Mostra di più23 pagine
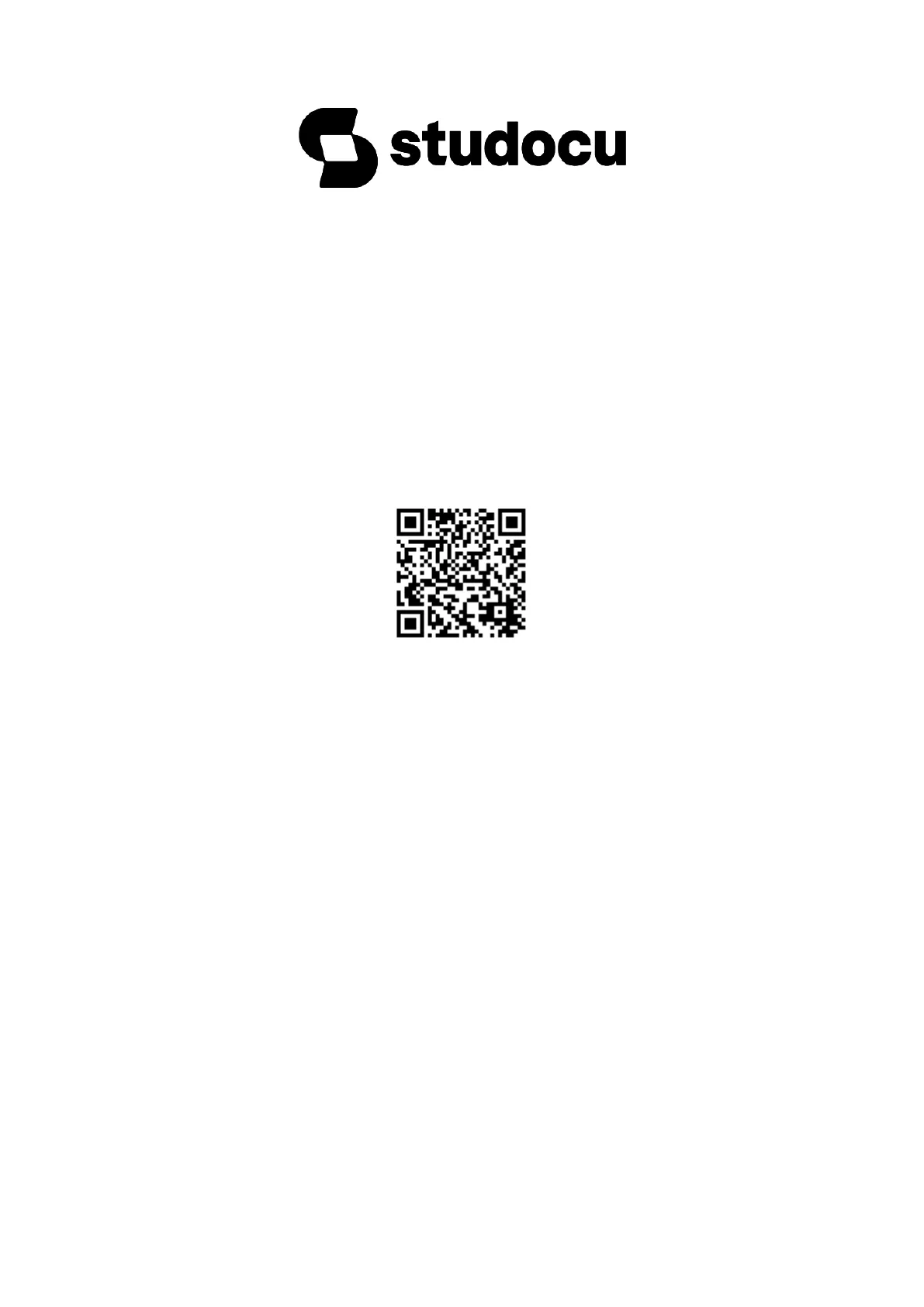
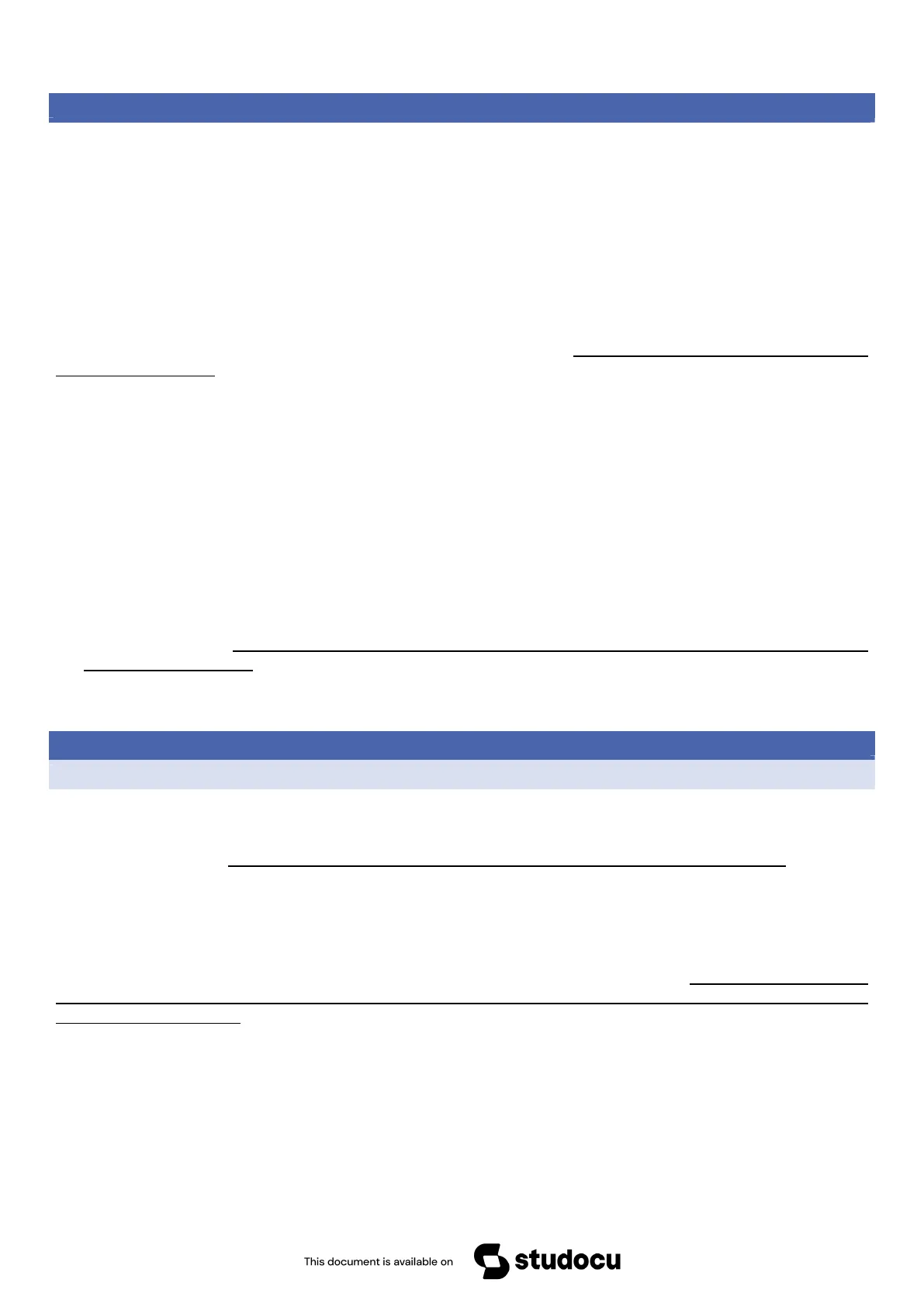
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
INTRODUZIONE
Con l'espressione STATO SOCIALE si intende l'insieme delle iniziative assunte dai vari Paesi nell'ambito dell'assistenza, della previdenza, della sanità, della regolamentazione del lavoro e, più in generale, per la tutela dei ceti più deboli. = > Esso è frutto della rivoluzione industriale e della necessità di offrire qualche risposta ai gravi problemi sollevati dalla nascita dell'economia di mercato. Alla locuzione neutra di "Stato sociale" e ai suoi equivalenti se ne sono affiancate altre considerate come sinonimi, ma che in realtà si colorano di un significato positivo, come quella inglese di WELFARE STATE ("Stato del benessere"), o negativo ("Stato assistenziale"), oppure si prestano a letture ambivalenti, come la francese Etat providence.
Alcune di queste espressioni sono riconducibili solo ad un momento particolare dell'evoluzione delle politiche sociali, e non al loro intero percorso. = > Per esempio, il Welfare State è riferibile alla fase avviata nel Regno Unito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che poi finì con l'influenzare le riforme attuate negli altri Paesi europei.
Altrettanto articolato è il concetto di POLITICHE SOCIALI. La tradizione di studi anglosassone tende, ad esempio, a includervi la previdenza, l'assistenza sociale, la sanità, l'istruzione e le politiche abitative; mentre gli studiosi tedeschi inquadrano in questo ambito solo la previdenza e l'assistenza sociale. Nel contesto italiano vengono ritenute costitutive dello Stato Sociale quelle politiche che riguardano la previdenza (i principali schemi assicurativi obbligatori: vecchiaia, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione, maternità, assegni familiari), l'assistenza sociale (forme di tutela predisposte a favorire quelle categorie di cittadini che, per motivi economici, sociali o sanitari, versano in condizioni di bisogno) e la sanità (cure mediche, ricoveri ospedalieri, fornitura di prodotti farmaceutici).
Lo Stato Sociale mosse i primi passi nel Vecchio Continente, e sempre lì ha conosciuto il maggiore sviluppo, trovando menzione persino in alcune CARTE COSTITUZIONALI, come quella italiana del 1948, nella quale si fa obbligo allo Stato di promuovere il benessere sociale dei cittadini, o come quella europea firmata nell'ottobre 2004 da tutti i Paesi membri dell'Unione.
Fin dal primo profilarsi di un progetto organico di politiche sociali, emerse il contrasto tra il modello inglese, che privilegiava le ragioni della libertà e della responsabilità dell'individuo, e quello tedesco, che vedeva nell'obbligo assicurativo, e quindi nell'interventismo statale, una risposta ai problemi della nascente società industriale. = > Il modello inglese avrebbe poi conosciuto una virata statalistica dopo il 1940, che portò alla nascita del Welfare State, prima di tornare ad un'impostazione privatistica negli anni Ottanta.
Questo andamento non trova riscontro in altre realtà europee, dove lo sviluppo dello Stato sociale ha avuto dinamiche più lineari. - > Magari più complicate (come nel caso italiano, a lungo caratterizzato dalla compresenza di strutture pubbliche e particolaristiche), però sempre contraddistinte da un percorso evolutivo verso più estese forme di copertura e un crescente coinvolgimento dello Stato.
Il tema della riforma dello Stato sociale occupa un ruolo crescente nell'agenda dei parlamenti e dei governi e suscita interesse non solo tra gli studiosi, ma anche nell'opinione pubblica.
CAPITOLO 1: POVERTÀ E FORME DI ASSISTENZA DALL'ETÀ MODERNA A METÀ OTTOCENTO
1.1 LE PRIME INIZIATIVE DI LOTTA AL PAUPERISMO
Il concetto moderno di "Stato Sociale" trae origine da una tradizione di pensiero che affonda le sue radici nell'età antico-medievale e che attribuiva alle comunità e al sovrano il perseguimento della pace, del bene comune e della giustizia.
La povertà, come dettava la morale cristiana, rappresentava una virtù non soltanto perché avvicinava il povero alla lettera del Vangelo, ma anche perché, attraverso le opere di carità, offriva ai ricchi uno strumento per guadagnarsi la salvezza.
Il POVERO era colui che non disponeva dei beni fondamentali per la propria sussistenza o che non era in grado di mantenere il proprio livello di vita. = > Di loro si occupavano le confraternite (religiose e laiche), le corporazioni e le associazioni di mestiere, gli ospedali (gestiti da religiosi o da comunità locali), e i Monti di Pietà, istituzioni nate per garantire ai settori più deboli della società l'accesso al credito su pegno. A ciò si aggiungeva il filantropismo dei ceti nobiliari, che a volte destinavano parte delle loro ricchezze alle elemosine e alle opere pie.
A partire dal 1500, una serie di fattori demografici, economici e sociali determinò in tutta Europa un forte incremento del numero di vagabondi e mendicanti, con effetti destabilizzanti sulle società dell'epoca, che cominciarono a modificare il proprio atteggiamento verso i poveri.
La dottrina della predestinazione, che considerava il successo e l'affermazione materiale un indizio della futura salvezza, ebbe un peso importante in questo processo. = > La figura del povero perse la funzione svolta nei secoli precedenti. Sul piano dottrinario, ciò trovo conferma in numerosi scritti dedicati al problema del pauperismo e della mendicità e in alcuni provvedimenti che puntavano a considerare i poveri un elemento perturbatore dell'ordine e della pace sociale e ad emarginarli. = > Cominciarono ad accentuarsi le distinzioni tra "poveri meritevoli", che andavano aiutati in quanto volenterosi e pronti a fornire il loro lavoro in cambio degli aiuti, e "poveri non meritevoli", giudicati oziosi e dediti al vizio, che erano dannosi per la comunità e andavano perseguiti o reclusi.
Inizio a farsi strada l'idea che l'esercizio o meno di un lavoro fosse un criterio di distinzione fra chi era in grado di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento e chi invece andava considerato povero.
In vari Paesi europei, il fenomeno del PAUPERISMO comincio così ad essere oggetto di misure legislative di contenimento e regolamentazione:
- In Gran Bretagna, dove stava iniziando la pratica delle enclosures e delle espropriazioni dei terreni demaniali da parte dei grandi proprietari, Enrico VIII varò una serie di disposizioni contro vagabondi e mendicanti (1536) e individuò nelle comunità locali i soggetti preposti ad occuparsi del sostegno ai poveri. - > Queste leggi avevano lo scopo di evitare migrazioni interne di masse di poveri e diseredati, non solo per questioni di ordine pubblico, ma anche per fornire una vasta manodopera a buon mercato al nascente capitalismo agrario;
- Enrico II di Francia prese iniziative analoghe, emanando uno speciale editto (1547) che voleva combattere l'ozio dei mendicanti 'validi' e regolamentare gli aiuti ai poveri malati, invalidi e impotenti;
- Misure simili furono varate dai papi Pio IV (1561) e Sisto V (1587).
In generale, queste disposizioni avevano un rigido carattere repressivo e stabilivano pesanti sanzioni per i trasgressori (arresto, punizioni corporali, bando perpetuo dalla città). - > Molte delle misure adottate in questo periodo si basavano sul principio che i poveri in grado di svolgere un'attività dovessero essere destinati al lavoro coatto.
Con Elisabetta I, l'Inghilterra si dotò di leggi volte a controllare e regolamentare in maniera organica il fenomeno del pauperismo. Questo impianto legislativo confluì nella Old Poor Law con la quale, per la prima volta in un atto legislativo, veniva sancito il "diritto a vivere" per tutti i cittadini (1601), e che diventò un punto di riferimento delle successive legislazioni sui poveri di altri Paesi europei. La Old Poor Law stabiliva che:
- Ad occuparsi dei poveri dovevano essere le parrocchie. = > Esse ricevevano risorse derivanti dalle imposte locali (le tasse sui poveri, POOR TAX 1572) che tutti i proprietari e fittavoli, ricchi o meno, erano tenuti a pagare a seconda della rendita della terra o delle case in loro possesso;
- Tutti coloro che si trovano in uno stato di indigenza erano tenuti ad accettare, quale prerequisito necessario per l'accesso ai servizi offerti, l'internamento in apposite strutture residenziali differenziate a seconda del tipo di disagio (POORHOUSES);
- Coloro che non erano in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa finivano negli ospizi di mendicità, mentre chi era in grado di lavorare svolgeva un'attività all'esterno (i fanciulli poveri, ad esempio, come apprendisti) o all'interno di speciali istituti, le WORKHOUSES.
- Per gli oziosi, coloro cioè che non accettavano l'internamento nelle poorhouses, erano previste sanzioni che andavano dalla reclusione in case di correzione fino alla pena capitale per i recidivi.
La legge sui poveri elisabettiana puntava da un lato a garantire manodopera a buon mercato ai proprietari terrieri, dall'altro a dissuadere i poveri dal ricorrere all'aiuto indiscriminato delle parrocchie.
La Poor Law inglese del 1601, così come le leggi di altri paesi europei in quel periodo, può quindi essere definita come una "POLITICA SOCIALE NEGATIVA", poiché il suo intento primario era soprattutto quello del controllo dei poveri e la difesa dell'ordine pubblico.
La POVERTÀ, in pratica, era ritenuta la conseguenza di una colpa ed in quanto tale l'unico metodo ritenuto efficace per risolvere il problema era individuato nella responsabilizzazione degli individui attraverso l'impegno lavorativo.
Queste disposizioni ispirarono anche le legislazioni varate in materia in altre zone d'Europa (Svezia, Danimarca, Norvegia, Belgio e Olanda, Stati tedeschi, Svizzera). = > Tuttavia, diversamente da quanto accadde in Gran Bretagna, la maggior parte delle iniziative prese altrove per fronteggiare il pauperismo poggio essenzialmente sulla carità privata, ovvero su aiuti provenienti da istituzioni religiose o da singoli, e il ricorso alla tassazione rimase raro.
Anche la Old Poor Law, tuttavia, manifesto presto limiti di fondo. = > In molte parrocchie, i proventi della Poor Tax furono talmente esigui da impedire la creazione di strutture differenziate per l'assistenza ai poveri, mentre altrove queste strutture non vennero affatto realizzate. Inoltre, il ricorso alla tassazione fece salire il malcontento dei possidenti, che chiesero controlli più rigorosi e un inasprimento delle disposizioni.
Mentre il fenomeno delle recinzioni riprendeva piede, impoverendo i contadini e favorendo una nuova ondata di migrazioni interne, si decise di stabilire l'obbligo, per chi riceveva aiuti con i proventi della Poor Tax, di non allontanarsi dalla parrocchia di residenza (Act of Settlement and Removal - legge sul domicilio - 1662). = > Tale norma aveva, quindi, lo scopo di scoraggiare i comportamenti opportunistici dei cosiddetti "indigenti di professione", cioè coloro che si spostavano periodicamente alla ricerca dei sistemi parrocchiali di sostegno "piu efficienti".
Dunque, fino all'inizio del Settecento, in Inghilterra la forma prevalente di intervento fu l'outdoor relief, che consisteva nell'erogazione alle famiglie povere di somme di denaro o generi di prima necessita.
Si sviluppò un vivace dibattito sugli effetti della Poor Law, che manifestava l'esigenza di limitare la carità privata, giudicata generatrice di ozio, e di indirizzare la carità pubblica soltanto verso persone effettivamente incapaci di lavorare. = > Questo orientamento venne accolto nella legislazione inglese, e confluì nel Knatchbull's Act (1722), in virtù del quale le parrocchie potevano negare la concessione di aiuti a quei poveri che si rifiutavano di entrare nelle workhouses. - > Il numero di questi istituti crebbe così in modo esponenziale.
1.2 IL PROBLEMA DEI POVERI FRA ILLUMINISMO ED ETÀ DELLE RIVOLUZIONI
Nel corso del 1700, si ebbe in tutta Europa una proliferazione di istituti analoghi alle workhouses inglesi. Rispetto ad esse, però, queste istituzioni non si rivolgevano più unicamente alle categorie dei poveri, ma guardavano all'intero e composito universo della