L'ABC della Teologia: radici, ateismo e cristianesimo
Documento di Università su L'ABC della teologia. Il Pdf esplora le radici della teologia moderna, le critiche alla religione di Feuerbach, Marx, Freud e Nietzsche, e il comandamento dell'amore, utile per lo studio della Religione.
See more32 Pages
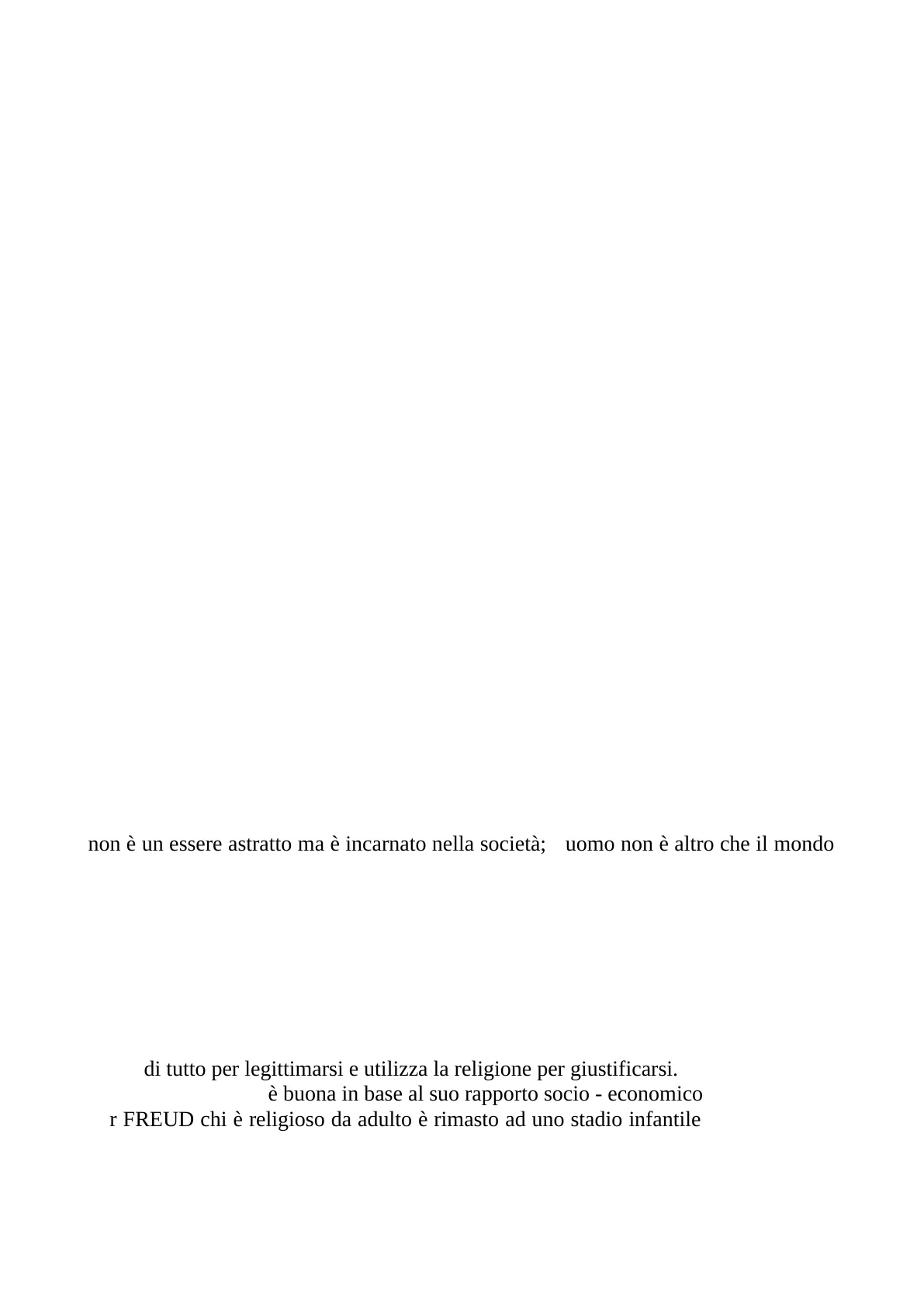

Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Le radici della teologia
La ribellione alla religione in nome dell'uomo nella modernità
L'ABC della teologia Parte prima Le radici Capitolo 1 La ribellione alla religione in nome dell'uomo nella modernità In Italia non è scontato essere credenti e riferirsi a Dio: perché? La ribellione a Dio in nome della libertà dell'uomo e per la sua protezione è stata introdotta da Feuerbach, Marx, Freud e Nietzsche.
FEUERBACH afferma che "il mistero della teologia" è l'antropologia (discorso sull'uomo). Dice che quando si parla di Dio, si parla della coscienza di te senza limiti, dell'infinità del proprio essere. Esistono diverse versioni di Dio in base alle diverse persone/culture. È importante studiare religione perché si studiano gli uomini. Feuerbach capovolge la Genesi 1,27 dicendo che l'uomo crea Dio a sua immagine e somiglianza, solo dopo Dio crea l'uomo a sua immagine.
Insegnamenti di Feuerbach
Cosa ci insegna Feuerbach?
- L'importanza del "religioso": qualcosa/qualcuno al primo posto nella tua vita c'è
- Crearsi un Dio a propria immagine e somiglianza vuol dire poter creare un Dio in base ai propri bisogni e desideri
Marx adotta la posizione di Feuerbach; la religione è immagine dell'uomo ma l'uomo non è un essere astratto ma è incarnato nella società; l'uomo non è altro che il mondo dell'uomo, dello stato, la società. La religione è una sovrastruttura del socio economico. Tutto il resto (politica, scuola, ... ) è comandato dall'economia. La religione può essere buona se va contro la miseria e aiuta i poveri; può essere cattiva se mantiene i buoni, buoni e i cattivi, cattivi. La Religione è quindi per lui come oppio dei popoli e cioè una maniera per anestetizzare.
Insegnamenti di Marx
Cosa ci insegna Marx?
- Società, economia, religione si attirano così che l'aspetto socio - economico fa di tutto per legittimarsi e utilizza la religione per giustificarsi.
- Una religione è buona in base al suo rapporto socio - economico
Per FREUD chi è religioso da adulto è rimasto ad uno stadio infantile. La religione è un corrispettivo della nevrosi. I fenomeni religiosi si possono studiare in relazione con i sintomi nevrotici che studiamo. Il cattolicesimo è il culmine della nevrosi perché è l'unica religione che chiama Dio "Padre" (complesso di Edipo).
Insegnamenti di Freud
Cosa ci insegna Freud?
- La religione affonda le radici nei processi primari di identificazione dell'umano
- La religione può diventare un modo per far esplodere le instabilità delle persone; può essere una scorciatoia dei disturbi della personalità e un infantilismo
NIETZSCHE nella Gaia Scienza racconta l'annuncio della morte di Dio. Togliere Dio dalla vita dell'uomo è come togliere l'orizzonte; è come togliere il Sole alla Terra. Si è liberi di rinunciare a Dio ma poi si finirà per creare dei surrogati e tutto diventa relativa.
Insegnamenti di Nietzsche
Cosa ci insegna Nietzsche?
- "uccidere" Dio è come togliere il Sole
- Bisogna trovare dei surrogati
- La via più coerente: io divento il Dio della mia vita
Il dolore è qualcosa di fisiologico ma anche qualcosa di personale. il problema non è il dolore ma la morte sia che la morte sia o non sia la fine, esse regola il dolore. Alla fine la forza del dolore è la morte e se questa regola il mondo allora è meglio che Dio non esista. La cultura europea non vuole aver a che fare con la morte, vuole la salute ed è disposta a sacrificare tutto per essa. Se ho la salute tutto va bene, se non ce l'ho tutto va male (credenza vista come fede). Diverse culture interpretano in modo diverso la morte.
Il cristianesimo di fronte all'ateismo
Ateismo, altre religioni e storia delle suddivisioni
Capitolo 2 Il cristianesimo di fronte al fenomeno dell'ateismo, alle proposte delle altre religioni e alla storia delle sue suddivisioni Nel documento Gaudium et spes vengono divisi i tipi di ateismo:
- Alcuni atei negano Dio (ateismo teoretico > dimostrano che Dio non esiste)
- Altri ritengono che l'uomo non può dire niente di lui (agnologismo) non si può parlare di lui
- Altri prendono i problemi relativi a Dio come se non avessero senso = vogliono crede a Dio ma lo fanno nel modo sbagliato)
Molti pretendono di affrontare Dio come si affronta un oggetto (in modo matematico) o non ammettono nessuna verità assoluta. Alcuni esaltano talmente tanto l'uomo che la fede Dio quasi snervata poiché affermano più l'uomo di Dio, altri si creano un'immagine di Dio completamente diversa dal Dio del Vangelo ed altri ancora non si pongono nemmeno il problema di Dio
Nel 1970 Martin Heidelberg: "il problema dell'Europa è il non aver nostalgia della nostalgia" e nel finale emerge che l'ateismo non è un fenomeno originario; non è mai esistita al mondo una civiltà senza religione. L'ateismo nasce da delle cause; originariamente si è religiosi. Una di queste cause sono le religioni. È colpa dei credenti che sono gli atei perché essi presentano la dottrina in modo ingannevole e in base alla ragione: critica e supera la teologica "mitologica" ed afferma che il vero modo di parlare della divinità è quello della scienza filosofica: solo il filosofo che possiede la conoscenza vera dell'essere può parlare correttamente di Dio.
Accezione cultuale della teologia
L'Accezione cultuale la ritroviamo nella Stoà con il significato di parlare agli dèi nel culto all'interno dello spazio religioso e civile della città (Es. Plutarco definisce teologi gli addetti al culto di Delfi). Marco Terenzio Varrone distingue tra teologia mitica (conoscenza che si esprime in favole e che viene usata dai poeti), teologia fisica( (utilizzata dai filosofi che sanno distinguere il vero dal falso), teologia civile (la sua conoscenza e amministrazione della città appartiene ai cittadini e ai sacerdoti).
La religione e il cristianesimo nell'era postmoderna
Possibilità di incontro con Dio
Capitolo 3 La possibilità della religione e del cristianesimo nell'attuale stagione postmoderna Di per se tutti i luoghi potrebbero permettere l'incontro con Dio, ma ce ne sono alcuni che lo favoriscono più di altri. Secondo la Bibbia, negli Atti degli Apostoli, possiamo fare buona esperienza di Dio in certe azioni:
- Insegnamento degli apostoli -- > pensare, ragionare, studiare come luogo di incontro con Dio.
- Comunione
- Spezzare il pane Catechesi, liturgia e carità sono le esperienze migliori che permettono l'incontro con Dio.
Non tutte le esperienze religiose indicano questa struttura. Con la liturgia ci sono momenti assembleari di preghiera. La carità consente di fare esperienze a favore degli altri. È cristiano colui che cura la struttura del pensiero e del sapere, vive una dimensione rituale celebrativa e vive una dimensione di "mettersi al servizio del prossimo"!
La catechesi nel cristianesimo
CATECHESI: il cristianesimo non ha ancora capito come incontrare Gesù in un momento di catechesi. Esiste davvero un modo di insegnare che permette di avere una esperienza di incontro con lui? Tra i diversi tipi di catechesi troviamo la spiegazione della dottrina della chiesa: incontrare Gesù vuol dire imparare a memoria la sua vita -- > declinazione intellettualistica dell'incontro con Dio. Si chiama infatti Catechismo il libro usato dalla catechesi. Di per sé ha una sua intelligenza questo modello, perché avere a memoria qualche cosa è buono. Il problema sta nel versante razionale dell'incontro con Dio, sembrerebbe fare filosofia, memorizzazione di Dio.
Cultura postmoderna e religione
Gli uomini vogliono vivere a pieno la terra, non vogliono sottrarsi ai loro doveri,sanno quanto è importante la condizione socio economica, la cultura post moderno ha chiuso i rapporti la tradizione storico-filosofica, c'è un cambio epocale, nella modernità dominavano le narrazioni, nella post-modernità domina l'autobiografia con la quale ci si accontenta di una ragione debole ( ognuno ha la propria verità). I questo periodo pensare al proprio bene è più importante del bene comune. Per quanto riguarda l'aspetto religioso si afferma che non bisogna più pensare alla religione monoteista ma a quella pagana, in quanto la cultura europea sta vivendo un rifermento più marcato ai protagonisti del pagano politeista. Il neopaganesimo è una sorta di religione liberante e alternativo dalle religione classiche , infatti esso non ha dogmi ed è aperto al cambiamento e alle novità. Il postmoderno vede il cristianesimo come particolare insofferenza sia dal punto di vista teorico che sociale: il post paganesimo rimprovera al mondo cristiano: il vivere verso tutti tramite una legge non scritta il quale è l'amore perché è una vita impossibile; l'idea che tutti gli uomini in principio sono peccatori e di conseguenza inferiori a dio; il fatto che si parli di un 'dio gonfiato" che schiavizza le coscienze dando sensi di colpa; il fatto che il figlio di dio avendo sofferto per colpa dell'uomo, l'umanità è in debito nei confronti di dio; la presenza di troppi dogmi che diventano subito leggi; il fatto che chi non rispetta i dogmi paga.
Catechesi, liturgia e carità
CATECHESI: per il cristiano la catechesi è la spiegazione della dottrina della chiesa che porta ad avere fede; l'annuncio della fede che avviene con i racconti di Gesù nella Bibbia; partire dalla stria dei vangeli per arrivare alla propria storia personale; la preparazione al discernimento. LITURGIA:momento centrale della vita di un cristiano, perché è l'azione di Dio per il suo popolo ( definizione concilio vaticano II 1963), vivere la religione significa vivere la liturgia. CARITÀ: indica il modo in cui cristo ci ha insegnato a vivere ovvero avendo carità verso gli altri Questi sono i 3 luoghi nei quali per un cristiano si può incontrare la figura di Dio.
La Bibbia e la teologia
La teologia cristiana come fides quaerens intellectum
Parte seconda La Bibbia e la teologia Capitolo 4 La teologia cristiana come fides quaerens intellectum Nel Nuovo Testamento la parola teologia non è presente, ma si trovano alcuni termini simili (conoscenza, sapienza, pensiero, ecc.). La cosa fondamentale è che il Nuovo Testamento si presenta come la testimonianza della Parola di Dio "fatta carne", Gesù Cristo, che ci trasmette le parole che Dio Gli ha dato. La vera conoscenza di Dio non può non passare attraverso la Parola di Gesù Cristo ed è questa la novità della teologia cristiana rispetto a quella greca.
Introduzione del termine teologia cristiana
La tradizione occidentale esita molto nell'uso del termine teologia come termine specifico per indicare un discorso cristiano su Dio. L'introduzione del termine e del concetto cristiano di teologia è legata a due fattori:
- L'ingresso di Aristotele nella cultura cristiana
- La fondazione e l'organizzazione delle università, dove la teologia viene presentata come scienza principe tra tutte le altre discipline.
Lo scritto della Prima lettera di Pietro è rivolto ai cristiani che vivono in situazione di migrazione in una zona al centro dell'Asia Minore. I destinatari nella maggioranza provenivano dal paganesimo e gli indizi presenti nel testo fanno presupporre una condizione di difficoltà delle comunità cristiane nell'impatto con l'ambiente pagano. Si insiste sulla sofferenza derivante dall'intolleranza dei pagani che non di rado sfociavano in atti discriminatori. L'intera lettera lascia intuire un clima generale di ostilità nei confronti dei cristiani, che si sentono "stranieri" rispetto al contesto. La comunità di Roma, solidale con quelle comunità che sperimentavano le stesse oppressioni provenienti dall'ambiente ostile, li esorta a vivere seguendo una condotta esemplare: i cristiani, infatti, sono invitati a vivere nella situazione e, senza fughe, a valorizzare la stessa sofferenza. Pietro ha fiducia nella reciprocità che regola il vivere civile. Generalmente il bene è riconosciuto e apprezzato. Ritiene perciò che l'opposizione dell'ambiente possa risolversi se i cristiani saranno operatori del bene. Pietro sa per esperienza che il bene può talora essere ricambiato con il rifiuto e l'inimicizia, dunque il credente non si deve deprimere davanti alla prova, perché, se uno è fervente nel bene, nulla potrà fargli veramente del male. L'autore intende rafforzare l'idea che la forza del bene è vincente; i cristiani devono darne prova. I credenti sono esortati a non lasciarsi paralizzare dal timore che incutono gli avversari, ma a sostenere il confronto con positività e discrezione; sono invitati a santificare nei loro cuori e nella loro vita Cristo riconoscendolo Signore. Per Pietro lo scopo di tale "apologia" (=difesa) è quello di sconfessare le accuse con i fatti. Chi parla male dei cristiani deve potersi ricredere osservando il loro comportamento. A questo punto si pone la questione del preciso senso di apologhia; con questo termine, più che l'adesione ad una dottrina, s'intende esplicitare la relazione vitale con Cristo che ha portato a una nuova impostazione di vita, in forza della rigenerazione ottenuta mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Sant'Agostino ha coniato alcune formule sintetiche per descrivere il rapporto tra la ragione e la fede, per esprimere l'esercizio credente della ragione:
- «credo ut intelligam et intelligo ut credam» > credo ut intelligam sottolinea che il punto di partenza della teologia è la fede; dunque, occorre prima credere e vivere la vita di fede per poter penetrare poi in una conoscenza anche intellettuale del Dio vivente. Intelligo ut credam è complementare alla prima; l'intelligenza dev'essere esercitata per portare ad una fede sempre più profonda e consapevole di sé;
- «quaeramus inveniendum, quaeramus inventum. Ut inveniendus quaeratur, occultus est; ut inventus quaeratur, immensus est» > il dinamismo proprio