Didattica Speciale e Inclusione Scolastica: evoluzione normativa e formazione
Documento sull'educazione inclusiva e l'evoluzione normativa italiana e internazionale. Il Pdf analizza i concetti chiave e le leggi che hanno plasmato l'approccio all'inclusione scolastica, con un focus sulla formazione degli insegnanti per la didattica inclusiva, utile per studenti universitari di Psicologia.
See more64 Pages
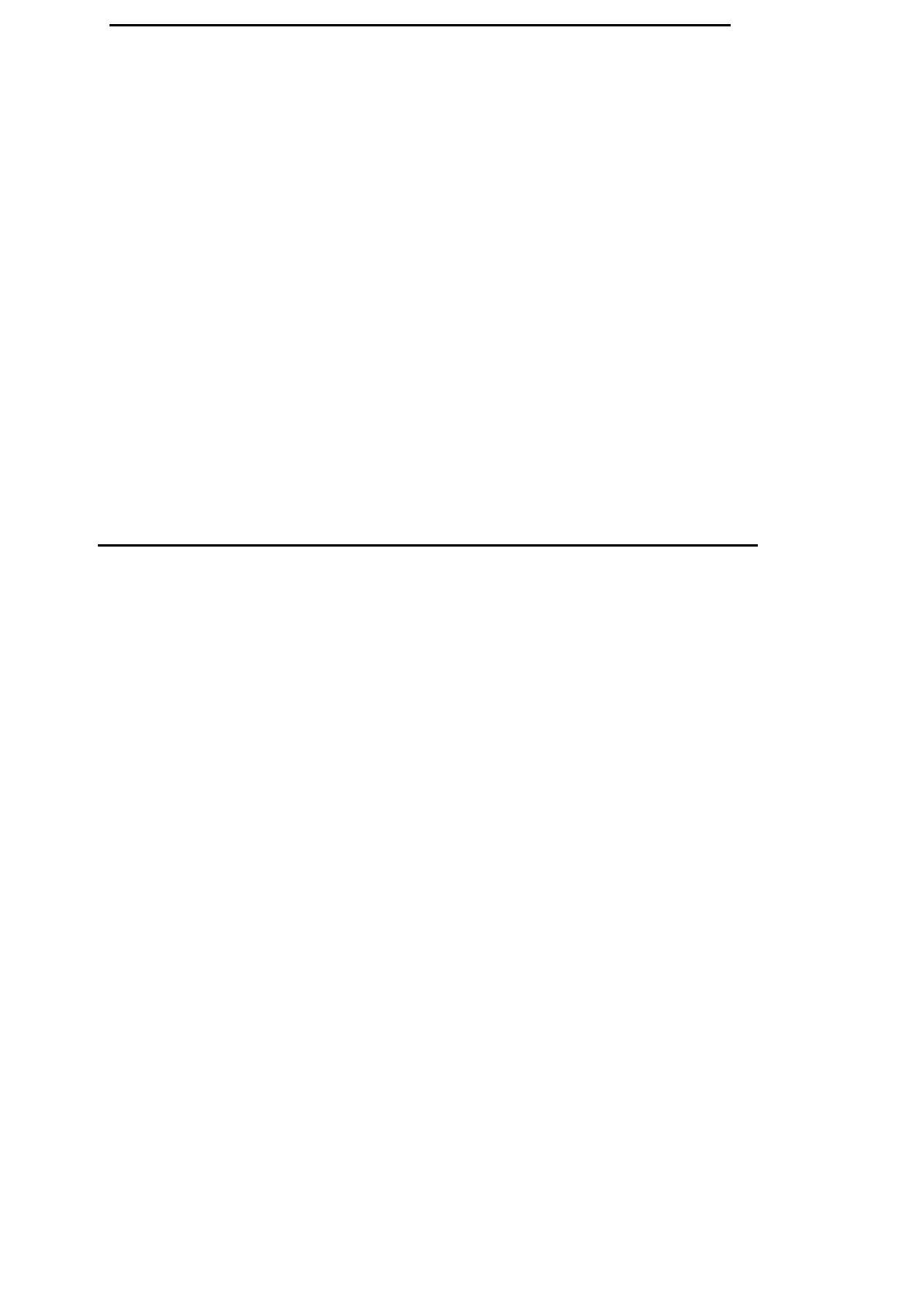
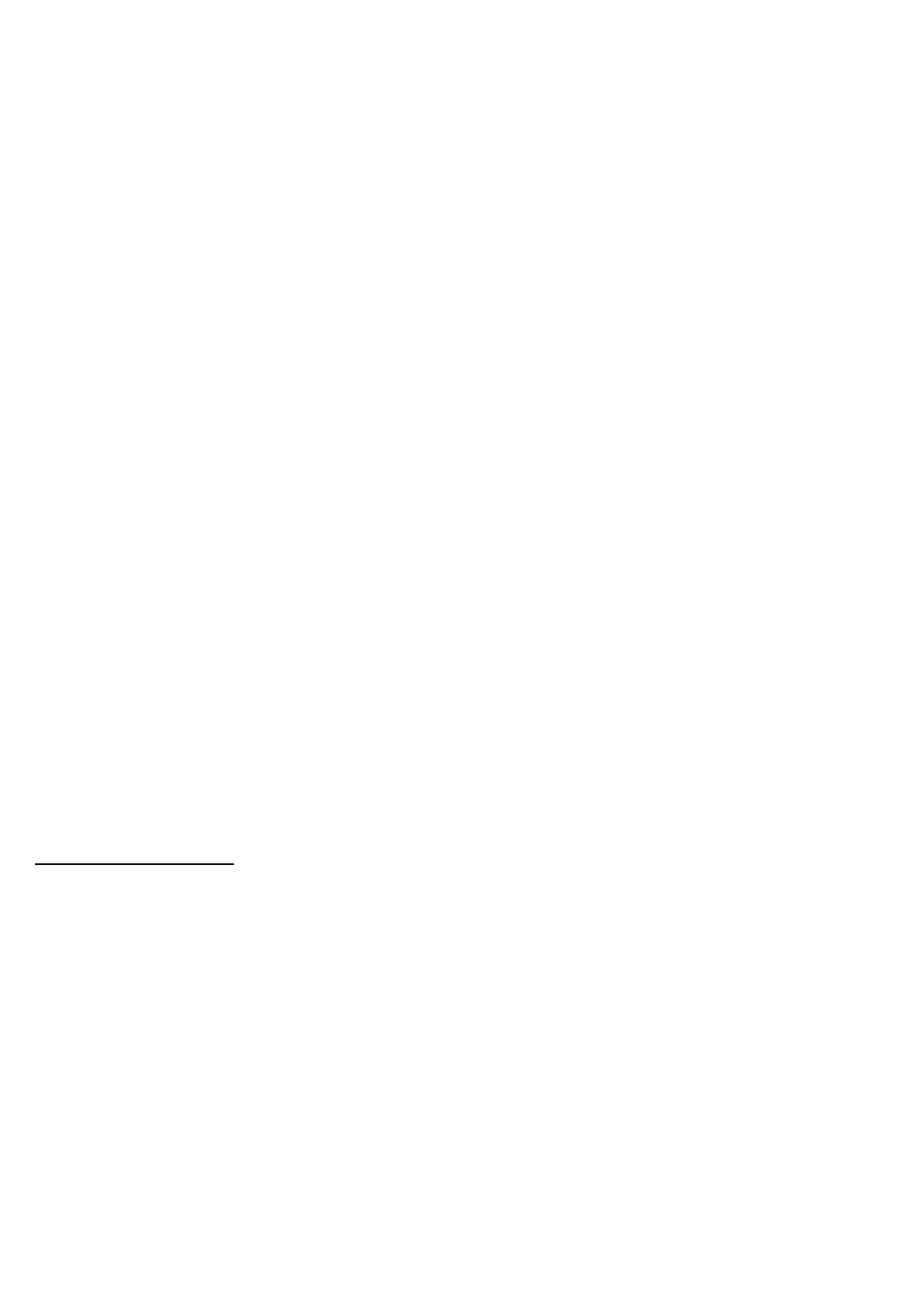
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Introduzione all'Inclusione Scolastica
Inclusive education: modello teorico nato negli anni '90 con lo scopo di rispondere alle diversità dei bisogni dei singoli studenti, promuovere un sistema educativo capace di intercettare le differenze e specificità di ognuno. Modello promosso e supportato dall'UNESCO (Conferenza di Salamanca, 1994, Carta di Lussemburgo, 1996, Convenzione sui diritti delle persone disabili, 2006). Non si tratta di indirizzarsi ad un allievo medio per poi aggiungere percorsi personalizzati, ma concepire una progettualità fin dall'inizio rivolta a tutti, tenendo conto delle differenze e orientandosi a promuovere per ciascuno le migliori opportunità di crescita personale -> rendere inclusivi i contesti, i metodi, gli atteggiamenti.
Cottini individua 4 piani, integrati tra loro, che descrivono e orientano la riflessione sulla dimensione inclusiva (4 parti del libro):
- Piano dell'affermazione dei principi di riferimento
- Piano dell'organizzazione del contesto e delle procedure ai fini inclusivi
- Piano metodologico-didattico
- Piano dell'evidenza empirica (verifica della significatività operativa delle metodologie).
Capitolo 1 - Evoluzione del Quadro Normativo
Excursus storico della normativa scolastica dalla separazione all'integrazione
- Anni '60: l'approccio alla disabilità era prevalentemente medico, e si riteneva che l'alunno con disabilità potesse essere aiutato in maniera più incisiva se inserito in gruppi di bambini con deficit simili. Classi differenziali nella scuola media unica (legge n. 1859 del 1962) e sezioni speciali o scuole materne speciali per i casi più gravi per i bambini dai 3 ai 6 anni (legge n. 444 del 1968) -> istruzione separata
- Anni '70: crisi delle istituzioni separate. Legge n. 118 del 1971 riconosce agli allievi in situazione di disabilità il diritto all'istruzione in classe comune, escludendo però i soggetti più gravi; intorno al 1975 gli specialisti hanno iniziato a rifiutarsi di attestare la gravità della disabilità.
1974: viene costituita la Commissione Falcucci (era una senatrice) per studiare l'inserimento dei bambini con disabilita nella scuola comune; nel 1975 la commissione elabora un documento in cui viene ribadito che il superamento dell'emarginazione passa da un nuovo modo di concepire e attuare la scuola e che l'inserimento nelle scuole comuni di bambini con disabilità non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. 1977: con la legge 517/1977 vengono abolite le classi differenziali e le scuole speciali -> questo favorisce il passaggio da inserimento a integrazione. La legge prevedeva la programmazione di attività per gruppi e interventi individualizzati e la presenza di insegnanti specializzati.
Negli anni successivi sono state emanate altre leggi e circolari ministeriali per l'interpretazione della legge 517/1977 (vedi pag. 32)
- Anni '80: legge n.215 del 1987 garantisce la frequenza della scuola media superiore a tutti i disabili. . 1992: legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone con disabilità. Ha lo scopo di raccogliere organicamente le disposizioni precedenti e riempire vuoti legislativi.
1 Negli articoli 12-17 si parla di integrazione scolastica, ponendo in primo piano non solo i bisogni particolari della persona con disabilità ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le sue potenzialità nell'ambito dell'apprendimento, della comunicazione e delle relazioni.
Grande rilevanza del confronto di tutte le istituzioni e in particolare coinvolgimento sempre più attivo della famiglia nella formulazione del Profilo dinamico-funzionale (PDF) e del Piano educativo individualizzato (PEI). Il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) del 24/02/1994 stabilisce che le unità sanitarie locali hanno il compito dell'individuazione della disabilità, che deve essere corredata dalla diagnosi funzionale (DF), che insieme al PDF costituisce la documentazione fondamentale richiesta dall'amministrazione scolastica. La DF viene definita "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di disabilità; non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit di cui è portatore l'alunno, ma ne pone in evidenza le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale". Il PDF fissa le linee di sviluppo potenziale del bambino a medio e breve termine e consente di individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica che trova la sua definizione nel PEI. Nel 2017 il decreto legislativo n. 66 prevede che dopo l'accertamento della condizione di disabilità venga redatto un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale, che ricomprende DF e PDF e è predisposto dall'unità di valutazione multidisciplinare con la collaborazione della famiglia e di un rappresentante dell'amministrazione scolastica.
- Legge 59/1997: le scuole acquisiscono autonomia in termini giuridici, finanziari, amministrativi, didattici, di ricerca, di sperimentazione e organizzativi. Abolizione dei programmi nazionali e maggiore responsabilità progettuale alle scuole, attraverso il POF (piano dell'offerta formativa), che comprende il curricolo didattico e questioni di organizzazione interne, gestione delle risorse relazioni con il territorio; la legge 107/2015 istituisce il PTOF. Attraverso il POF si dovrebbe esprimere la sensibilità della comunità verso l'accoglienza degli studenti con difficoltà.
Le scuole autonome: promuovono percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e ala crescita educativa di tutti gli alunni; riconoscono e valorizzano la diversità; promuovono le potenzialità di ciascuno; adottano tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo; regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento di singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni; adottano forme di flessibilità dell'organizzazione educativa e didattica; assicurano iniziative di recupero e sostegno, continuità, orientamento.
La sintesi di questo percorso di progressiva attenzione ai bisogni degli allievi può essere rintracciata nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal ministero nel 2009, che non apportano modifiche normative ma delineano impegno per migliorare la qualità dei processi di integrazione scolastica nella prospettiva dell'inclusione, anche alla luce dell'emanazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia (enfasi sulla gestione coordinata dell'integrazione, ruolo di tutti gli attori, coinvolgimento di tutti i docenti, valutazione d rapportare al PEI e considerare come analisi dei processi e non della performance).
La curvatura normativa verso la prospettiva dell'inclusione
Il passaggio da integrazione a inclusione non rappresenta uno stacco, ma una curvatura che amplia l'orizzonte alla considerazione della diversità come caratteristica di tutti e di ognuno e alla riflessione e individuazione di barriere e ostacoli sociali in grado di rendere difficile la partecipazione di ogni persona alla vita comunitaria.
Le disposizioni internazionali
- Anni '70: emanazione in Inghilterra del rapporto Warnock -> viene introdotto il concetto di Special Educational Needs (BES). , il quale ha contribuito a orientare la 2 discussione verso un approccio inclusivo alle diversità, centrato sull'individuazione di obiettivi comuni a tutti gli allievi; questo orientamento è ancora solo accennato.
- 1994 - Dichiarazione di Salamanca -> chiaro impegno nei confronti del principio dell'educazione per tutti e per ciascuno, riconoscendo la necessità di bambini, giovani e adulti con BES di frequentare percorsi di formazione e istruzione all'interno de comuni sistemi educativi -> l'educazione delle persone con disabilità è parte integrante del compito della scuola regolare. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede che le scuole predispongano percorsi educativi in grado di considerare anche i bisogni educativi di tutti gli allievi. Viene rovesciata la prospettiva sociale usuale dell'integrazione scolastica: sono i programmi scolastici che devono adattarsi ai bisogni dei bambini e non viceversa.
- 1996 - Carta di Lussemburgo -> articolata in tre parti. Principi fondamentali: ogni Stato membro deve adottare una legislazione che garantisca a tutti l'accesso a un sistema scolastico ordinario; viene data importanza al ruolo rivestito dai genitori, alla centralità dell'intervento avviato precocemente e fondato su una valutazione precisa e costante dei bisogni dell'individuo e dell'ambiente familiare. Strategie: riferite agli aspetti e alle attività concrete da mettere in atto quando si vogliono applicare i principi generali. Enfasi sulla qualità dell'insegnamento che deve mirare a un rapporto educativo globale e alla costruzione della rete tra famiglia, insegnanti e specialisti a supporto dei processi inclusivi. Proposte: riguardano le prospettive e i cambiamenti da attuare in futuro.
- 2006 - Convenzione sui diritti delle persone disabili elaborata dalle Nazioni Unite -> viene riconosciuto il diritto alla piena inclusione in ogni contesto delle persone con disabilità. La disabilità viene definita come il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali in grado di impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri -> riferimento al modello sociale della disabilità e all'ICF, che vede la disabilità come frutto di un complessa interazione di condizioni create dal contesto. La sfida dell'inclusione delle persone con disabilità non riguarda solo una piccola minoranza ma l'intero genere umano.
- Italia, 2009: Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico
- 2009, UNESCO - Linee guida sull'educazione inclusiva -> l'inclusione è vista come un processo in grado di rispondere alla diversità delle esigenze di tutti gli allievi, attraverso l'incremento delle possibilità di partecipazione all'apprendimento, alle culture e alle iniziative comunitarie.
- In ambito europeo sono presenti numerose iniziative volte alla promozione dell'inclusione scolastica, tra queste grande importanza rivestono i Principi guida per promuovere la qualità nella scuola inclusiva del 2009, ovvero
- Ampliare l'accesso all'istruzione e favorire la piena partecipazione e le opportunità educative a tutti gli studenti
- Potenziare la formazione di tutti i docenti
- Mettere in campo azioni in grado di promuovere una cultura condivisa e l'accoglienza delle diversità degli alunni e delle loro esigenze
- Organizzare adeguatamente la "struttura di sostegno"
- Prevedere sistemi di finanziamento certi, flessibili e preferibilmente decentrati
- Sviluppare politiche orientate in prospettiva inclusiva
- Avere una legislazione che ponga sempre l'inclusione come meta da raggiungere
- 2014 - Cinque messaggi chiave per l'educazione inclusiva -> dal punto di ista operativo suggeriscono di agire:
- Il prima possibile, in quanto tutti i bambini hanno diritto a ricevere il sostegno necessario, precocemente e ogniqualvolta serva 3
- Considerando l'educazione inclusiva come un bene per tutti, che mira ad offrire istruzione di qualità a tutti gli alunni
- Facendo riferimento a professionisti altamente qualificati
- Per avere sitemi di sostegno e meccanismi di finanziamento che siano adeguati alla misurazione dell'efficienza e di quanto conseguito.
Normativa italiana
Con la legge 170/2010 sui DSA, la direttiva ministeriale del 2012 e la C.M. n. 8 del 203 sui BES, il MIUR è intervenuto sulla questione, con l'obiettivo di dare visibilità a una popolazione scolastica in difficoltà di apprendimento.
Gli studenti con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, di una didattica individualizzata e personalizzata, che tenga conto elle peculiarità degli allievi e di adeguate forme di verifica e valutazione.
Strumenti compensativi: dispositivi didattici e tecnologici in grado di sostituire o facilitare la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.
Strumenti dispensativi: interventi che consentono all'allievo di non svolgere alcune prestazioni che, sempre a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitate e formalizzate all'interno del Piano didattico personalizzato (PDP) per la continuità didattica e la condivisione con le famiglie. Il fatto che con la certificazione DSA non sia prevista la presenza di un insegnante di sostegno sottolinea l'esigenza che tutti gli insegnanti sappiano intervenire in maniera adeguata.
Nell'area dei BES vengono comprese due ampie condizioni di difficoltà scolastiche: i disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, di coordinazione motoria, disprassie, disfunzioni non verbali, ADHD, funzionamento intellettivo