L'estetica antica: evoluzione del pensiero estetico da Grecia a Rinascimento
Documento sull'estetica antica, che traccia l'evoluzione del pensiero estetico dall'antica Grecia al Rinascimento. Il Pdf esamina concetti chiave come armonia, mimesis e il ruolo dell'artista, analizzando le teorie di filosofi come Baumgarten, Eraclito, Empedocle e Protagora, fino a Dante e al Quattrocento, per il corso universitario di Filosofia.
See more10 Pages

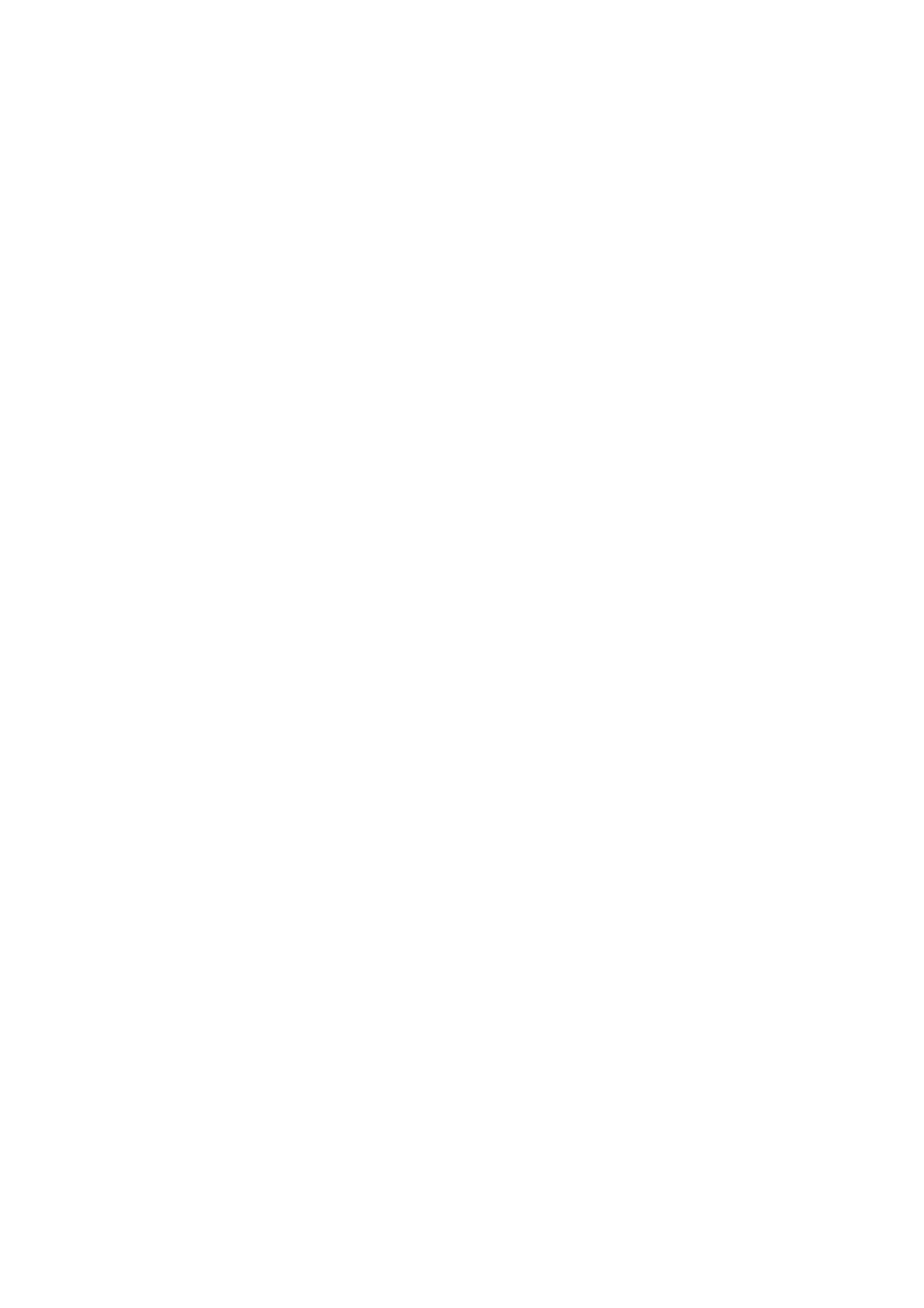
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
Premessa
L'estetica è una disciplina tipicamente moderna. Settecento il secolo in cui, nella cultura occidentale, nasce e si sviluppa l'estetica quale ambito autonomo della ricerca filosofica. La prima opera intitolata "Aesthetica" risale al 1750 e si deve al filosofo tedesco Alexander Gottlieb Baumgarten. Termine greco "aisthesis" che significa "percezione", si comprende che tale disciplina i problemi relativi al bello e all'arte sono oggetto di riflessione e di discussione. Il problema estetico coinvolga questioni più generali riguardanti il senso della vita umana nel cosmo, l'esperienza della natura, il rapporto con il divino, la conoscenza della verità, le forme della politica. Mira a delineare, sullo sfondo di epocali differenze storiche relative alla cultura e alle forme di vita, sia la continuità dei problemi sia il pluralismo degli approcci teorici e delle soluzioni.
Premessa alla nuova edizione
Risponde a esigenze e sollecitazioni palesate dai lettori.
- L'estetica antica
Armonia e techne nel pensiero mitico dell'antica Grecia
Il bello come armonia
Nell'ambito del pensiero antico l'equivalente semantico di "bello" - "to kalon" - ha un significato ben più ampio, con preminenti valenze di carattere cosmologico, gnoseologico, religioso ed etico-sociale. Per i greci il bello è principalmente "harmonia", ossia "ciò che è ben congiunto" (dal verbo "harmottein", congiungere, comporre). Il bello manifesta anzitutto l'ordine dell'universo, quella struttura ed equilibrio che fanno del mondo un "kosmos" cioè un tutto ordinato e quindi armonico "dal verbo "kosmein", "ordinare"). Nella sua capacità di manifestare l'ordine armonico della natura, il bello è anche identificato con la luce e lo splendore in grado di farci conoscere la trama intelligibile del mondo. Conoscere significa per i Greci sollevarsi dal visibile all'invisibile, così da cogliere a livello intellettuale quei principi che sottendono l'ordine cosmico e, quindi, la sua bellezza. Da ciò deriva lo stretto legame che sussiste tra bellezza e verità, il bello è al tempo stesso indisgiungibile dal bene. Il bello è strettamente connesso alla giustizia: secondo i Greci, infatti, il giusto ordine della città (della pòlis) non è altro che una tradizione in termini sociali dell'ordine armonico del cosmo; pertanto, il bello, nella sua capacità di manifestare l'ordine perfetto della natura, è vissuto dal Greci come un accadimento divino pertanto, secondo il pensiero mitico, il bello, prima di essere una proprietà dell'arte, è essenzialmente una caratteristica della natura. La bellezza permette di raccogliere l'intero universo nell'unità di una forma, ma conferisce a ogni cosa la sua propria forma. In quanto dono divino che fa risplendere le cose nella loro specificità, il bello è propriamente "charis", "grazia" riconciliatrice che suscita piacere e incanto.
Techne e mousike
In riferimento ai prodotti dell'arte, il termine gerco "kalos" è sinonimo di "chresimos" cioè "utile", oppure di "euprepes", cioè "adatto, conforme a uno scopo", che può essere di carattere economico, domestico, conoscitivo o religioso. Se per i Greci l'arte è essenzialmente "techne", tecnica appunto, il termine greco "techne" indica ogni attività umana che, connessa all'uso delle mani e alla trasformazione fisica di materiali, abbia carattere poietico e risulti fondata, da un lato, sulla conoscenza delle regole e dei procedimenti atti a produrre determinati manufatti e, dall'altro, sulla capacità migliorabile con l'esercizio di mettere efficacemente in pratica tali regole e procedimenti. Musica e danza, insieme alla storia e all'astronomia, rientrano nell'ambito della "mousike". Esse sono arti musive, cioè ispirate dalle Muse L'estetica antica Le arti musiche sono quindi un dono divino e, come tali, sono mosse da "enthousiasmos" (entusiasmo) termine che significa "essere in dio". Le arti musive sono animate da una sapienza superiore, il mousikos, oltre a rendere testimonianza di ciò che è stato e ha senso ricordare, è capace di vedere ciò che, avendoprincipio nel presente, dovrà realizzarsi nel futuro. Alla "mousike" viene riconosciuta non solo una funzione religiosa ma anche politico-sociale. La "mousike" ha anche un valore purificatore o catartico.
Arte come mimesis
I Greci sostengono che l'arte è propriamente "mimesis", imitazione. Il "mousikos", come abbiamo visto, è colui che riflette non solo attraverso la sua parola, ma anche nei gesti e nei suoni che accompagnano il canto. Il concetto di imitazione è alla base non solo delle arti musive ma anche di quelle tecniche. La "mimesis" significa innanzitutto agire conformemente a un canone, cioè a un sistema di regole. Sotto questo punto di vista la "mimesis" intesa come adesione a un canone, assume un significato più profondo, cioè quello di imitazione della natura, da intendersi non come semplice copia, bensì come rispecchiamento dell'ordine divino insito nel cosmo. Se i Greci considerano bello un utensile nella misura in cui esso si manifesta perfettamente conforme alla sua funzione è perché esso, nella sua capacità di portare a coronamento la propria virtù, manifesta il suo perfetto accordo con l'ordine della natura in cui si inserisce la sua azione.
Kosmos e mimesis nei presocratici
Musica e ordine matematico dell'universo
Se la musica, in quanto scienza dell'armonia, ci fa conoscere l'ordine matematico dell'universo, essa, in quanto arte dei suoni che conferisce forma sensibile a tale ordine, ha il potere di agire sull'animo umano e di ripristinare in esso equilibrio e misura nei riguardi degli istinti, dei desideri e di tutte le pulsioni corporee. La musica è una scienza e un'arte di origine superiore, al punto da qualificarsi come un sapere e una tecnica di carattere divino.
Eraclito ed Empedocle: armonia come accordo di opposti
Il concetto di bello come armonia ritorna in Eraclito: ogni cosa trae esistenza e significato dal proprio contrario. La tensione dei contrari è così al servizio di una superiore e invisibile armonia che coincide con il "logos" del mondo, il principio razionale che governa tutte le cose come legge universale e divina. Secondo Empedocle il principio dell'armonia cosmica è "Eros", "Amore". Per Empedocle tutta la realtà è riducibile a quattro elementi o "radici" che, con l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, determinano attraverso le loro combinazioni la generazione di tutte le cose. Per Empedocle il pittore è in grado di restituirci tutta la variopinta realtà attraverso la mescolanza, secondo una terminata misura e quantità, dei quattro colori fondamentali: il bianco, il nero, il rosso e il giallo. Per i pitagorici il musico non fa altro che rispecchiare i ritmi matematici inscritti nell'armonia del cosmo, così per Empedocle il pittore imita le proporzioni quantitative che regolano l'equilibrio e la stabilità delle cose.
Edonismo e convenzionalismo estetico nei sofisti
Protagora: relatività del bello e artificio
La concezione del bello viene messa in crisi dai sofisti. Nella loro riflessione la bellezza smarrisce la sua valenza di legge cosmica valida per tutti e, trasformata in qualcosa di essenzialmente relativo alla percezione sensibile di ognuno, perde il proprio carattere di assoluta oggettività. Di tale mutamento è emblematico il pensiero di Protagora, non solo ciò che piace e appare bello a qualcuno può non piacere e sembrare brutto a un altro, ma può anche apparire ora bello e ora brutto a un medesimo soggetto. Si tratta di un modo artificiale, cioè "fatto ad arte", e "fare ed arte" significa per Progatora, come per tutti i sofisti, operare in modo diverso da come opera il mondo naturale. Opera anche secondo determinate regole subordinate consapevolmente alla realizzazione di un fine. Protagora afferma che se alcune arti , come la scultura, la pittura .. , hanno come scopo la realizzazione di oggetti inutili, volti unicamente a suscitare piacere. Questo spostamento di attenzione dal contenuto all'affetto emerge soprattutto in rapporto alla poesia. Protagora non intende riferirsi a ciò che esprimono le parole, bensi al modo con cui sono espresse. Ciò che conta nella poesia non è il contenuto, ma la forma che lo esprime. Separando così forma e contenuto, Protagora conclude che il valore della poesia non dipende dalla "mimesis", bensì dall' "orhotes", ovvero dalla sua intera coerenza tecnico-formale. La poesia diventa in tal modo il luogo di una consapevole finzione, di una cosciente messa in scena dell'illusione e dell'inganno.
Gorgia: il potere magico-incantatorio della poesia
Il linguaggio non rispecchia il significato dell'essere, ma produce questo stesso significato. Non esiste un "logos" oggettivo e immutabile in base al quale è possibile giudicare la correttezza o meno di quanto esprime il linguaggio, il quale ha la capacità di agire sull'anima, orientandone i pensieri e le azioni, perché fa appello a quanto nell'uomo è più lontano dalla ragione, le passioni. "Poliesis" cioè produzione. Il potere seduttivo della poesia viene definito da Gorgia un "errore per l'anima". Ma si tratta di un errore che per l'anima rappresenta il nascere di una nuova vita, fatta non solo di emozioni mai provate prima, ma anche di sentimenti e passioni rinnovate, che nessuna cosa reale sarebbe stata capace di suscitare con tale intensità: Gorgia le attribuisce il potere psicagogico che i pitagorici avevano attribuito alla musica, svuotandolo tuttavia di ogni funzione di carattere etico e pedagogico. Le parole sono come i farmaci, hanno il potere di modificare gli stati d'animo, possono curare oppure avvelenare l'animo, fino al punto da infondervi una malvagia persuasione e spingere l'uomo a fare cose che sono causa della sua rovina. Se tale è la poesia in quanto arte, tali saranno anche la pittura e la scultura, tecniche dell'effetto e della simulazione. L'artista rivela al massimo grado l'aspetto propriamente demiurgico dall'essere umano, cioè quella divina forza plasmatrice che gli uomini possiedono da quando Prometeo ha donato loro il fuoco e la tecnica rubati agli dèi.
Democrito: relativismo estetico e illusionismo artistico
Una concezione simile a quella dei sofisti si ritrova in Democrito. Secondo Democrito i principi ultimi della realtà devono essere identificati "atomi", cioè "non divisibile". Le cose sono combinazioni di atomi che, venendo a contatto con gli atomo di cui è formato il corpo umano, generano le sensazioni e i sentimenti a esse legati. Ne consegue che le sensazioni sono il frutto di un'interazione tra soggetto e oggetto e, come tali, ci fanno conoscere non ciò che sono realmente le cose ma come esse ci appaiono. Le sensazioni sono soggettive e tali saranno anche i sentimenti a esse legati. Ne consegue che il bello, dipendendo dal sentimento, perdono la propria valenza oggettiva. In parallelo a questa idea relativistica del bello, Democrito sviluppa una concezione illusionistica ed edonistica delle arti figurative e musive che lo affianca ai sofisti, anche se si distingue da essi in rapporto alla propria visione dell'arte in generale. Una volta stabilito che l'arte si è costituita come "mimesis" produttiva al fine di sopperire alle mancanze naturali dell'uomo, Democrito sostiene che essa si divide in necessaria e superflua. Alcune arti, come ad esempio la musica, la poesia e la danza, sono sorte non dalla mancanza ma dalla sovrabbondanza, cioè quando l'uomo, ormai raggiungo un certo agio materiale, ha iniziato a sentire il bisogno di svagarsi: "Democrito afferma che la musica è più recente (delle altre arti) è nata quando già esisteva il superfluo". La mousike è nata per divertire e ha un valore puramente edonistico. Tale affetto mimesis così perfetta della natura da perdere ogni carattere artificiale e presentarsi come reale. E' su questa ingannevole apparenza di realtà che essa fonda il proprio potere di attirare l'attenzione del fruitore e di generare in lui non solo piacere, ma anche divertimento. In virtù di questa capacità illusionistica, Democrito attribuisce all'arte una sorta di potere magico. Presuppone nell'artista un potere irriducibile di un sapere tecnico, dono naturale dell'artista.
Platone: il bello come splendore del vero e l'ambiguità della mimesis
Il bello come idea
Il tema socratico del bello ideale viene ripreso da Platone per essere sviluppato nel senso di una forma intelligibile o eidos (idea). Tale forma o idea non deve essere intesa come un semplice contenuto mentale o concetto, ma come una realtà che risiede in un mondo trascendente, viene definito da Platone con il termine "Iperuranio". Necessario pensare che l'idea del bello sia una conoscenza innata presente in noi fin dalla nascita. Secondo il mito platonico proposto nel Fedro, l'anima è immortale e, prima di incarnarsi in un corpo, viveva nell'Iperuranio dove, seguendo i carri degli dei, aveva potuto contemplare il mondo delle idee, compresa quella del bello. Definita come luce, l'idea del bello, pur essendo distinta dalle altre idee, non è separata da esse, qualificandosi come splendore del Vero e del Bene. Il mondo sensibile, pur rappresentando lo stato di smemoratezza dell'anima, è anche l'occasione perché essa possa ridestarsi da questa condizione di oblio. E'