Didattica Nova: integrazione tecnologie digitali nell'educazione
Documento da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su Didattica Nova: Paola Lisimberti, Stefano Moriggi. Il Pdf esplora l'applicazione delle tecnologie digitali nell'apprendimento, con focus su didattica innovativa e collaborativa, comunicazione in classe e uso dei social network per percorsi di apprendimento.
See more25 Pages
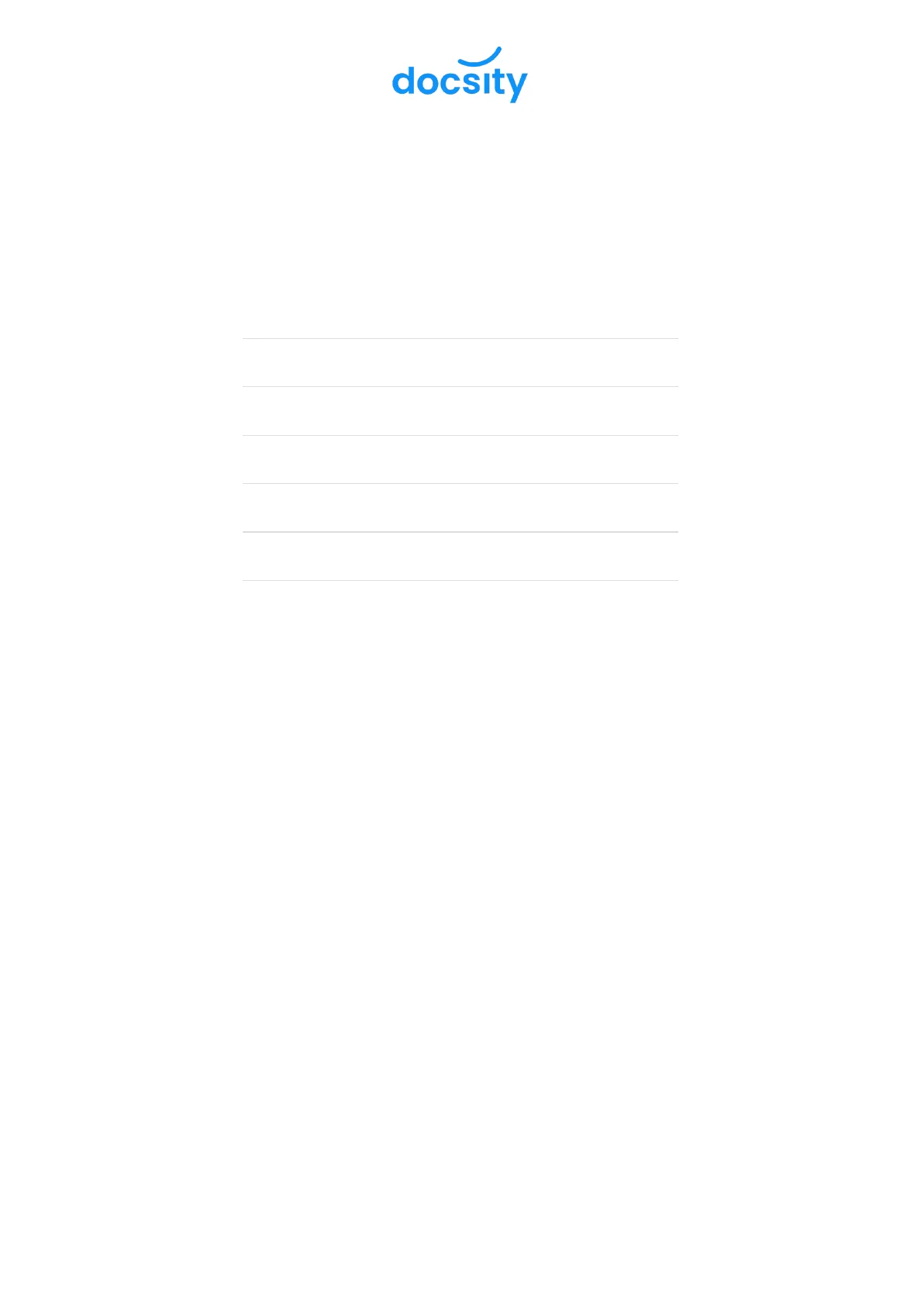
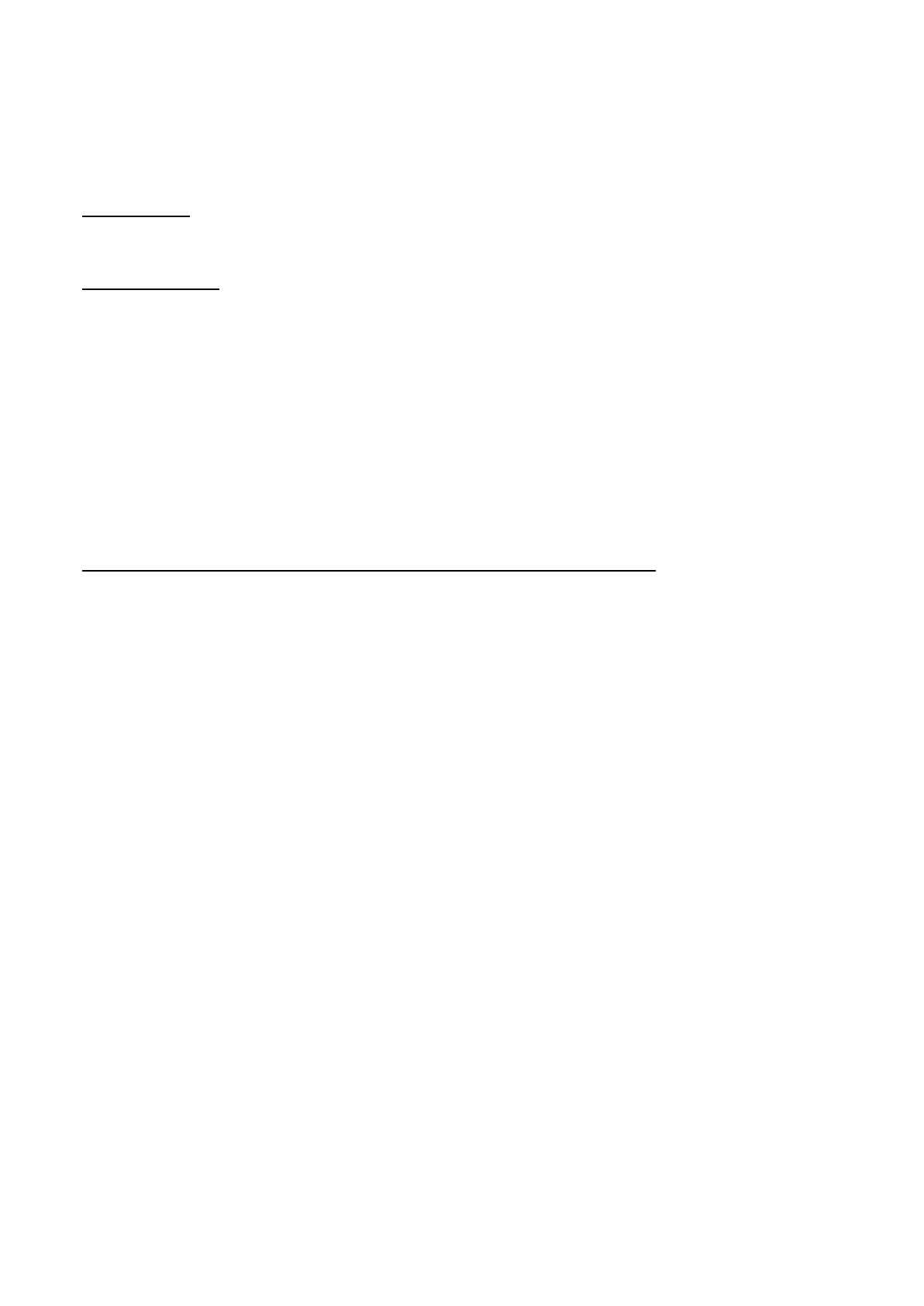
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
Preview
docsity
Didattica Nova: Paola Lisimberti, Stefano Moriggi Pedagogia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) 24 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/didattica-nova-paola-lisimberti-stefano-moriggi/7509900/ Downloaded by: stefano-figus-3 (340262@studenti.unimore.it)
DIDATTICA NOVA
Lo "spazio-tempo" dell'apprendimento digitalmente aumentato Paola Lisimberti, Stefano Moriggi
Introduzione: L'urgenza, l'emergenza e il cronotopo
Capitolo 1
Oltre la distanza Stefano Moriggi
- Prologo. Esserci o non esserci: questo è il problema?
- A ritroso, verso il futuro ...
2.1 Come pensare (con) le tecnologie
2.2 Gestire (cooperativamente) la propria ignoranza
- Verso un'ecologia del digitale
3.1 Come pesci fuor d'acqua: un esercizio di consapevolezza mediale
3.2 Non ci sono più i fatti di una volta ... Good bye, Mr. Gradgrind!
- Epilogo. Leggere Playboy per scassinare il presente (dell'aula)
Capitolo 2
Progettare percorsi di apprendimento per il cittadino del XXI secolo Paola Lisimberti Premessa
- Una didattica nova per una classe dinamica e collaborativa
1.1 La classe è finita nella rete
1.2 Costruire la comunicazione con la classe
1.3 A scuola di social
1.4 Aule virtuali
1.5 "Smart Labyrinth": un esempio di aula virtuale progettuale
1.5.1 Creazione dei gruppi di lavoro in aula virtuale
1.5.2 Il diario di bordo
1.6 Nel forum si impara a fare domande
- Per un apprendimento senza limiti di spazio e di tempo
2.1 La lezione sostenibile e accogliente
2.2 Studenti ricercatori: la Classe di Bayes
2.2.1 Realizzare un fotolibro
2.2.2 Prima fase: tool box
2.2.3 Seconda fase: problem solving cooperativo
2.2.4 Terza fase: situation room
2.3 La voce dell'insegnante: fare didattica per le STEM con un podcast
2.4 Il social reading
- La cultura digitale come habitus mentale
3.1 Aprite il libro a pagina
Conclusione Document shared on https://www.docsity.com/it/didattica-nova-paola-lisimberti-stefano-moriggi/7509900/ Downloaded by: stefano-figus-3 (340262@studenti.unimore.it)
Introduzione
L'urgenza, l'emergenza e il cronotopo
Il Coronavirus ha trasformato in urgenza ciò che già da tempo era un'emergenza. Nel senso che la necessità di mettere radicalmente in discussione una tradizione didattica ormai clamorosamente scollata dalla realtà di un mondo extra-scolastico in continua e rapida evoluzione era emersa in tutta la sua evidenza da qualche decennio. Siamo piuttosto convinti che la scuola sia ormai giunta a un bivio epocale. Le opzioni sono due: • il fronte di chi sostiene che la scuola possa sopravvivere nella sua funzione (solo) rimanendo uguale a se stessa, a prescindere da ciò che accade al di fuori del suo perimetro fisico; • quello di chi pensa che la scuola debba piuttosto farsi contaminare dal mondo entro cui vuole continuare a svolgere un ruolo pedagogicamente incisivo e culturalmente significativo. - > evoluzione. Siamo convinti che la pervasività del digitale vada vissuta e concettualizzata come una discontinuità culturale e in quanto tale occorra affrontarla, fuori e dentro la scuola. E il buon senso in questi casi può rivelarsi più un ostacolo che uno strumento per individuare effettivi rischi e potenziali opportunità. L'evoluzione tecnologica nei secoli ha agevolato diverse modalità di produzione di conoscenza e differenti pratiche di accesso al sapere e di condivisione di dati e informazioni. Prenderne atto significa iniziare a far davvero i conti con l'emergenza (culturale) innescata dalla diffusione del digitale. E siccome lo spaesamento è lo stato d'animo tipico di chi si trova a vivere (a insegnare o ad apprendere) nel mezzo di una transizione tecnologica e culturale, ci è parso opportuno avviare un ragionamento su come stanno cambiando lo spazio e il tempo dell'apprendimento. Più precisamente abbiamo preferito parlare di "spazio-tempo". Abbiamo ritenuto opportuno illustrare plausibili variazioni sul tema della scena didattica digitalmente aumentata, in primis analizzando lo spazio-tempo che le sottende -> indicando esempi concreti di strategie metodologiche coerenti e compatibili a tali contesti di apprendimento. Questa prospettiva dovrebbe inoltre favorire un approccio eco-logico alle tecnologie -> evidenziare come la nostra interazione con strumenti e dispositivi sempre più performanti e interattivi abbia prodotto specifici ecosistemi culturali di cui noi e i nostri simili siamo stati al contempo gli artefici e i prodotti. Rendersi consapevoli della "casa" che abitiamo è una delle premesse teoriche fondamentali per passare all'azione (didattica) con efficacia.
Oltre la distanza Stefano Moriggi
1. Prologo. Esserci o non esserci: questo è il problema?
Si può notare come la possibilità di garantire una qualche continuità alla didattica solo mediante le tecnologie digitali si sia rivelata per molti una insperata opportunità per ribadire l'inderogabilità dell'esserci fisico nell'(inter)azione pedagogica. Document shared on https://www.docsity.com/it/didattica-nova-paola-lisimberti-stefano-moriggi/7509900/ Downloaded by: stefano-figus-3 (340262@studenti.unimore.it)Per alcuni tale radicale forzato stravolgimento delle consuetudini didattiche ha rappresentato il pretesto storico e teorico per individuare la minaccia tecnologica del «remoto» alla scuola «tradizionale» della «presenza». Bisognerebbe intuire le reali potenzialità e gli effettivi limiti entro cui anche la stessa urgenza potrebbe essere diversamente gestita. Dopotutto, la diffusa abitudine a ripetere nei contesti virtuali il modello della lezione frontale "tradizionalmente" agito nell'aula fisica è solo uno dei corto circuiti culturali prodotti dalla riduzione delle tecnologie digitali a "tele dispositivi" (per altro lascia intendere che il digitale sulla scena dell'apprendimento abbia avuto una funzione pressoché ornamentale, e ben lontana dal rappresentare un reale e concreto arricchimento della didattica). Rapporto tra tecnologie e apprendimento non è contrapposizione tra "a distanza" (digitale) e "presenza" (fisica). Esserci o non esserci (in aula) ... Questo parrebbe il (solo) problema. Sarà necessario ridefinire e rinegoziare il senso e il significato del nostro stare, insieme, nel mondo (e dunque anche a scuola). Non si prende ancora sufficientemente sul serio il fatto che le discontinuità introdotte nelle nostre pratiche quotidiane dall'innovazione tecnologica costituiscono questioni culturali a pieno titolo. Come rendersene conto? - > Munirsi di attrezzi ... Quali? Le parole. Chi sarebbe disposto ad ammettere che la propria socialità coincide esclusivamente con l'orizzonte di esperienze possibili in presenza (fisica)? I "mezzi di comunicazione" non hanno forse contribuito a ridisegnare nel tempo e nello spazio (e a distanze variabili) il nostro modo di essere, aristotelicamente, animali sociali? Allora, forse, il termine "a distanza" non andrebbe così nettamente contrapposto al termine "presenza". E, d'altra parte, si potrebbe provare a declinare il termine presenza al plurale, specificando le modalità con cui siamo in grado di esserci (senza per questo mai pensare di sostituire la fisicità propria delle interazioni personali in presenza). Perciò riteniamo che lo "spazio-tempo" della socialità umana andrebbe piuttosto indagato, compreso, descritto ed eventualmente progettato approfondendo le modalità con cui strumenti e dispositivi tecnologici hanno consentito (e consentiranno) di imbastire relazioni e comunicazioni in grado di arricchire l'esperienza di condivisione simultanea di uno spazio fisico.
2. A ritroso, verso il futuro ...
2.1 Come pensare (con) le tecnologie
Svincolarsi linguisticamente e concettualmente dall'infondata dicotomia tra presenza (fisica) e distanza (digitale), aiuta a cogliere più nitidamente come l'Homo sapiens si sia culturalmente evoluto anche ridisegnando tecnologicamente relazioni e interazioni in cui la presenza fisica costituiva solo una delle possibili modalità dell'esserci. "Pensare la distanza significa porsi in una prospettiva privilegiata per iniziare a pensare (con) le tecnologie". Qui si propone di considerare l'evoluzione delle pratiche di apprendimento monitorando la gestione Document shared on https://www.docsity.com/it/didattica-nova-paola-lisimberti-stefano-moriggi/7509900/ Downloaded by: stefano-figus-3 (340262@studenti.unimore.it)tecnologica (e dunque culturale) della distanza fisica e intuendo tra le pieghe di tali vicissitudini storiche l'implicito progetto di una idea di socialità, modulata su diverse declinazioni dello stesso concetto di presenza. Ecco alcuni fatti e vicende indispensabili per dar conto della complessità dello scenario attuale (riando voce ad autentici pionieri delle reti digitali): Scrivevano Joseph Carl Robnett Licklider e Robert W. Taylor in un articolo(1968) «In pochi anni gli esseri umani saranno in grado di comunicare in modo più efficace mediante una macchina che non faccia a faccia. Questa è una cosa piuttosto sorprendente da dire, ma è la nostra conclusione». «Ma comunicare è qualcosa di più che inviare e ricevere, noi crediamo che i comunicatori debbano fare qualcosa di non banale con le informazioni che inviano e ricevono». «Stiamo entrando in un'era tecnologica in cui saremo in grado di interagire con la ricchezza delle informazioni dal vivo, e non solo nel modo passivo in cui ci siamo abituati a usare libri e biblioteche. Ma come partecipanti attivi di un processo in corso, portando un contributo mediante la nostra interazione, e non semplicemente ricevendone qualcosa dalla nostra connessione». > Hanno inaugurato una modalità di esserci (a prescindere dalla presenza fisica) più attiva e partecipata. Timothy John Berners-Lee (informatico al CERN Conseil Européen puor la Recherche Nucléaire) di Ginevra, il co inventore insieme a Robert Cailliau del World Wide Web descriveva il ragionamento che, nel settembre del 1984, lo guidò nella sua impresa informatica: «Sono sempre stato interessato a studiare la maniera in cui si collabora tra persone. [ ... ] Se si stava in un'aula, si scriveva su una lavagna. lo cercavo un sistema che permettesse a tutti di confrontarsi e tenere sotto controllo la memoria istituzionale del progetto». riflettere sul nesso (epistemologico) sarebbe un ulteriore passo per comprendere come la comunità scientifica abbia sempre e di nuovo cercato di "aumentare" tecnologicamente il potenziale cooperativo di un'impresa collettiva a prescindere dalla distanza o dalla presenza dei singoli ricercatori. Tornare a riscoprire il ruolo maieutico del confronto dialettico consentito da un progetto comune e collaborativo come quello della ricerca, potrebbe rappresentare un riorientamento gestaltico (ovvero un cambio di paradigma) necessario proprio per ridefinire limiti e potenzialità del digitale sulla scena dell'apprendimento.
2.2 Gestire (cooperativamente) la propria ignoranza
Aggiungere qualche ulteriore dettaglio utile a ricostruire il processo ideativo che ha condotto Tim Berners-Lee alla realizzazione di WWW consentirà: 1. di recuperare le premesse culturali da cui il World Wide Web è derivato; 2. di intuire più nitidamente le condizioni ambientali e gli approcci metodologici mediante cui arricchire digitalmente l'esperienza di apprendimento su basi epistemologicamente fondate. Document shared on https://www.docsity.com/it/didattica-nova-paola-lisimberti-stefano-moriggi/7509900/ Downloaded by: stefano-figus-3 (340262@studenti.unimore.it)